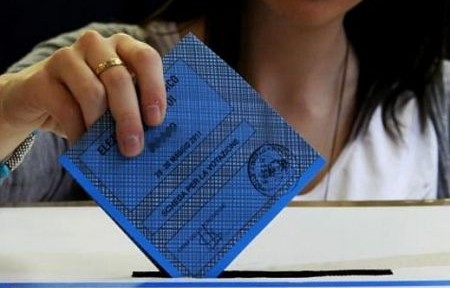In punta di diritto, le leggi elettorali dovrebbero essere neutrali, cioè non essere confezionate per chi detiene il potere o per l’opposizione che spera di conquistarlo. In via di fatto, nell’Italia dei contrasti storici, della Babele delle lingue politiche e delle burocrazie di partito che fanno e disfano governi, istituzioni, partiti e amicizie, le leggi elettorali sono strumenti che troppi adottano per convenienza specifica, infischiandosene della sovranità popolare. Come nel caso, non marginale, delle preferenze, unica arma rimasta nelle mani del singolo elettore.
Si dimentica che il suffragio universale per un settantennio non è esistito nell’Italia regia. Nella quale i primi iscritti del 1848 (come quelli dei «plebisciti» che annessero popoli numerosi al dozzinante Piemonte) ammontarono a meno del 2 per cento della popolazione. Quel suffragio s’impose soltanto nel 1919; quando popolari e socialisti, fra loro divisi, riuscirono ad ottenere che si votasse non per censo ma per cittadinanza. Il suffragio fu in verità semiuniversale, poiché, salvo i cattolici di Sturzo, tutti gli altri partiti respinsero l’idea di portare alle urne le donne: come se esse fossero sprovvedute e incapaci di discernere e scegliere politicamente. Però quel voto fece comprendere al colto e all’inclita che lo strumento elettorale non fosse una concessione del re ma un diritto del popolo.
Prima che si giungesse, dopo vent’anni di autoritarismo, al voto del 1946 (allorché la democristiana Angela Guidi riuscì a far concedere il voto alle donne, una conquista storica), i partiti si scontrarono: sia sulla proporzionale che sulle preferenze. Quasi tutte le formazioni, di destra come di sinistra, si tenevano caro il sistema uninominale dello Stato liberale, immaginando che i collegi fossero affidati ai capiclan locali, mentre le preferenze (specie per l’aggregazione dell’elemento femminile) servissero solo a favorire i democristiani, a ragione della suggestione che i parroci si riteneva potessero esercitare sulle donne. Se si andassero a rileggere le collezioni dell’«Avanti!», dell’«Unità», del «Risorgi¬mento Liberale», dell’«Opinione», de «La Nuova Europa» e via discorrendo, si accerterebbe che, «lungi dall’essere democratici», i partiti di massa di sinistra e quelli d’opinione di destra erano contrari sia alla proporzionale che alle preferenze, ritenendole sconvolgenti le vecchie regole di un prefascismo che non aveva retto all’iniziale poco numeroso assalto mussoliniano.
Chi pretende testimonianze più recenti, non dovrebbe incontrare difficoltà a comprendere come, Mani Pulite a parte (né equanime, né democratica), l’impazzimento referendario sulla preferenza unica, dovuto all’uninominalista Mario Segni, risultò determinante nella liquidazione della Prima Repubblica ed il sopravvento della Seconda, ora palesemente in agonia irreversibile. La preferenza unica scompigliò le abitudini italiane di tutti i partiti, che dal 1946 avevano collegato il sistema delle preferenze plurime per: ottenere il minimo di dispersione dei voti; riconoscere le diversità politiche e territoriali interne a circoscrizioni elettorali troppo ampie e disuguali quanto a numero di iscritti nelle liste; e fornire la possibilità a partiti plurali (tutti, salvo il Pci) di collegamenti fra correnti e personalità di varie province così da ridurre al minimo esclusioni dal parlamento di candidati rappresentativi di realtà sociali differenziate nei medesimi territori di attività. Il Pci, da sempre uninominalista, dal 1946 accettò la preferenza plurima per consentire tendenzialmente ad ogni federazione provinciale di controllare se la base rispettasse le disposizioni di votare i singoli candidati designati dalle singole burocrazie locali ma in definitiva prescelti dal vertice nazionale in relazione alla loro anzianità di militanza, alla fedeltà all’ortodossia stalinista-togliattiana, alla elezione di tutto il tradizionale personale dirigente del partito. Tale sistema, accolto anche dalle destre postliberali, si accompagnava al ricorso al collegio unico nazionale, inventato per evitare che personalità illustri ma poco presenti nelle cronache giornalistiche fossero escluse dalle camere perché mancanti di clientele generose.
La preferenza plurima fu voluta dalla Dc per consentire l’elezione di candidati meno noti nelle singole circoscrizioni ma più rappresentativi delle tendenze in cui si articolava quel partito con più anime e permettere alle stesse minoranze di trovarsi eletti propri rappresentanti anche se in dissenso coi vertici nazionali. Il suffragio risultò, dunque, veramente universale: 1) con il voto alle donne; 2) con la preferenza plurima. E per quasi cinquant’anni il sistema elettorale funzionò in modo da garantire il cosiddetto «diritto di tribuna» anche alle formazioni più piccole ma pur esse aventi diritto ad una presenza in parlamento.
Con la preferenza unica, accusata di essere fomite di corruzione e di frammentazione ritenuta intrinseca alla proporzionale, sappiamo tutti che il sistema elettorale non è stato più neutro; ma è servito essenzialmente a selezionare preventivamente i candidati più graditi alle ristrettissime oligarchie padrone dei vertici nazionali di tutti i partiti, nessuno escluso. Sino allo scandalo del porcellum, che ha introdotto il metodo che assicura la scelta di nominati dall’alto con totale esclusione del principio stesso di sovranità popolare, tutt’al più riconosciuto come mero strumento di ratifica delle decisioni dei vertici di partito, dei satrapi della distribuzione del potere, diventati padroni di tutte le consultazioni politiche. Sino all’ultimo prodotto dei governi nominati fuori dal parlamento e con criteri di selezione inattinenti alla volontà popolare.
Il ripristino della legalità costituzionale potrebbe trovare attuazione con il recupero della preferenza plurima all’interno di circoscrizioni più piccole e con selezione preventiva di organi locali che decidano non in ragione della fedeltà dei candidati al capataz nazionale, ma per un minimo di adeguatezza a capire e suggerire progetti differenziati e alleanze non assembleatrici di opportunisti, bensì finalizzate ad assicurare stabilità alle istituzioni. Solo in tal modo le preferenze ridarebbero un senso alla sovranità popolare.