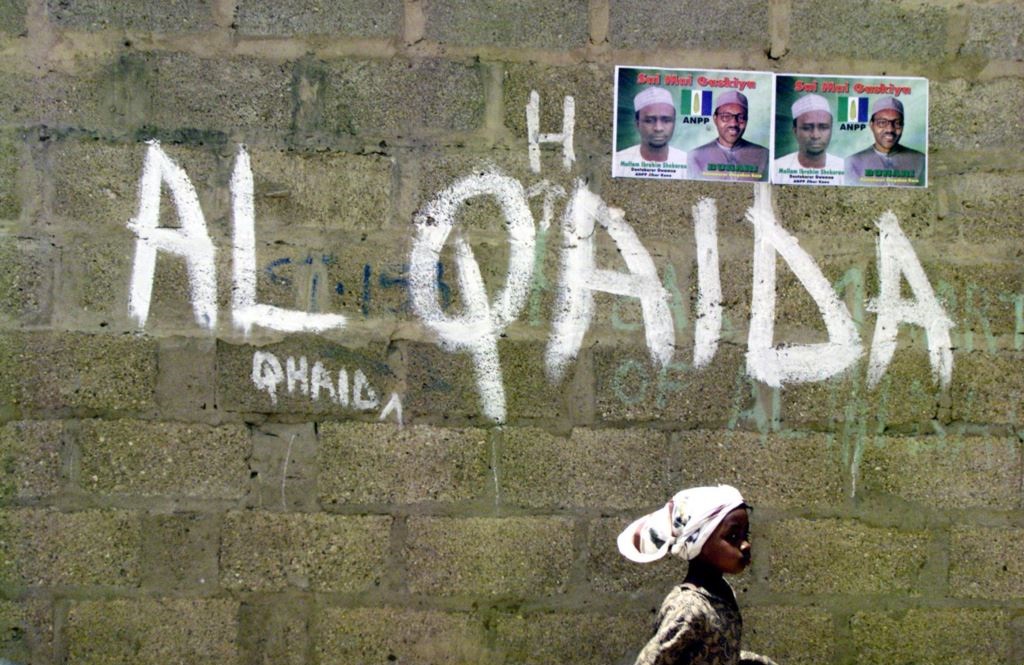L’operazione Mare nostrum è stata varata il 22 ottobre 2013 e in un anno di operatività ha permesso di soccorrere 101mila migranti. L’operazione è stata criticata da più parti in quanto costituirebbe un pull factor, ma a fronte di queste critiche vi è stato anche un diffuso consenso, specialmente nei Paesi di provenienza dei flussi migratori e presso le varie Organizzazioni internazionali che si occupano di migrazioni. Siamo ora nella fase di uscita da Mare nostrum e si può certamente considerare un successo aver ottenuto dall’Ue una sostanziale condivisione di questo sforzo italiano portato avanti per un anno. L’operazione europea Triton subentra a Mare nostrum, sancendo però il passaggio da una gestione “umanitaria” della frontiera marittima meridionale dell’Ue ad una prevalentemente “securitaria”. Sembra quindi che siamo tornati alla casella iniziale, in un contesto in cui non possiamo che attenderci una ripresa dei flussi migratori incontrollati che hanno caratterizzato questo 2014. L’onere di combattere questo fenomeno spetta all’Europa tutta, ma l’Italia si considera in prima linea. La posizione del nostro Paese è particolarmente critica anche per motivi geopolitici. Il principale Paese di transito dei flussi migratori diretti verso le nostre coste è infatti la Libia. In considerazione della situazione politica interna, con Tripoli non si può collaborare per la gestione dei flussi migratori; né si possono “respingere” i migranti sulle coste libiche, visto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha solennemente censurato tale prassi. Che fare allora?
Il ministero degli Esteri ha ritenuto di utilizzare la presidenza dell’Ue per varare una strategia alternativa. Non più solo sicurezza, non ancora cooperazione con Tripoli, vista la situazione sul terreno, ma rilancio della cooperazione con i Paesi dell’Africa orientale intorno alla Libia, e in particolare con quelli dai quali proviene la maggioranza dei flussi migratori (essenzialmente i Paesi del Corno d’Africa: dal 1 gennaio al 30 novembre 2014 sono sbarcati in Italia 34.189 eritrei e 5.531 somali, che insieme rappresentano il 24% dei migranti irregolari sbarcati). Per l’appunto, mancava un foro di dialogo fra l’Ue e tale regione (esiste un simile “esercizio” per l’Africa occidentale, chiamato Processo di Rabat); inoltre, si tratta di Paesi con i quali l’Italia vanta relazioni storiche ben consolidate.
È quindi venuto quasi naturale proporre ai nostri partner Ue e alla Commissione di avviare un dialogo migratorio con i Paesi del Corno d’Africa. L’impresa non è stata facile. Si tratta di una regione percorsa da fratture di varia natura, che hanno portato anche a conflitti armati e a lunghe crisi, alcune de le quali ancora irrisolte. Molti erano scettici quindi sulla possibilità di “mettere intorno a un tavolo” tutti i Paesi del Corno d’Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia e Kenya), insieme poi a quelli mediterranei di transito (Libia, Egitto e Tunisia). Per preparare questa iniziativa di dialogo, il vice-ministro Pistelli ha compiuto una missione in Africa orientale a luglio, che si è rivelata essenziale per acquisire il consenso a livello politico sull’iniziativa. Questo ha permesso di bruciare le tappe e di convocare verso la fine della presidenza italiana (28 novembre scorso) una conferenza ministeriale di lancio di quello che si è deciso di chiamare il Processo di Khartum (formalmente: “Eu-Horn of Africa migration route initiative”). Durante la conferenza, presieduta dai ministri Gentiloni e Alfano, alla presenza del viceministro Pistelli e del sottosegretario Manzione, è stato approvato il testo di una “Dichiarazione politica”, che traccia le linee essenziali del Processo di Khartum: collaborazione migratoria fra Ue, Paesi del Corno d’Africa e Paesi di transito mediterranei, focalizzata sulla lotta al traffico degli esseri umani e alla migrazione irregolare, ma suscettibile di espandersi in futuro ad altri settori (migrazione legale, migrazione e sviluppo, protezione internazionale).
Il testo della Dichiarazione, che pure è il risultato di lunghi e complessi negoziati fra europei e africani, non è – nell’ottica italiana – che un inizio. Lo scopo di questo nuovo esercizio è realizzare progetti concreti di gestione delle migrazioni nei Paesi di transito e origine. Il commissario Avramopuolos ha annunciato di aver già stanziato 5 milioni di euro per il 2015 sui fondi per la cooperazione allo sviluppo e un milione sui fondi destinati alla cooperazione nel settore della sicurezza. I fondi stanziati sono un buon inizio, ma occorre uno sforzo anche da parte degli Stati europei partecipanti. La Germania è stato il primo Paese a capire questa esigenza, e il ministro Steinmeier è venuto a Roma non solo per “marcare” l’interesse del suo Paese per il Processo di Khartum, ma anche per gettare le basi, con il ministro Gentiloni, di un piano d’azione bilaterale destinato a realizzare progetti concreti che diano immediata attuazione a questa nuova iniziativa italiana. Le azioni che si intende realizzare nell’ambito del Processo di Khartum, in una prima fase, riguardano la lotta ai network criminali che organizzano la tratta degli esseri umani, la formazione della polizia di frontiera, campagne di informazioni sui rischi della migrazione irregolare, il rafforzamento dei centri di accoglienza per migranti che nella regione sono gestiti da Unhcr e dall’Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim). In un secondo tempo, se tutti gli Stati partecipanti al Processo di Khartum lo vorranno, si aggiungeranno azioni di sviluppo nella regione e progetti di migrazione legale.
Lo scopo è di trovare alternative alla migrazione irregolare, che comporta tanti rischi, tramite la creazione di canali regolari di immigrazione, ma anche favorendo lo sviluppo in loco, al fine di limitare la necessità di lasciare il proprio Paese. Ben inteso, non si tratta di impedire di partire a chi lo desidera. Tanti fuggono da dittature o situazioni di crisi e la loro richiesta di accoglienza in Europa corrisponde a precisi obblighi sanciti dal diritto internazionale. Non significa neanche di impedire la migrazione per motivi economici, un fenomeno che risponde a precise logiche di carattere economico e sociale in Africa ed Europa.
L’ambizione del Processo di Khartum è semplicemente quella di meglio gestire questi fenomeni, nel rispetto dei diritti umani: non è poco, e non sarà possibile conseguire risultati tangibili in breve tempo. Ma bisognava pur cominciare.