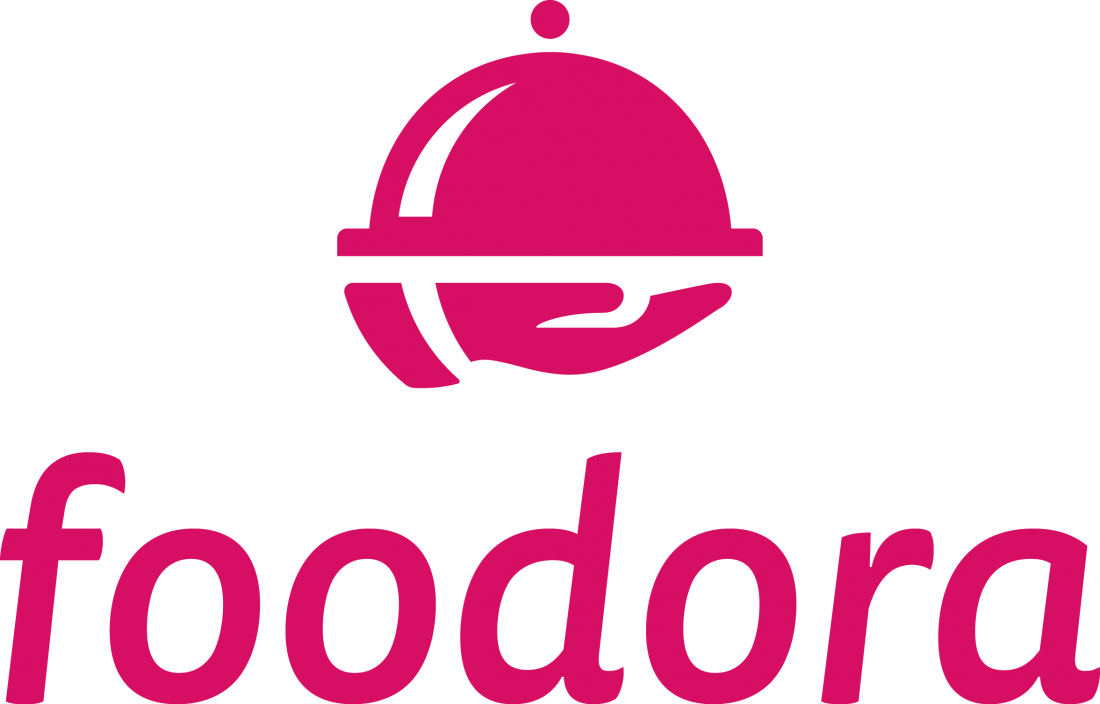Anche in Italia si comincia a parlare di gig economy. Merito o colpa: dipende dai punti di vista – del caso Foodora, la start up tedesca nata nel 2014 messa sotto accusa per le paghe troppo basse dei rider, i ragazzi addetti alla consegna dei pasti a bordo delle loro bici.
Foodora è un’azienda di digital takeaway: mette in contatto clienti e ristoratori che aderiscono alla sua piattaforma con un semplice clic della sua app. Pizzerie, ristoranti etnici o tradizionali: tutti on demand, tutti a portata di smartphone. Un’idea cui Foodora ha aggiunto, grazie all’impiego delle due ruote, il tocco della sostenibilità ambientale. I risultati sono arrivati presto: gli ordini crescono del 75% al mese e anche la copertura del servizio (ora siamo a 36 città in 10 paesi) si sta allargando velocemente.
Ci troviamo dunque di fronte ad un business vero, non ad un passatempo per “smanettoni”. Nulla di male, se non fosse che a Torino, epicentro della protesta, Foodora ha portato sotto i 3 euro la retribuzione per ogni consegna, mentre in Germania ne sborsa 9. Inoltre il piglio arrogante con cui ha replicato alle rimostranze dei rider (“Foodora non è un lavoro per sbarcare il lunario, ma un’opportunità per chi ama andare in bici, guadagnando anche un piccolo stipendio”, questa sulle prime la reazione dei vertici) ha inasprito il contenzioso.
Un po’ di storia, come nasce la sharing economy
Ma chi sono in realtà i lavoratori che hanno sfidato le ire dell’azienda organizzando in proprio la protesta? Negli Stati Uniti li chiamano gig worker, dal colloquiale gigger, neologismo che in italiano suona come “chi fa il lavoretto”, termine familiare a tanti giovani (e di questi tempi non solo ai giovani) che arrotondano, non di rado in nero, le loro magre entrate.
In realtà Foodora, ma lo stesso discorso vale per le altre piattaforme che offrono lavoretti “gig”, rappresenta il caso più appariscente di quella che sarebbe forse più corretto chiamare economia on demand, a sua volta solo una delle molte derivazioni della sharing economy, l’economia della “condivisione” che abbatte la barriera tra servizi e industria (l’esempio classico è quello del car sharing: il consumatore non acquista la proprietà del veicolo ma un diritto all’uso), un fenomeno con cui abbiamo imparato a familiarizzare negli ultimi anni. Questo nonostante la sua portata rivoluzionaria sia stata intuita molto tempo addietro. Risale al 1978 la prima definizione teorica del “consumo collaborativo”, coniata da Marcus Felson e Joe L. Spaeth nell’articolo “Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach” pubblicato nel American Behavioral Scientist. Un’intuizione ripresa poi anche da Jeremy Rifkin nel saggio “L’era dell’accesso”, nel quale l’economista preconizza il cambiamento del ruolo della proprietà privata e dei sui effetti sulla società.
Quelle analisi erano forse troppo in anticipo sui tempi, ma a rileggerle oggi è difficile negare che i loro autori vedessero lontano. Di certo il ruolo della tecnologia è stato determinante perché l’economia della condivisione lasciasse le pagine dei libri per atterrare tra noi: senza lo sviluppo della rete prima e delle tecnologie abilitanti poi (dai big data al cloud computering…), senza l’enorme diffusione dei device mobili (smartphone e tablet), sarebbe impossibile connettere milioni di persone alle piattaforme digitali che rappresentano l’ossatura della sharing economy.
La gig economy rientra in questo quadro. Tra i leader mondiali del settore Fiverr, una società con base a Tel Aviv, ha fatto dei “lavoretti” il suo marchio. La piattaforma permette di acquistare e vendere prestazioni e servizi a prezzi modestissimi: si parte da 5 euro, Fiverr trattiene il 20% e l’unica forma di garanzia sulla qualità dei servizi acquistati è costituita dalle recensioni degli altri consumatori. E’ il paradiso, o l’inferno se volete, dei freelance.
Ci sono poi app che portano la spesa a domicilio, come Istacart, che fanno consulenze legali, come Upcounsel, o che strizzano l’occhio al gourmet che è in ognuno di noi, come Gnammo, la prima piattaforma italiana dedicata al Social Eating (cuochi on-demand).
Tuttavia la sharing economy non ha una dimensione esclusivamente immateriale. In alcuni casi, come quello del coworking, a venir condiviso è uno spazio fisico, il luogo di lavoro. Gli studi più recenti sullo smart working sostengono che nel 2020 il 75% dei lavori si svolgerà lontano da uffici e fabbriche; di qui il coworking, l’esigenza di avere a disposizione spazi condivisi di lavoro.
Primo di tre approfondimenti a cura di Augusto Bisegna e Carlo D’Onofrio