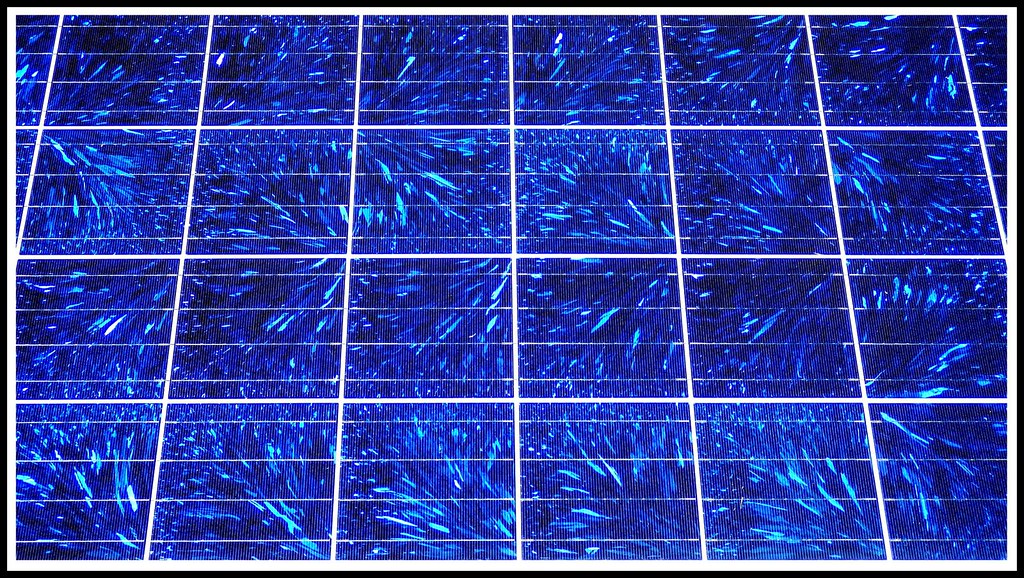L’industria del solare, essenziale per la transizione sostenibile, è quasi interamente dipendente dalla Cina. Gran parte del materiale alla base delle celle fotovoltaiche è prodotto nella regione dello Xinjiang, dove il governo cinese calpesta i diritti umani. Come si coniuga la necessità urgente di celle solari e il rispetto dei diritti umani?
L’energia solare è uno dei metodi più convenienti di produrre energia pulita. I prezzi di un pannello fotovoltaico sono diminuiti più del 75% nell’ultima decade grazie alla ricerca e all’efficientamento della produzione. La vasta adozione a livello europeo, spesso facilitata da incentivi statali, ha fatto sì che il fotovoltaico fosse responsabile per più del 4% dell’energia totale prodotta nell’Ue nel 2020, e gli analisti di Bloomberg credono che la capacità solare globale decuplicherà nei prossimi trent’anni.
La filiera produttiva, però, è altamente problematica. Già nel 2013 l’Ue aveva notato che l’80% delle celle fotovoltaiche era prodotto in Asia, complice la competizione aggressiva della Cina; in quegli anni le tedesche Bosch e Siemens chiudevano le rispettive divisioni solari. Oggi sei delle sette compagnie al mondo che producono pannelli fotovoltaici sono cinesi, e la settima, Canadian Solar, ha una tale presenza nel mercato cinese che sta pensando di quotarsi lì.
Anzitutto le società occidentali non possono competere con i prezzi cinesi, mantenuti artificialmente bassi grazie ai sussidi del Partito-stato. Nell’ottica di incoraggiare l’adozione di questa tecnologia il più possibile, è solo naturale che i pannelli meno costosi vengano privilegiati – anche se questo aumenta la dipendenza tecnologica dalla Cina.
Ma la questione è seriamente aggravata dalla provenienza del polisilicio necessario per fabbricare le celle solari. Secondo Jenny Chase, a capo del distaccamento di analisi solare di BloombergNEF, “quasi ogni modulo solare basato sul silicone – ossia almeno il 95% del mercato – probabilmente contiene del silicone proveniente dallo Xinjiang”. E per l’analista Johannes Bernreuter, sentito da Politico, nel 2020 il 45% della produzione globale di quel tipo di silicone proveniva dalla regione.
Lo Xinjiang, nel nordovest della Cina, è abitata da diverse minoranze etniche, tra cui quella uigura. Negli ultimi anni il governo cinese ha “ospitato” milioni di uiguri – di fede musulmana – in “strutture di addestramento vocazionale” per “garantire un impiego stabile a persone di tutte le etnie”. Pechino giura che non si tratta di lavoro forzato ma non permette che ispettori internazionali visitino i complessi.
E però il crescente numero di rapporti, prove e testimonianze emerse – che raccontano tutt’altra storia, fatta di imprigionamenti, sorveglianza, lavaggio del cervello, violenza, sterilizzazione di massa e tortura – hanno portato Ue, Usa, Gran Bretagna e Canada a sanzionare il regime cinese per violazione di diritti umani in maniera coordinata.
Questi campi di “rieducazione” fungono anche da centri industriali, dove il regime impiega l’immensa forza lavoro per attività come la raccolta del cotone. Come racconta Politico il Dragone manda avanti processi di formazione per aumentare la produzione di beni più complessi, come il polisilicio necessario per i pannelli solari. E data la mancanza di dati accessibili dall’estero, i clienti occidentali che collaborano con le imprese nello Xinjiang devono fidarsi della parola dei loro soci cinesi riguardo alla quantità di lavoro forzato dietro ai loro prodotti.
All’emergere di rapporti – tra cui quello dell’Australian Strategic Policy Institute – sulle filiere produttive dipendenti dal lavoro forzato dello Xinjiang, alcune grandi aziende hanno troncato i rapporti con i loro partner locali. Un ulteriore rapporto di novembre 2020, di Horizon Advisory, ha identificato la predominanza di polisilicio prodotto nello Xinjiang nei prodotti solari esportati dalla Cina, dopo il quale diverse compagnie statunitensi hanno iniziato a investigare le loro filiere a monte.
Rimane il fatto che oggi i Paesi occidentali non possono permettersi il lusso di comprare pannelli solari senza incorrere nel seguente problema etico: la transizione all’energia solare vale la probabilità che i prodotti siano stati realizzati con tecniche di schiavitù moderna? E più urgentemente, data la dipendenza massiccia dal polisilicio dello Xinjiang: come si “ripuliscono” le filiere produttive dal lavoro forzato?
Esistono soluzioni oltre all’esercizio di pressioni, per via commerciale o governativa, sulle controparti cinesi. Secondo Foreign Policy i governi occidentali dovrebbero introdurre tariffe sulle celle solari in base al “lavoro sporco” dietro alla loro realizzazione. Questo renderebbe meno competitivi i prodotti cinesi e potrebbe essere accompagnato da incentivi per le compagnie occidentali, cosicché queste possano investire nel settore, recuperando la statura industriale persa negli ultimi vent’anni.
Alcuni europarlamentari (e il governo tedesco) stanno spingendo per delle leggi che costringerebbero le compagnie europee a dimostrare che le loro filiere di approvvigionamento siano libere da pratiche di lavoro forzato. Guardando più in là, la Commissione europea sta finanziando un progetto, NextBase, per studiare pannelli più efficienti di quelli prodotti in Cina.
A meno di una miracolosa conversione umanitaria del governo cinese, la soluzione a lungo termine può passare solo dal reshoring della produzione di tecnologie strategiche per il futuro. L’energia solare è tra i cavalli su cui sta puntando l’Occidente (specie l’Ue e l’America di Joe Biden) per sostenere la transizione sostenibile e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Ma la strada per un mondo più ecologico non può continuare a passare dalla violazione di diritti umani.