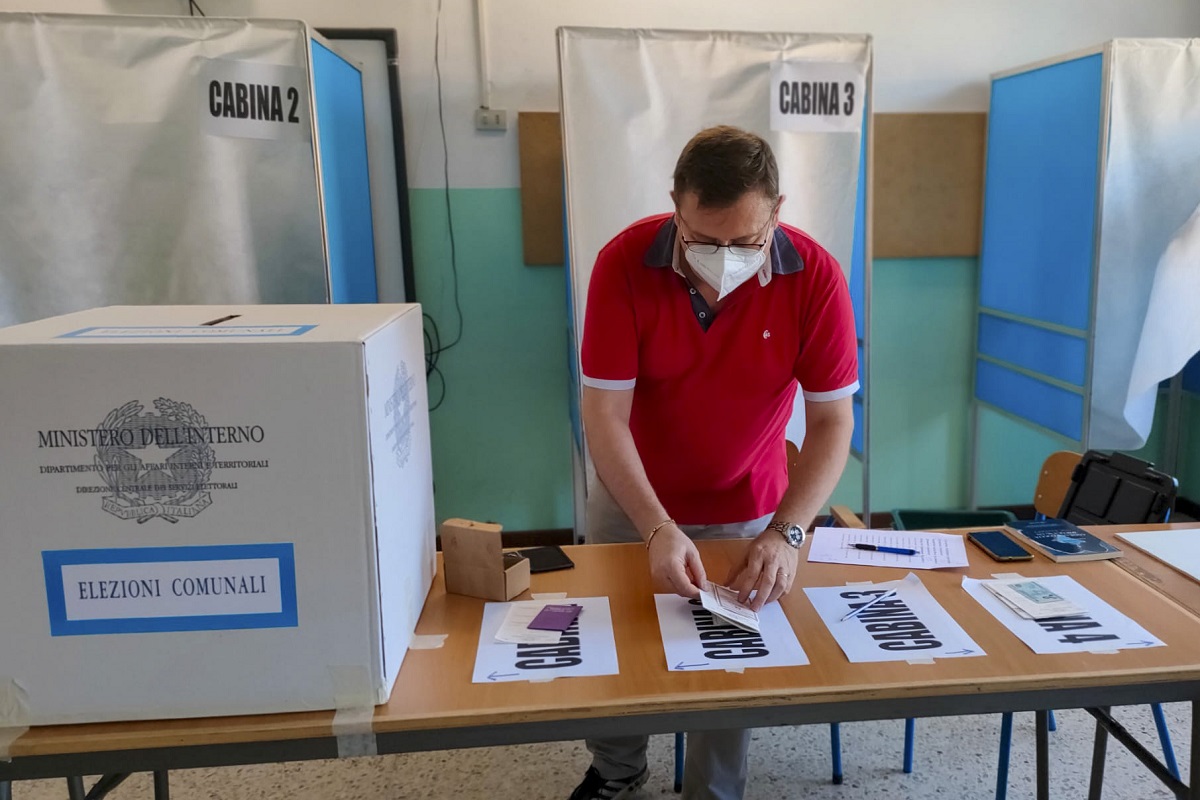La sonora batosta alle amministrative impone una riflessione seria. Ci vuole una Costituente su cui fondare la nuova alleanza. L’intervento di Silvano Moffa
La debacle del centrodestra nei ballottaggi delle amministrative è molto più di un incidente di percorso sulla strada delle politiche. Chi pensa, da quelle parti, di archiviare la sonora sconfitta nelle città più importanti – salvo qualche rara eccezione, come Rieti e Frosinone, dovuta alla qualità dei candidati e al fatto che l’elettorato ha voluto premiare la bontà delle amministrazioni uscenti (per intenderci: Antonio Cicchetti a Rieti e Nicola Ottaviani nel capoluogo ciociaro) o come è accaduto a Genova e Palermo, dove tutto si è risolto nel primo turno – sbaglia di grosso e rischia di consegnarsi a più dolorose e pesanti batoste.
Da qualche tempo, da troppo tempo ormai, su quel versante politico mancano analisi serie e approfondite sulla natura e sulle condizioni di una alleanza che è ormai nulla più che un cartello elettorale costruito sulle sabbie mobili di accordi verticistici. Quando ci si accorda e si mettono da parte rancori e antiche ruggini qualche risultato positivo arriva. Ma quando si alza il tasso di litigiosità a livello locale, si punta su profili di candidati improvvisati e modesti (come è avvenuto, un anno fa, per le comunali di Roma, Milano e Napoli) oppure ci si lascia abbagliare dai sondaggi che premiano ora l’uno ora l’altro leader di partito, in una alternanza che miete consensi in un campo che è sempre più ristretto (la forbice tra chi vota e chi si astiene si è progressivamente allargata) allora le cose vanno male, anzi malissimo.
Rubricare la sconfitta soltanto a questo dato è però ancora insufficiente a spiegare il malessere che, da più di un decennio, ha immerso il centrodestra di berlusconiana memoria in una sorta di mito incapacitante. Dove pure esisterebbero tutte le condizioni per affermarsi e per governare, interviene sempre qualcosa che lo impedisce. Ovviamente, la colpa non può essere ascritta ad un destino cinico e baro, neppure attribuita sempre agli altri. Le cause andrebbero cercate altrove. Ad esempio nella qualità politica della proposta politica che va di pari passo con la qualità politica della classe dirigente (ammesso che da qualche parte ne esista una degna di tal nome) oppure nella scarsa attitudine a interpretare i cambiamenti in atto nel Paese e fuori dai nostri confini, in un mondo sempre più connesso e interdipendente, oppure in quella che acutamente Massimo Franco sul Corriere della Sera definisce una “nuova fase”, dove “non si tratta di dare risposte a vecchie domande, ma di capire che sono cambiate le domande”.
Insomma, si fatica nel centrodestra a comprendere che tutto è cambiato, sono saltati antichi paradigmi, la stessa distinzione destra/sinistra appare superata nella sua antica accezione e, purtroppo, non ripensata e ridefinita in nuovi contenuti e moderni inventari valoriali. Ci sono questioni, temi rilevanti (dall’ambiente alla demografia, dalla crisi del globalismo alle nuove forme del capitalismo, dalla domanda identitaria alla costruzione di un’Europa diversa alla geopolitica alle domande di sicurezza sociale e di futuro delle nuove generazioni, per esempio) che, al massimo, vengono citati per titoli ma mai sviscerati e approfonditi; spesso, addirittura, sono ridotti a slogan e banalizzati nella foga propagandistica, con il risultato di privarli di essenza e di sostanza. Nella superficialità si consuma il delirio di onnipotenza dei leader con febbre da sondaggio.
Ci domandiamo come si possa costruire un progetto politico senza una forte, radicata base culturale. Senza porre mano e testa alla elaborazione di un quadro programmatico che poggi su basi reali e concrete. Come dar vita ad una rassemblement nazionale che prescinda, una volta per tutte, dalla dannosa corsa interna a fare i primi della classe, con alunni sempre più scarsi: le iscrizioni ai partiti sono calate a picco, indice di una crisi che sta diventando irreversibile.
Anni fa, quando nacque il Popolo delle Libertà (Pdl) fu messa in piedi, opportunamente, una commissione di studio con autorità di assoluto rilievo: storici, filosofi, politici, economisti, analisti, giornalisti, uomini e donne di pensiero provenienti da vari filoni culturali e da differenti esperienze politiche, confluiti tutti nel nuovo soggetto politico promosso da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega e Cdu. Avendone fatto parte in rappresentanza di An, mi limito a ricordare soltanto alcuni di quei nomi: Pera, Colletti, Baget Bozzo, Tremonti, Brunetta, Calderoli, Bondi, Adornato, Follini, Malgieri, Buttiglione, Cicchitto, Martino, Urbani. Il compito di quella commissione era di far scaturire proprio dalle diverse culture nazionali, socialiste, liberali e dei cristiano-conservatori una sintesi unificante, un progetto culturale che potesse fornire l’architrave ad un progetto politico unitario. Fu quella una mirabile intuizione, un formidabile punto di partenza che portò, nel 2008, il Pdl ad essere, con il 37,4 per cento, il partito più votato. Quella commissione doveva essere permanente al fine di aggiornare, di volta in volta, il quadro di analisi e quello programmatico del nuovo partito, oltre che per supportare l’iniziativa governativa e l’azione legislativa dei parlamentari del centrodestra. Il guaio fu che, una volta conquistato il governo del Paese, non se ne fece più nulla. Il lavoro di elaborazione si interruppe. Tutto fu affidato alla contingenza del momento. Quella fonte di radicamento e di crescita del nuovo soggetto politico fu lasciata essiccare preferendole il più urgente e pragmatico esercizio del governo. Come se le due cose non potessero viaggiare in parallelo. Non si comprese allora, e non si è compreso ancor oggi, che la vita e la tenuta di un governo si basa soprattutto sulla qualità della proposta politica, corroborata da idee-forza, e sulla costante, incisiva, dialogante, democratica azione dei partiti che ne fanno parte. Di qui la fuga dell’elettorato, l’aumento dell’astensionismo, in una parola: la crisi della democrazia e della rappresentatività di cui il Paese soffre, sia a destra che a sinistra. Nasce da questo vuoto la deriva tecnocratica che ormai sta supplendo, da tempo immemorabile, all’assenza della politica e al deficit di partiti all’altezza del ruolo che pure la Costituzione assegna loro.
Ecco, se dovessimo indicare la ragione principale dei tormenti che agitano il centrodestra odierno lo individueremmo soprattutto nell’abbandono di quella spinta, nell’esaurirsi della attitudine allo studio e alla elaborazione di un progetto comune e unificante, nella caduta di entusiasmo in chi rifugge dalle conventicole dei “lustratori di scarpe”, dei signorsì alla corte dei leader e dei pochi oligarchi che gli girano attorno, semplicemente perché possiede un’indole e un carattere che non si rassegna ad incensare il capo nonostante i suoi errori, sempre e comunque.
Tant’è. I risultati di quella scelta sono sotto gli occhi. Purtroppo, a leggere le note e i commenti rilasciati sul mortificante risultato elettorale nei Comuni, sembra che la lezione non sia servita. Eppure, non ci vorrebbe molto a capire che ci sono almeno tre paradossi da risolvere. Il primo riguarda Forza Italia. Affidarsi al ritorno in campo di Berlusconi per sedare dissidi e ambizioni interne mostra i limiti di un partito che non riesce ad andare oltre la figura dell’ormai vecchio leader che ne incarna, inutile dire, storia e identità, successi e insuccessi. Il secondo paradosso riguarda Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. La smania di primeggiare nella corsa alla leadership del centrodestra a scapito degli alleati e di accreditarsi come volto rassicurante dal profilo coerente, dopo aver solcato il terreno dei sovranisti, venduto l’anima agli ambienti ultraconservatori d’oltreoceano, mantenuto un feeling con i populisti spagnoli di Vox e collegamenti con l’Ungheria di Orban, espone Giorgia Meloni a una miscela tutt’altro che coerente e agli strali ostili che ne ricalcano i tratti di ambiguità.
Ben diversa sarebbe stata la situazione se la scelta conservatrice fosse stata preceduta da una sincera autocritica in merito alle scelte populiste del passato, alla confusa adesione ad istanze sovraniste senza tener conto della radicale differenza che passa tra sovranità e sovranismi, come pure nei riguardi dello stesso approdo neoconservatore, annunciato dalla sera alla mattina senza neppure la parvenza di un dibattitto e di un approfondimento, per esempio, intorno alle acute riflessioni filosofiche di pensatori della portata di Roger Scruton oppure nel merito di quel conservatorismo a più spiccata impronta sociale che emerge dalle Encicliche sociali della Chiesa. L’essere Giorgia Meloni indicata dai sondaggi come leader del primo partito dovrebbe spronarne il destro verso più fondati indirizzi e più solidi contenuti. Infine, la Lega. Il disegno di Salvini di farne un soggetto politico a valenza nazionale è praticamente fallito. Né poteva essere altrimenti dal momento che il concentrato di spinte autonomiste (il federalismo rafforzato a favore del Nord) e di istanze liberiste, a vantaggio delle piccole e medie imprese, non ha fatto i conti con l’idiosincrazia della gente del Mezzogiorno verso ogni forma di colonizzazione e di strumentalizzazione del proprio consenso, da un lato, e con il declino del ceto medio come categoria su cui la Lega di Bossi tradizionalmente era adusa investire, dall’altro lato. Per non parlare della pesca occasionale e di scarsissima qualità del ceto politico scelto per condurre in porto quella missione.
Fin quando non si supereranno questi paradossi, si assisterà all’accentuarsi dei difetti e all’appannamento dei pregi. Per venirne a capo ci vorrebbe la Costituente di un nuovo centro destra. Una Costituente vera, non di facciata. Qualcosa di molto simile a quella commissione del Pdl di quindici anni fa. Nella speranza che ci siano uomini e donne di analogo spessore e con quella visione.