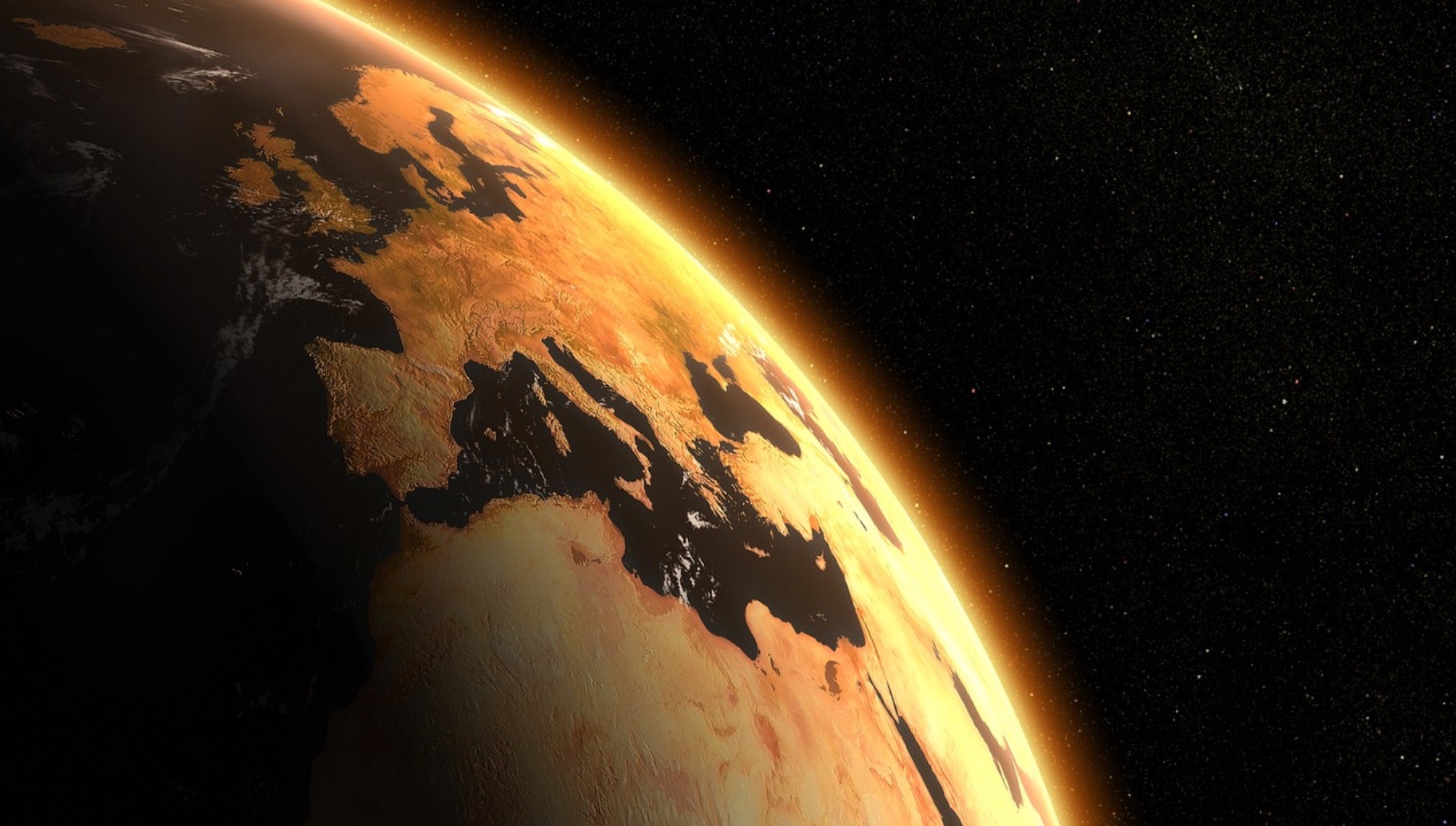In Italia viviamo una dissonanza cognitiva: le forze politiche impegnate nella campagna elettorale sembrano non accorgersi dell’importanza dei cambiamenti climatici. Lo ha ricordato Macron ai suoi ministri, perché sarebbe importante lo riconoscessero anche in Italia. L’intervento di Arvea Marieni
In un discorso ai suoi ministri eccezionalmente trasmesso in televisione il presidente francese Macron ha invitato il governo e la nazione all’ “unità” davanti alla “grande trasformazione” marcata dalla fine “dell’abbondanza”, delle “evidenze” delle nostre abitudini e della “noncuranza”. Decisioni forti aspettano il governo. Soprattutto, Macron dice chiaro che il momento che viviamo non è marcato solo da “crisi gravi” e urgenti. Questo sarebbe normale gestione dei compiti del governo.
Quello che viviamo è diverso ed entra “nell’ordine dei grandi sconvolgimenti”. La parola che usa è bouleversement. La guerra come fatto puntuale, e il cambiamento climatico come elemento strutturale, ne sono i motori.
In Italia viviamo una dissonanza cognitiva.
Mentre alcuni perdono ancora tempo a gracchiare sulle cause del cambiamento climatico, la campagna elettorale è sconnessa dalla realtà. Il cambiamento climatico e i suoi effetti stanno accelerando. E i segni vitali del pianeta, per dirla con la NASA, peggiorano. Mario Draghi ha ricordato a Rimini gli effetti immediati sull’Italia dell’intensificarsi dei “fenomeni avversi”, ma non sembra neanche lui averne colto la dimensione essenzialmente dirompente che mette in discussione tout court lo status quo dei modelli economici attuali.
La siccità dell’estate 2022 è significativa e prolungata in tutto il mondo, dall’Europa alla Cina, agli Stati Uniti e all’Africa, e ha portato con sé gravi effetti a catena sulla produzione di energia, su interi settori industriali e sulla sicurezza alimentare. La siccità, avverte un rapporto ONU, è aumentata del 29% in una generazione. E peggiorerà.
A questo si aggiungono varie crisi ecologiche concomitanti. Mentre i ghiacciai si sciolgono – da quelli dell’Himalaya dipende la vita di oltre un miliardo di persone – l’acqua piovana non è più potabile in nessuna parte del mondo.
La causa sono dei composti chimici industriali, perfluorurati PFOS e PFOA che non si decompongono nell’ambiente mai. L’umanità è “a un bivio” e occorre agire “con urgenza, utilizzando ogni strumento possibile” (ONU). Sono a rischio “i sistemi ecologici da cui dipende la sopravvivenza di ogni forma di vita, compresa la nostra specie”. Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale. Per i militari dei maggiori paesi, minaccia “immediata e diretta” alla sicurezza nazionale.
L’Italia non è messa bene. Il Mediterraneo e i Balcani stanno diventando un hotspot per i cambiamenti climatici.
Proiezioni realizzate con i modelli più avanzati indicano che si verificheranno notevoli cambiamenti nella regione. Dal 2021 in poi assistiamo ad un riscaldamento sostanziale e una diminuzione delle precipitazioni attorno al 5%. Le ondate di calore e gli incendi fanno il resto, con un aumento della desertificazione. La realtà sta persino superando i modelli.
La situazione attuale è già critica. La soglia minima di acqua necessaria per soddisfare il fabbisogno idrico in una regione è 1.700 m³ pro capite/anno. Nel Mediterraneo meridionale (noi) e orientale, 180 milioni di persone vivono in “povertà idrica” con soli 1.000 m³/anno. Di queste, circa 80 milioni sopravvivono in condizioni di grave carenza idrica (500 m³/anno). Una pressione crescente che contribuirà all’instabilità sociale e alle migrazioni di milioni di persone. Memo per la campagna elettorale.
In molte aree del Mediterraneo l’80% dei prelievi di acqua dolce disponibili dipende dall’agricoltura. La maggior parte dell’acqua per irrigare serve in estate, quando la domanda è massima e l’acqua meno.
L’innovazione tecnologica e biotecnologica nelle colture aiuterà, ma non sarà sufficiente. Bisognerà cambiare i modelli di produzione intensivi che impoveriscono il terreno e le risorse idriche in un circolo vizioso. Per questo la UE punta a decarbonizzare l’agricoltura e ridurre l’uso dei fertilizzanti chimici del 30% entro il 2030. Dovrà però anche essere ridotto il consumo di alcune derrate e prodotti.
Lo stesso vale per l’energia. Qualche giorno fa il Presidente di Nomisma, Davide Tabarelli, di certo non un romantico verde, ha riconosciuto che è urgente un piano di risparmio per il gas e l’energia.
Quello che ha dimenticato di dire è che si tratta di misure che devono diventare strutturali. Ma se l’era dell’abbondanza sta per finire, sarà la sobrietà economica a dettare le regole del gioco. Efficienza energetica e delle risorse sono strumenti di resilienza in un mondo che sta cambiando. L’uscita dai fossili ci consegnerà un mondo diverso, più snello ed essenziale.
In Cina un’intensa ondata di calore e siccità nel sud, intorno al bacino del fiume Yangtze sta prosciugando i fiumi. Il livello dell’acqua nelle dighe si abbassa, limitando la produzione di elettricità nelle centrali idroelettriche, proprio mentre la domanda di aria condizionata è in aumento. La siccità pesa anche sulla produzione idroelettica italiana.
Per evitare interruzioni di corrente, le autorità della provincia del Sichuan – che si basa sull’energia idroelettrica per circa l’80% del suo fabbisogno energetico hanno ordinato alle fabbriche di interrompere le attività.
Il contraccolpo sull’economia globale di un rallentamento cinese potrebbe essere molto forte.
Già, perché senza acqua si fermano le centrali. Anche quelle nucleari che hanno bisogno di grandi quantitativi di acqua per i processi di raffreddamento, come succede in Francia, quest’anno costretta ad importare elettricità dai vicini europei per gli stop agli impianti.
Il mondo di oggi è organizzato su un capitale di infrastrutture e capacità produttive che sono il risultato di diversi secoli di accumulo e hanno cicli di vita molto lunghi.
Cambiare questo sistema e al tempo stesso mantenere il più possibile ciò che i combustibili fossili hanno costruito sostituendoli con altre fonti di energia richiede metodo e pianificazione. È lo sforzo del Green Deal europeo. Me lo disse nel corso della nostra prima conversazione Mauro Petriccione, che dalla direzione generale per il clima della Commissione Europea quello sforzo guidava.
Nei paesi europei l’unico modo per avere un piano che sopravviva ai cambiamenti politici è che ci sia un consenso molto forte tra gli elettori e la società civile, che trascenda la persona in carica in quel momento.
Oggi, ad esempio, nessun candidato alle elezioni presidenziali proporrebbe di abolire l’assistenza sanitaria o la sicurezza sociale, perché i francesi vi sono visceralmente legati.
Dobbiamo raggiungere lo stesso livello di consenso per la decarbonizzazione, il che significa che questo piano deve essere forgiato con gli attori che dovranno attuarlo. Tanto più le catastrofi ambientali accadranno, tanto maggiore la presa di coscienza. Una politica responsabile dovrebbe evitare di arrivare fino all’orlo dell’abisso.
“Nonostante i crescenti segnali di speranza, non c’è dubbio che la strada da percorrere sia irta di difficoltà, poiché stiamo costruendo qualcosa di completamente nuovo. Oggi nessuno sa come funzionerà un’economia decarbonizzata.” Ricordava spesso Mauro Petriccione. “In questo momento”, era solito continuare “c’è un ampio sostegno pubblico per le politiche verdi. Nell’UE, vedo che oggi i partiti socialisti, liberali e cristiano-democratici hanno abbracciato politiche più verdi di quelle che i Verdi proponevano qualche anno fa. Si tratta di un cambiamento radicale. Fino a pochi anni fa, e credo che il 2018 possa essere considerato uno spartiacque, nessuno nell’UE, né la Commissione, né tanto meno la maggior parte degli Stati membri, stava facendo abbastanza per le politiche climatiche. Il cambiamento climatico e la protezione dell’ambiente erano obiettivi importanti tra altre priorità politiche, spesso più importanti o più urgenti. La situazione è cambiata. In parte, ciò è dovuto al cambiamento dell’opinione pubblica. Fridays for Future, che è il primo movimento politico di massa giovanile a livello continentale dopo le proteste della generazione del 1968 è impressionante. Sono più costruttivi, hanno una visione di ciò che vogliono ottenere. In Europa, hanno davvero spinto i politici ad agire. Tuttavia, mi chiedo se questi ragazzi si rendano pienamente conto di ciò che hanno innescato; se siano consapevoli dei cambiamenti epocali che li attendono.”
Come Mauro, quello che so oggi per certo è che se non sosteniamo le nostre economie e i nostri popoli durante la transizione, se la scelta per i nostri lavoratori si riduce a proteggere l’ambiente o a perdere il lavoro, allora non ce la faremo. E il Green Deal sarà solo una causa persa.
“Alla fine, saranno gli elettori a fare la differenza tra il successo e il fallimento”. Cominciava con queste parole la mia prima, lunga conversazione con Petriccione nell’estate del 2019. Ne sarebbero seguite altre. Sempre troppo poche fino alla notizia della sua morte.
Il giurista di origine italiana, pragmatico e senza fronzoli, lavorava per la Commissione dal 1987. Ovunque andasse era preceduto dalla sua reputazione. In qualità di vicedirettore generale della DG TRADE, ha guidato il negoziato che ha portato all’accordo commerciale UE-Canada, il CETA, e soprattutto all’accordo di partenariato economico con il Giappone, di cui andava molto fiero.
Non solo per il risultato, ma anche per la rete di relazioni personali, amichevoli e fiduciarie che era riuscito a costruire nel corso dei negoziati. Secondo un metodo che riteneva fondamentale preservare nel suo nuovo lavoro, irto di difficoltà e con partner a volte ostici. Un approccio che avrebbe soprattutto riprodotto nei negoziati con la Cina sin dalle primissime fasi del suo nuovo incarico. Mauro era duttile, aperto e profondamente curioso. I rapporti con i cinesi si presentarono da subito complessi. Gli mancavano le chiavi e l’esperienza per comprendere le regole dei suoi nuovi amici. Nel giro di qualche mese aveva interiorizzato i meccanismi di fondo.
Per Mauro la Cina era un partner inevitabile. I rapporti con Pechino su clima e ambiente sono solidi. Ma questo non è ancora sufficiente per rispondere adeguatamente all’urgenza e alla velocità dei cambiamenti climatici.
Mauro riteneva che fosse ora di passare ad un approccio “trasformativo”. Con Pechino come con gli altri partner internazionali.
Al contrario di molti, Mauro aveva i mezzi per immaginare come potesse essere disegnato questo quadro trasformativo, fondato su un nuovo sistema di regole adatto all’economia post-fossile. Il toolbox gli veniva dalla sua formazione, dalla sua intelligenza e dalla sua esperienza. Prima del 2018, nella sua carriera, Petriccione si era occupato di tutto tranne che di clima, spaziando dalla difesa commerciale agli standard, agli investimenti, alla concorrenza, all’agroalimentare, alla WTO, alla risoluzione delle controversie, alle relazioni con gli Stati membri o con l’Asia, all’America Latina.
Estraneo alla cricca dei soliti noti – i negoziatori e i professionisti del clima – Mauro incarnava una prospettiva nuova per il processo dei negoziati globali, poiché la sua esperienza gli consentiva di affrontarli da angolazioni tradizionalmente non associate ai negoziati ambientali, sebbene fossero intrinsecamente rilevanti.
Non mi sorprese quindi che fosse lui ad essere nominato quando la Commissione decise che era ora di fare sul serio su Parigi. Oggi è pacifico, e Mauro concordava, che la mancanza di allineamento multilaterale sulle politiche energetiche, industriali e commerciali ha portato al fallimento delle COP fino a Madrid, segnando i limiti “strutturali” del formato tradizionale dei negoziati sul clima. Il cambiamento di Glasgow e la prima legge climatica degli Stati Uniti si devono a un cambio di prospettiva fondamentale ormai accettato, sebbene non ancora realizzato. La protezione del clima e dei sistemi naturali diventano il centro delle politiche e dell’azione deli governi.
Petriccione riteneva “che l’Accordo di Parigi, pur con tutti i suoi difetti, avesse dato origine ad un meccanismo originale e potenzialmente molto efficace di obblighi di processo, che lasciano spazio alle scelte nazionali di sostanza, ma una volta che quelle scelte sono state fatte, conferiscono loro un certo grado di obbligatorietà di fatto”.
Come spesso sottolineato, la sfida ambientale globale del cambiamento climatico richiede politiche sia per ridurre l’intensità di carbonio dell’economia sia per potenziare i pozzi naturali di carbonio: energia, industria, trasporti, agricoltura, politiche fiscali, compresi i sistemi di tassazione e incentivi, sono le principali politiche settoriali che devono essere coinvolte per affrontare il cambiamento climatico. In breve, la sfida del cambiamento climatico coinvolge marginalmente le politiche ambientali “classiche”. E’ questione di politiche industriali, economiche e sociali. Quello che gli eventi costringono Macron a dichiarare in diretta alla nazione.
Un ultimo punto. Mauro avrebbe potuto essere già in pensione. Fu su richiesta dei vertici della Commissione che rimase. Per spirito di servizio, certo, ma anche perché ci credeva. Spero che la sua eredità sia degnamente raccolta.