Nel suo ultimo libro intitolato Capitalismo, Alberto Mingardi sfata molti luoghi comuni, quasi sempre alimentati dall’ostilità di molti intellettuali nei confronti del profitto, della proprietà privata e dei prezzi. La recensione di Giuseppe De Tomaso
Dura da più di 150 anni la guerra degli intellettuali al capitalismo. Una guerra concentrica, dichiarata da destra e da sinistra, di cui non s’intravvede l’epilogo, nemmeno sotto forma di tregua. Anzi, più l’economia di mercato riduce le sacche di povertà nel mondo, più s’allarga il fronte dei suoi detrattori, che le addebitano di tutto e di più, anche a costo, talora, di capovolgere i fatti e la verità. Lo stesso posizionamento anti-ucraino di numerosi pensatori occidentali è figlio del pregiudizio anti-borghese radicatosi in Europa a partire dalla rivoluzione industriale.
E siccome l’Ucraina intende far parte del club delle democrazie liberali europee partorite dall’illuminismo, le scuole di pensiero ostili alla società aperta e alla libertà economica preferiscono schierarsi, nella guerra in corso, con l’aggressore anziché con l’aggredito.
Chi, invece, vuole avvicinarsi senza preconcetti alla storia e all’attualità dell’economia di mercato, non ha che da leggere l’ultimo libro di Alberto Mingardi, intitolato Capitalismo ed edito dal Mulino (167 pagine, 13 euro).
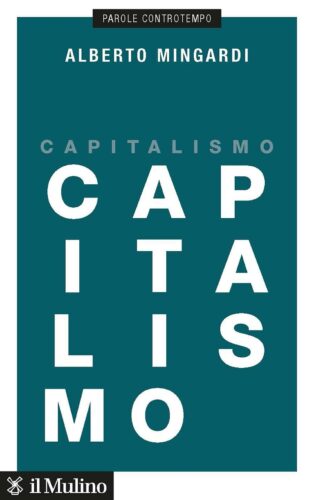
Docente universitario, direttore dell’Istituto Bruno Leoni, Mingardi è un infaticabile dissacratore di luoghi comuni. Il capitalismo è forse la vittima sacrificale più vilipesa da parte di coloro che, sotto sotto, tifano e si battono per una società chiusa, ingessata, diretta dall’alto, pianificata da uno Stato sempre più a caccia di quattrini da incassare e di regolazioni da varare. È talmente singolare la vicenda del capitalismo che parecchi suoi nemici sorvolano tuttora sulla miseria e sulla crescita zero che, per millenni, hanno caratterizzato la storia dell’uomo fino a pochi secoli addietro, cioè fino a quando gli ordinamenti liberali hanno preso il sopravvento sugli ordini feudali. Pur di non riconoscere la portata rivoluzionaria della rivoluzione borghese, parecchi studiosi tollerano più la ricchezza dinastica tipica dell’era feudale che la ricchezza meritocratica espressione delle società in movimento, basate sull’abilità degli imprenditori nel soddisfare le esigenze dei consumatori.
Neppure la constatazione che capitalismo significa innovazione, tanto che la storica dell’economica Deirdre N. McCloskey, suggerisce di ridefinirlo innovismo, riesce a placare gli animi più prevenuti, che non sono pochissimi. I più tendono a confondere il mercato con il posto dei privilegi e della staticità, mentre è vero proprio il contrario. Per un’impresa che ha successo, spiega Mingardi, ce ne sono 100 che muoiono in fasce, persino quelle apparentemente più solide possono vedersi franare il terreno sotto i piedi. La verità è che l’economia di mercato è più imprevedibile del meteo a marzo, sfugge ad ogni pronostico, perché segnata da quella mirabilmente illustrata dall’austriaco Joseph. A. Schumpeter (1883-1950). Basti pensare che solo il 10% delle imprese vitali 70 anni fa, supera oggi la prova di quel (capitalismo) che seleziona progetti e imprese in base alle preferenze dei consumatori.
Neppure la presa d’atto della democratizzazione del lusso, realizzata dal mercato, riesce ad attenuare l’antagonismo ideologico di quanti associano il capitale al demonio. Neppure l’arricchimento come fenomeno di massa, neppure la benefica magia rappresentata dal commercio tra estranei, neppure il sostegno finanziario del capitalismo alla scienza moderna (insieme costituiscono una premessa egualitaria), neppure le novità tecnologiche più ecologiche delle richieste gretine (da Greta), neppure il decentramento delle decisioni riescono a smontare le superstizioni contro il mercato e la proprietà privata, ritenuti artefici di tutti i mali dell’umanità.
La questione è semplice. Chi decide sui gusti, sugli orientamenti della gente comune? Chi decide cosa produrre: i politici o i consumatori? La politica, argomenta Mingardi, attraverso l’intervento statale tende ad allargare la propria presa tattile su ogni prodotto e servizio. Risultato: proliferano le rendite e le franchigie ordinistiche, che di sicuro soffocano l’economia. Le corporazioni si mettono di traverso contro la concorrenza, spesso nascondendo interessi inconfessabili. La concorrenza è fastidiosa e tutti cercano di aggirarla, sostenuti da larga parte del ceto intellettuale, dalla frustrazione degli istruiti nei confronti dei verdetti del mercato. Il che, per citare il sociologo Luciano Pellicani (1939-2020), ha contribuito ad alimentare la , coassiale appunto alle frustrazioni crescenti.
Del capitalismo, inteso nel libro di Mingardi, come economia di mercato non piace il disordine, l’anarchia della produzione. Viceversa, sono numerosi i fan, i supporter della pianificazione a cui piace da morire l’ordine, sulla falsariga di quanto succedeva, 25 secoli fa, nella statica Sparta rispetto alla dinamica Atene. Nell’ossessiva esplicazione del primato della politica alla fine prevale la coercizione, a svantaggio degli accordi volontari tra produttori e consumatori, e non solo tra loro.
La criminalizzazione del profitto è il filo conduttore di chi contesta il mercato e la proprietà privata. Ma come insegnava Ludwig von Mises (1881-1973), l’unico economista, sottolinea Mingardi, le cui previsioni si sono avverate, il profitto serve alle imprese per capire se stanno operando bene, ossia se sono efficienti. Senza il profitto, senza la proprietà privata e senza i prezzi liberi, salta qualsiasi calcolo economico, con buona pace dell’allocazione razionale delle risorse e degli investimenti, che necessitano di essere ispirati, guidati da informazioni veritiere e accertate, frutto delle relazioni tra milioni di persone, non già dai desiderata del potere dominante. Senza le decisioni scaturite dai prezzi, gli imprenditori guiderebbero a farsi spenti, o si muoverebbero come ciechi senza bastone.
Nemmeno l’accoppiamento naturale tra proprietà privata e responsabilità sfugge alle forche caudine di chi invece preferisce lo Stato quale unico padrone e direttore d’orchestra. Nemmeno la tendenza tipica dell’impresa pubblica, che erode la voglia di fare, riesce a placare la voglia matta dello Stato a interferire un po’ dappertutto, grazie a una legislazione spesso sinonimo di pianificazione. E pensare che il boom economico del secondo dopoguerra dipese molto dalla maggiore libertà in cui operarono imprese e lavoratori. Oggi, complice anche un’interpretazione estrema del keynesismo, al protagonismo dello Stato si è unita l’invocazione continua del debito quale garante di ogni diritto, in realtà quale produttore di nuove tasse per le future generazioni. È in corso l’età dei sussidi a prescindere, in nome della lotta alle disuguaglianze che, in realtà, proprio il mercato, documenta Mingardi, ha ridotto in tutto il mondo.
Ma nonostante tutto, nonostante le frecce avvelenate indirizzate contro il mercato, Mingardi non si dichiara pessimista. A patto, però, che, in avvenire, non dilaghino protezionismi e corporativismi. A patto di non farsi sedurre dai di sedicenti esperti. A patto di preferire la globalizzazione alla chiusura stile lockdown delle attività economiche. Finora, la società aperta, più o meno globalizzata, è riuscita a resistere a quanti volevano imbrigliarla. Ma non è detto che la sfida tra aperturisti e chiusuristi si sia conclusa. Molto dipenderà, lascia intendere Mingardi, dalla volontà o meno di voler continuare ad essere liberi di scegliere.
Certo, se gli intellettuali fossero meno prevenuti verso il mercato…








