La sicurezza come prassi è un processo basato sulla conoscenza della realtà nei suoi fattori di pericolo e di prefigurazione delle possibili, relative evoluzioni; un processo che sostanzialmente mira a ridurre al minimo ottenibile la minaccia, in base sia alla memoria storica degli eventi passati sia della prefigurazione dei futuri. Oggi anche attraverso la velocità della dimensione digitale. Pubblichiamo la prefazione di Gianni De Gennaro al volume “Sicurezza nazionale. Poteri, conflitti, informazioni”, a cura di Aronne Strozzi, pubblicato da Luiss University Press
Ci sono parole che più di altre hanno un forte potere riflessivo della condizione dell’uomo nella dimensione sociopolitica: poteri, conflitti e informazioni sono tra queste.
Pensare alla relazione e al bilanciamento tra questi elementi nei differenti sistemi politici, dai democratici agli autocratici, è l’obiettivo di questo testo. Con un comune denominatore: le organizzazioni preposte alla ricerca, alla raccolta e alla valorizzazione delle informazioni. I servizi d’intelligence.
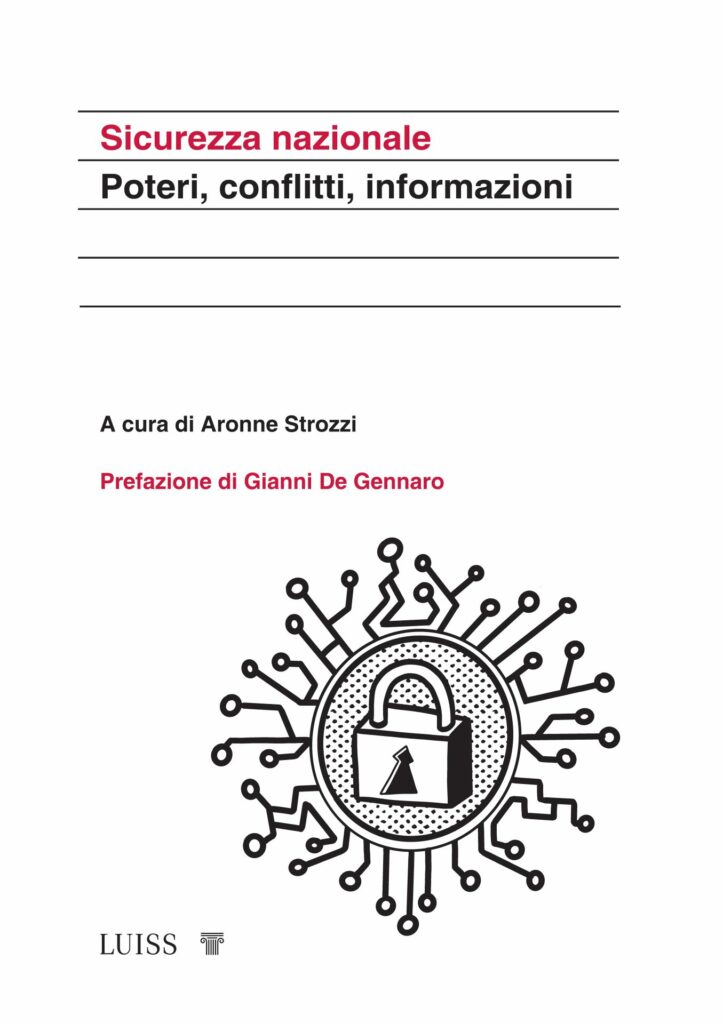 L’evoluzione dell’ordine mondiale cui stiamo assistendo, con un Occidente in confronto competitivo e, per alcuni scenari, in scontro con l’Est e il Sud del mondo, si annoda saldamente con la rivoluzione digitale che già investe le relazioni umane a livello globale e incide sulla configurazione conosciuta dei rischi e delle minacce.
L’evoluzione dell’ordine mondiale cui stiamo assistendo, con un Occidente in confronto competitivo e, per alcuni scenari, in scontro con l’Est e il Sud del mondo, si annoda saldamente con la rivoluzione digitale che già investe le relazioni umane a livello globale e incide sulla configurazione conosciuta dei rischi e delle minacce.
La sicurezza come prassi è un processo basato sulla conoscenza della realtà nei suoi fattori di pericolo e di prefigurazione delle possibili, relative evoluzioni; un processo che sostanzialmente mira a ridurre al minimo ottenibile la minaccia, in base sia alla memoria storica degli eventi passati sia della prefigurazione dei futuri. Oggi anche attraverso la velocità della dimensione digitale.
La sicurezza della convivenza associata è per gli Stati e oggi anche per gli attori globali – i c.d. “Hyperscaler” – un fattore intrinseco alla loro stessa esistenza. I volumi delle informazioni digitali che crescono a dismisura e la velocità della loro propagazione e affermazione come “verità” (o per alcuni addirittura “post-verità”), richiedono agli ordinamenti e alle organizzazioni nuove capacità di “cucire” i saperi per comprendere la complessità dello scenario e prefigurarne le probabili evoluzioni.
È un processo a un tempo di destrutturazione delle modalità di produzione e consumo del sapere, ma anche di deregolamentazione del potere delle informazioni, originariamente pubblico e oligopolistico, a seguito dell’affermazione di nuovi titolari e gestori di patrimoni di informazioni nel campo privato e con interessi e attività globali. È il dominio della c.d. “infosfera”, la nuova dimensione digitale della condizione umana, ovvero la tendenza verso la prevalenza dei dati sulla realtà materiale.
L’apparente pariteticità offerta dall’infosfera, tuttavia, non si traduce in una maggiore comprensione del contesto, né in eguali opportunità di accesso alla conoscenza. A fare la differenza sono la qualità e la quantità dei dati ma soprattutto l’ampiezza e l’efficienza della loro manipolazione mediante gli strumenti del super calcolo. Ciò porta a considerare, mai come prima, proprio per finalità di sicurezza i profili della residenza e della concentrazione delle informazioni, nonché delle potenzialità manipolative degli algoritmi.
La ricerca del significato immerso nel fondo delle informazioni non è più solo un tema di disponibilità tecnica, da risolvere con l’adozione delle più performanti lenti di ingrandimento dei flussi, ma anche di dimensione politica, laddove i Servizi d’intelligence sono chiamati a supportare i processi decisionali governativi attraverso l’autenticazione delle fonti di raccolta e l’elaborazione dei contenuti.
Ciò invoca una riflessione nel campo della teoria di governo che porta a interrogarsi sulle sfide che questo processo trasformativo è in grado di profilare ai modelli organizzativi statali e segnatamente alle missioni dei dispositivi preposti al mantenimento della sicurezza di un Paese.
Si tratta di una sfida che intercetta vari ambiti e che postula, a motivo dell’ampiezza e profondità degli effetti, una considerazione multidisciplinare, un approccio di scala, sinergico, integrato e strutturale.
Proprio guardando all’ordinamento giuridico nazionale di settore emerge, come dato di assoluta novità legislativa, ora ampiamente metabolizzato nella pratica istituzionale, il rilievo conferito dalla legge di riforma del comparto di intelligence, la n. 124 del 2007, alla nozione di “Sistema di informazione” intesa come chiave di volta dell’intero impianto politico-tecnico preposto alla sicurezza della Repubblica.
Emerge chiara e distinta, grazie a questo passaggio normativo, una visione che, senza stravolgere il piano delle competenze e delle responsabilità istituzionali, guarda all’insieme più che al particolare e che si riflette nella missione di salvaguardare la sicurezza nazionale in un ambiente di forze, di interessi e di tensioni sulle prerogative sovrane di ogni Stato.
Su questa poliedricità di approccio è basata questa pubblicazione, il cui titolo è tutt’altro che casuale: Sicurezza nazionale. Poteri, conflitti, informazioni, una raccolta di contributi distinti per angolazione di prospettiva, ma accomunati dall’esigenza di dare conto dell’ampiezza, della pervasività e della magnitudine che la sicurezza nazionale registra sullo scenario domestico e internazionale. Sono apporti curati da autori che posseggono, in buona parte, una preziosa esperienza operativa nel campo dell’intelligence pubblica e privata.
Nella rassegna ritroviamo la declinazione al plurale di tre fattori essenziali: l’accesso alle informazioni, anche nell’ambiente digitale; l’esercizio dei poteri all’interno e all’esterno della dimensione sovrana materiale e immateriale; la gestione dei conflitti tra poteri sovrani e interessi interstatuali. La trattazione della “Filosofia della Sicurezza” e della “Storia dell’Intelligence” fanno da sfondo e premessa allo sviluppo degli ulteriori contributi nei quali, con maggiore attualità, si trovano, trasversalmente rispecchiate, le componenti a supporto dell’azione politica e di governo nei differenti ordinamenti esaminati.
In questo senso ritengo efficace l’excursus che muove dal nostro Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e, in particolare, dal commento dei principali e innovativi strumenti giuridico-operativi di potenziamento della ricerca informativa, per giungere in chiave comparativa alle caratteristiche e agli strumenti delle principali Comunità di intelligence a livello globale, i “Servizi”, fino al mondo privato e alla relazione tra sistema informativo ed ecosistema economico-finanziario negli Stati Uniti d’America.
Certamente utile si rivela la trattazione comparata tra sicurezza nazionale e interessi strategici di un Paese o di un’Alleanza tra Paesi, attraverso la dimensione geografica e politica, l’economia e la tecnologia che, anche grazie all’azione delle grandi imprese strategiche di rilevanza internazionale, caratterizza il posizionamento di un determinato Paese sulla scena globale, cosicché il tema di una più strutturata collaborazione pubblico-privato è esaminato nella prospettiva del risk management nel mondo aziendale.
Infine, come ho anche evidenziato in apertura di prefazione, la pubblicazione ci porta nella dimensione digitale più proiettiva: l’intelligenza artificiale. È un fatto storico che il rapporto sicurezza-tecnologia influenzi i modi della ricerca informativa e oggi questo rapporto è ancor più intrinseco con l’affermarsi così rapido del nuovo potere degli algoritmi, specie nel dominio del calcolo di natura generativa.
Il testo dedica una parte allo specifico argomento, a partire dal fattore antropocentrico per poi riflettere sulla individuazione del giusto trade-off fra vincoli e benefici dell’uso di questa tecnologia nelle attività di pertinenza del ciclo di intelligence. Penso infatti che sia legittimo ritenere che in presenza di una espansione dei flussi informativi il più utile impiego dell’intelligenza artificiale consista nel discriminare il dato giusto (cioè temporalmente utile) dalla soglia del c.d. “rumore informativo” cui la società e i cittadini digitali di oggi e di domani sono e saranno sempre più esposti.
Si tratta, insomma, di una lettura destinata a praticanti e cultori della materia, ma che può suscitare l’interesse anche di un pubblico più vasto che cerchi approfondimenti sulla “magnifica complessità” del mondo dei “servizi segreti”, espressioni strumentali dell’azione politica di governo, ma anche – laddove gli ordinamenti lo consentano – funzione di qualificazione e certificazione delle informazioni rilevanti per l’interesse nazionale.








