Le parole in rima di Rodari ci ricordano che siamo tutti sotto lo stesso cielo, che l’umanità intera è unita al di là della violenza, delle differenze culturali e politiche. Con lo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022, il mondo si è improvvisamente risvegliato dal suo sonno profondo. L’aggressione a un Paese europeo, l’invio delle armi, il riarmo da parte degli Stati, il ritorno delle trincee e tante altre cose hanno fatto assumere all’Occidente la consapevolezza che la guerra, in fin dei conti, non è poi così lontana come si credeva. Pubblichiamo un estratto del libro di Mario Mauro dal titolo “Viene la guerra” (Rubbetino)
La luna di Kiev
Chissà se la luna
di Kiev
è bella
come la luna di Roma,
chissà se è la stessa
o soltanto sua sorella…
“Ma son sempre quella!
– la luna protesta –
non sono mica
un berretto da notte
sulla tua testa!
Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,
dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
e i miei raggi viaggiano
senza passaporto”.
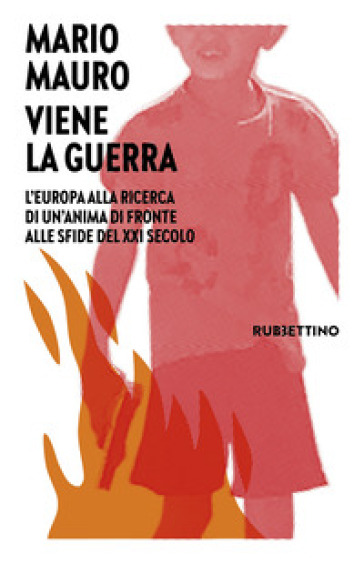 La luna di Kiev, poesia di Gianni Rodari, è una filastrocca per bambini e non ha nessuna implicazione con la guerra. Tuttavia, le parole di Gianni Rodari risuonano più che mai attuali oggi, nei giorni in cui riecheggiano a distanza di oltre due anni le grida di dolore del popolo ucraino. Le parole in rima di Rodari ci ricordano che siamo tutti sotto lo stesso cielo, che l’umanità intera è unita al di là della violenza, delle differenze culturali e politiche.
La luna di Kiev, poesia di Gianni Rodari, è una filastrocca per bambini e non ha nessuna implicazione con la guerra. Tuttavia, le parole di Gianni Rodari risuonano più che mai attuali oggi, nei giorni in cui riecheggiano a distanza di oltre due anni le grida di dolore del popolo ucraino. Le parole in rima di Rodari ci ricordano che siamo tutti sotto lo stesso cielo, che l’umanità intera è unita al di là della violenza, delle differenze culturali e politiche.
La luna raccontata da Rodari è la luna di tutti, capace di parlare all’umanità intera e di donare preziosi consigli capaci di alimentare l’immaginazione e la conoscenza. Rodari la interroga con l’innocenza di un bambino, domandandosi chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. I raggi della luna illuminano tutto il mondo senza fare alcuna distinzione, lanciando un messaggio di pace e di uguaglianza e solidarietà tra gli uomini. In realtà, i versi di Rodari pongono anche un tema di profondo realismo. Se siamo tutti sotto lo stesso cielo non esistono i conflitti, ma il conflitto. Dove la capacità di produrre nuovi equilibri è un tutt’uno con il riconoscere le ragioni dell’altro.
Fin dai primi anni del suo pontificato papa Francesco ha posto particolare attenzione ai molti conflitti in giro per il mondo. Il Pontefice ha parlato più volte dalla finestra dei Palazzi apostolici di tutte quelle guerre silenziose e lontane che ancora oggi mietono ogni anno decine di migliaia di morti, ma non ha mai dimenticato quelle guerre che, invece, per lungo tempo hanno dominato la narrazione sui grandi media occidentali come la guerra civile in Siria e il conflitto in Ucraina. Molto spesso ci si dimentica che il Papa ha una posizione privilegiata per guardare la situazione del nostro mondo: la Chiesa, sparsa in tutto il mondo, ha una profonda conoscenza del territorio all’interno del quale opera.
Grazie a queste radici profonde che si immergono nelle realtà locali, la Chiesa raccoglie ogni giorno notizie e informazioni da ogni angolo del globo. Dal principio del suo pontificato, papa Francesco ha parlato spesso di «terza guerra mondiale a pezzi». Solo oggi, a distanza di anni e con un mondo molto diverso da quello in cui Francesco è salito al soglio pontificio, ci si accorge che il suo monito era di una gravità che solo pochi fin da allora avevano colto appieno. Con un decennio di anticipo, il Papa aveva previsto quello di cui noi solo oggi ci accorgiamo: vi è un conflitto latente nel mondo che collega ogni guerra che conosciamo. Questo conflitto è profondo, silenzioso, ma in alcuni punti della terra esso esplode.
Con lo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022, il mondo si è improvvisamente risvegliato dal suo sonno profondo. L’aggressione a un Paese europeo, l’invio delle armi, il riarmo da parte degli Stati, il ritorno delle trincee e tante altre cose hanno fatto assumere all’Occidente la consapevolezza che la guerra, in fin dei conti, non è poi così lontana come si credeva. Era ormai opinione comune che il ricorso alle armi per risolvere le controversie – in particolare nel mondo occidentale civilizzato e ipertecnologico – fosse una cosa da barbari ormai.
Vi era la diffusa illusione che gli ultimi ad aver visto la guerra sarebbero stati per sempre i nostri nonni. Ma all’improvviso questa bolla è esplosa. Ci si è resi conto che la «terza guerra mondiale a pezzi» di cui ha parlato a lungo il Papa, e a cui troppi pochi avevano dato ascolto, è in realtà sempre più concretamente sotto gli occhi di tutti.
Francesco ha però già smesso ormai da tempo di parlare di un conflitto a pezzi, ormai parla solo di «guerra». Agli occhi del Pontefice quello verso cui il mondo sta inesorabilmente andando è un conflitto su scala mondiale che ormai non ha più nemmeno senso definire «a pezzi». Il tempo che rimane per evitare questo scenario – che sarebbe probabilmente una guerra nucleare – è quindi ormai agli sgoccioli.
La soluzione a questa drammatica situazione va ricercata nello sviluppo degli equilibri geopolitici degli ultimi decenni. Da sempre nella storia, dopo ogni guerra i vincitori si accordano e delineano gli equilibri dei tempi e venire: Vestfalia, Vienna e Parigi sono stati tutti trattati di pace che hanno dato al mondo una stabilità duratura, ma non eterna. Ogni guerra finisce con una pace, ma quest’ultima non è che il risultato di un conflitto che l’ha preceduta. L’ultima volta che vi è stata una pace che ha dato al mondo stabilità e ordine era il 1945.
Alla Conferenza di Yalta – ormai quasi ottant’anni fa – sedevano attorno al tavolo i vincitori della Seconda guerra mondiale: Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna. Dalle loro decisioni nacquero quegli equilibri che fino al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 avrebbero regolato i rapporti di forza del mondo. Oramai, però, anche il mondo guidato dall’egemonia statunitense è giunto alla fine: nuovi attori si sono affacciati sulla scena mondiale e pretendono di essere riconosciuti, vogliono una nuova pace che ne riconosca il ruolo. Per questa ragione molti di loro sono disposti a tutto. Ad ogni guerra segue una pace, ma il prossimo conflitto potrebbe essere l’ultimo dell’umanità. Serve quindi che – per la prima volta nella storia – si raggiunga una pace senza che questa sia stata preceduta da una guerra: il tempo è poco e la posta in gioco molto alta.
Viene la guerra, insomma. Una trentina di conflitti infiammano oggi lo scenario globale. Dall’Ucraina al Caucaso, dal Medioriente fino all’instabilità africana e alle tensioni nello scacchiere indopacifico. Conflitti crudeli che sarebbe però sbrigativo liquidare come fenomeni solo regionali. Da troppo tempo gli equilibri globali sono legati ad accordi di potere, come Yalta, stipulati in un mondo e in un’epoca profondamente diversi. Gli interessi dei nuovi grandi players globali oscillano tra chi vuole nuovamente Yalta come la Russia e gli Stati Uniti che pretendono di conservare il ruolo di guardiano del mondo, e chi esige una Yalta del tutto nuova, come Cina e India. In questo scenario cruciale quale partita può giocare l’Europa e soprattutto l’Unione Europea, solo esempio di progetto politico promosso non solo dai paesi vincitori di una guerra, ma da vincitori e vinti assieme?
“La terza guerra mondiale a pezzi” di cui da anni parla papa Francesco è ormai una strada obbligata per la risoluzione delle controversie? Ed è proprio vero che la richiesta di pace e dialogo insistentemente reiterata dal Pontefice è una posizione isolata?
Al di là della tradizionale teoria della deterrenza, quali carte ha a sua disposizione la comunità internazionale per promuovere e favorire oltre il gioco delle grandi potenze una dinamica di pace? Armi, soldi e demografia — caratteri ineludibili dello status di grande potenza — saranno i soli arbitri del confronto tra democrazie ed autarchie? Il libro si propone, rispondendo a queste domande, di offrire opportunità non retoriche alla giustizia e alla pace.








