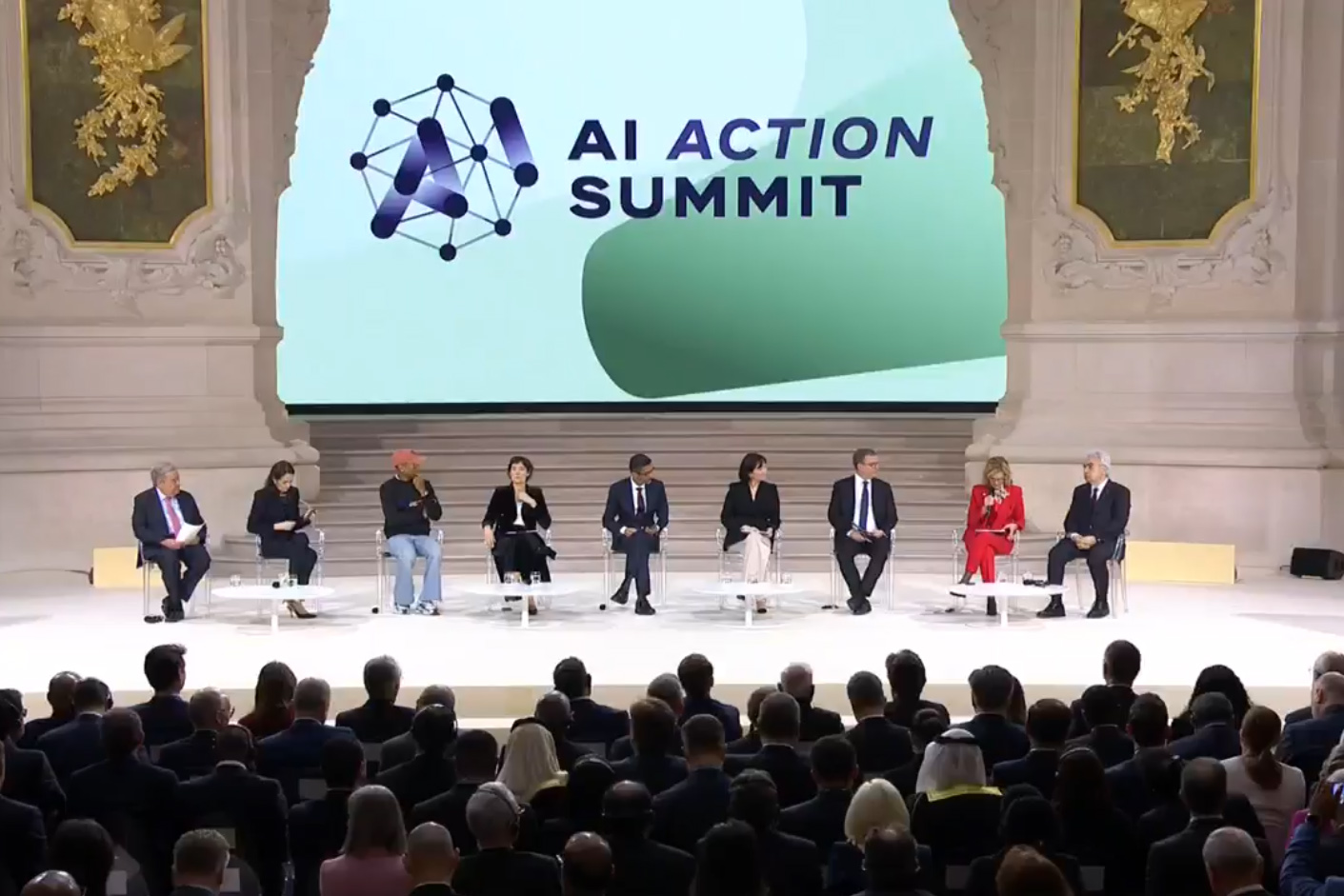L’Europa, per massimizzare i suoi investimenti nell’IA, deve tracciare una terza via, distinta sia dagli Stati Uniti che dalla Cina. Ha stabilito regole e stanziato fondi, ma ora serve il coraggio di attuare una politica tecnologica che possa coinvolgere tutto il resto del mondo e che possa portare a una nuova produzione tecnologica propria
Il terzo AI Summit si è tenuto a Parigi, sotto la regia del presidente Macron. Poca “AI” e molto “summit”: l’evento è stata l’occasione per la Francia di avere un palcoscenico mondiale dove intessere relazioni parlando di intelligenza artificiale, seguendo la nuova narrativa muscolare statunitense che privilegia i numeri della spesa e degli investimenti rispetto alla sicurezza e alla regolamentazione. A dominare i titoli infatti sono stati i miliardi di euro che la Francia e l’Europa pensano di attrarre per promuovere le proprie politiche tecnologiche, a discapito del vero obiettivo del summit: una regolamentazione globale sull’AI. Tuttavia, senza la firma degli Stati Uniti e del Regno Unito, l’accordo è rimasto incompleto. Forse è anche lo spirito dei tempi, con l’Onu e gli altri organismi internazionali in grande difficoltà di consensi e di prospettive o forse è arrivato il momento di abbandonare i grandi progetti di governance globali. Ma quindi l’Europa si toglie la divisa da arbitro e scende in campo nella competizione con Usa e Cina? Freniamo gli entusiasmi. Proviamo a capire meglio vinti e vincitori dal punto di vista degli attori protagonisti nella corsa all’intelligenza artificiale.
Francia
I sogni di grandeur francese si proiettano sull’intelligenza artificiale: Emmanuel Macron ha infatti utilizzato il summit come palcoscenico per rafforzare il ruolo della Francia come hub europeo dell’AI. Con un piano da 109 miliardi di euro per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha mandato un messaggio chiaro: Parigi vuole essere il centro di gravità dell’innovazione in Europa, ponendosi in competizione con l’Unione Europea stessa. Gli investitori sono internazionali: 20 miliardi di euro dalla società Brookfield (Canada) più altre quote da Amazon, dal fondo Apollo Global Management e dalla multinazionale Digital Realty. Inoltre, la Francia ha stretto un accordo strategico con gli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di un data center AI da 30-50 miliardi di dollari, rafforzando la propria posizione nell’infrastruttura tecnologica globale anche con la creazione di ambasciate virtuali dei dati e identificando già 35 siti per ospitare nuove infrastrutture. Macron ha dalla sua il vantaggio competitivo di un’abbondante produzione di energia nucleare, essenziale nella costruzione dei data center sempre più energivori. La Francia ha infatti 90 TWh di energia nucleare in eccesso che esporta ogni anno. Potrebbe benissimo decidere di dirottarla verso la costruzione di nuove infrastrutture, se chi paga offre di più, anche a discapito dell’Italia, che ne è importatrice. Oltre all’energia, la Francia ha un grande vantaggio: un sistema universitario che sfornerà potenzialmente 100.000 ingegneri AI l’anno e sono proprio questi ultimi a offrire il contributo più significativo.
Senza contare la partnership con l’India di Narendra Modi, presente al summit, che, dato il suo potenziale tecnologico, le sue risorse e la sua IA “per il bene comune”, di natura multilaterale, può essere in prospettiva una valida alternativa sia alla visione americana della deregolamentazione, sia a quella cinese del controllo statale. Macron ha anche esortato le aziende europee ad acquistare da startup europee. Secondo lui, la maggior parte delle aziende negli Stati Uniti e in Cina preferisce soluzioni locali, mentre in Europa questo approccio è meno diffuso, soprattutto nel settore tecnologico.
Inoltre, la startup Mistral ha ricevuto un forte sostegno governativo, con Macron che ha promosso direttamente il nuovo chatbot “Le Chat”, diventato in breve tempo l’app più scaricata su iOS in Francia. Nonostante le difficoltà di espansione nel resto d’Europa, Mistral sta costruendo una solida presenza nel settore B2B grazie a collaborazioni strategiche con aziende come Stellantis, Veolia e Helsing, società europea attiva nella difesa.
Al grido di “Make the planet great again”, Macron avrebbe voluto che questo summit non fosse solo l’annuncio di un grande piano di investimenti in Francia, ma un campanello d’allarme per una strategia europea. Tuttavia, resta prigioniero dello sciovinismo francese, e non si intravede alcuna volontà concreta di costruire un percorso comune europeo. “Plug, baby, plug”, dice Macron parafrasando Trump: il Presidente francese ha sempre dimostrato di avere una grande visione sull’innovazione, ma i problemi rimangono tutti nell’esecuzione. Vedremo se riuscirà a posizionare la Francia come superpotenza dell’IA.
Usa
Sono i soldi a guidare la visione americana sull’intelligenza artificiale. «Sono qui per parlare di opportunità, non di paura di rischiare. Dobbiamo liberare l’innovazione e garantire che l’intelligenza artificiale porti benessere alla nostra gente. Questa è un’opportunità che l’amministrazione Trump non ha intenzione di sprecare», ha dichiarato il vicepresidente J.D. Vance nel suo intervento al Grand Palais, attaccando chi collabora con «regimi autoritari», un chiaro riferimento alla Cina e alla sfida lanciata da DeepSeek, ma anche la «regolamentazione eccessiva», che, secondo lui, «potrebbe soffocare un’industria in piena espansione».
Il mantra statunitense resta lo stesso: regole leggere, investimenti miliardari. Le big tech americane stanno già mettendo sul piatto cifre enormi: oltre i 500 miliardi di dollari di Stargate ci sono gli investimenti delle singole aziende, che sommati insieme fanno la stratosferica cifra di 320 miliardi solo per il 2025. Per fare un confronto, per quest’anno il governo italiano prevede di destinare circa 55,6 miliardi di euro agli investimenti pubblici, un quinto di quanto spendono le big tech in intelligenza artificiale.
Gli Stati Uniti sono consapevoli che hanno tutte le potenzialità per il dominio tecnologico e non intendono farsi rallentare in nessun modo.
UK
Il governo britannico ha sorpreso tutti rifiutandosi di firmare la dichiarazione finale del summit, segnando una distanza dalle politiche europee. Il premier Keir Starmer sembra voler riallacciare i rapporti con gli Usa piuttosto che allinearsi con l’Europa, come suggerisce la sua nuova strategia sull’intelligenza artificiale, focalizzata sullo sviluppo piuttosto che sulle regole. Fa sorridere ripensare al primo AI Summit, tenuto a Bletchley Park, dove venne decifrata la comunicazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, e in cui l’allora Primo Ministro Rishi Sunak si vantava che il Regno Unito sarebbe stato l’esempio della regolamentazione mondiale, spalleggiando le previsioni catastrofiche di chi vedeva nell’IA un’arma per la fine dell’umanità.
Italia
Ah l’Italia. Mentre in Senato giace da mesi il Ddl IA del governo, trattato ormai come una vhs vecchia e inutile, l’Italia ha mandato Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, che non ha aggiunto niente di memorabile. Giorgia Meloni fu molto contenta di essere celebrata come uno degli ospiti più importanti al primo Summit in Inghilterra, dimostrando interesse sull’intelligenza artificiale. È finito l’amore per la tecnologia o non si è voluto dare risalto a un evento curato dai cugini francesi? Non lo so, fatto sta che l’Italia è tornata irrilevante nel panorama mondiale dell’intelligenza artificiale.
Europa
“Il più grande partenariato pubblico-privato al mondo per lo sviluppo di un’IA affidabile”, dichiara Ursula von der Leyen annunciando InvestAI, un piano da 200 miliardi di euro che l’Ue intende destinare all’intelligenza artificiale. Sembra finalmente che l’Europa voglia competere con le grandi potenze tecnologiche, ma, analizzando meglio i dettagli, emergono alcune criticità. Il modello di InvestAI richiama da vicino quello del Piano Juncker del 2015, che prometteva miliardi per l’innovazione, ma si basava su una combinazione di fondi pubblici e investimenti privati. L’idea è che il capitale pubblico funzioni da leva per attrarre finanziamenti privati. Se il meccanismo funzionerà come previsto, potrebbe realmente mobilitare ingenti risorse. Tuttavia, se gli investitori privati non risponderanno come auspicato, la disponibilità effettiva dei fondi potrebbe essere molto inferiore alle attese.
Dei 200 miliardi annunciati, 150 miliardi dovrebbero arrivare da aziende, venture capital e fondi di investimento, mentre 50 miliardi saranno stanziati dall’Unione Europea attraverso programmi come Horizon Europe, Digital Europe Programme e InvestEU, che prevedono co-finanziamenti. In sostanza, non si tratta di nuovi investimenti, ma di una riallocazione di risorse già esistenti.
In particolare, 20 miliardi saranno destinati alla creazione di quattro AI Gigafactories, supercomputer avanzati per l’addestramento di modelli di IA di ultima generazione. Queste infrastrutture, secondo le stime, potrebbero ospitare fino a 100.000 chip di ultima generazione, quadruplicando la capacità delle attuali AI factories. Una di queste è prevista anche in Italia, grazie a Leonardo, il supercomputer del Cineca. L’obiettivo è fornire a ricercatori e startup europee strumenti per competere con i colossi americani e cinesi. Tuttavia, senza player tecnologici di peso, il rischio è che queste infrastrutture rimangano sottoutilizzate o finiscano sotto il controllo di colossi già affermati, diventando terreno di conquista per altre potenze tecnologiche.
Da mesi si parla della necessità di creare un’”Airbus dell’IA”, un’iniziativa industriale capace di competere con i giganti globali. All’AI Action Summit di Parigi, questa visione sembra prendere forma. La presidente della Commissione Europea ha infatti annunciato la “EU AI Champions Initiative”, una nuova alleanza tra settore pubblico e privato, che coinvolge oltre sessanta aziende, tra cui grandi gruppi industriali come Airbus, L’Oréal, Mercedes e Siemens, e aziende tecnologiche come Spotify e Mistral AI. L’iniziativa mira a:
- Mobilitare talenti e capitali per rafforzare l’ecosistema IA europeo;
- Accelerare l’adozione dell’IA nei settori consolidati per aumentarne la competitività;
- Coordinare gli sforzi tra tecnologia, industria e politica per modernizzare le infrastrutture e promuovere un ecosistema tecnologico realmente competitivo.
Tuttavia, i contorni del progetto restano ancora poco chiari. Sarà all’altezza delle grandi aspettative? Solo il tempo lo dirà. Da sottolineare l’assenza di imprese italiane coinvolte nel progetto.
Nel frattempo, l’AI Act non sta contribuendo a rendere l’Europa più attrattiva per gli investitori e le aziende tecnologiche. La Commissione ha pubblicato le linee guida per facilitare l’applicazione delle prime norme dell’AI Act con un complesso testo di 130 pagine pieni di casistica e criteri discrezionali, soprattutto nella definizione degli usi vietati e delle relative eccezioni. Parallelamente, la direttiva sull’AI Liability, che avrebbe dovuto armonizzare le norme sulla responsabilità per i danni causati dai sistemi di IA, è stata affossata. Una scelta che, per tempistiche, appare più una concessione alle pressioni della Casa Bianca che un reale ripensamento strategico da parte della Commissione von der Leyen.
L’Europa si muove, ma resta ancora molta strada da fare per costruire una vera leadership tecnologica autonoma.
Il ruolo dell’Europa: da coniglio a leone
Se non avessimo avuto l’acciaio, come avremmo sostenuto la Prima Rivoluzione Industriale? Oggi, l’intelligenza artificiale e la sua intera catena del valore sono fondamentali per la nuova economia.
L’Europa ha bisogno di una strategia radicalmente diversa per tornare protagonista: il ritardo rispetto agli Stati Uniti non dipende dalle normative, ma dalla carenza di investimenti adeguati. La web tax e la global minimum tax sono tentativi di riequilibrare il potere fiscale tra l’Ue e le Big Tech americane, ma restano inefficaci se prima non vengono risolte le disparità fiscali interne all’Unione. La soluzione non è il protezionismo, ma un’apertura strategica a nuove collaborazioni con realtà emergenti in Asia, Africa e America Latina. Paesi come India, Giappone, Corea del Sud e alcune economie africane stanno investendo in ricerca e innovazione, creando opportunità che l’Europa non può permettersi di ignorare. Anche la Cina può rappresentare un partner chiave, come riconosciuto dalla presidente Ursula von der Leyen (ha anche firmato l’accordo globale).
Come evidenziava il filosofo ed economista scozzese David Hume, commercio e cooperazione internazionale sono essenziali per la prosperità di tutti. L’Europa non deve limitarsi a rafforzare i legami con gli Stati Uniti, ma costruire una politica tecnologica multilaterale, capace di cogliere le migliori opportunità a livello globale.
L’innovazione europea non può dipendere da un unico attore, per quanto potente. Serve un approccio strategico che favorisca scambi con nuovi hub tecnologici, attrazione di talenti internazionali e diversificazione delle fonti di investimento. La differenza tra i leader dell’IA e i loro inseguitori si sta assottigliando. Oggi, per dominare il settore, servono ancora enormi capitali, ma per ridurre il divario ne bastano meno rispetto al passato. Il mercato si sta diversificando e diventando più competitivo, un’opportunità che l’Europa deve sfruttare. La specializzazione nei diversi settori verticali resta una strategia efficace per ottenere un vantaggio competitivo nel breve periodo.
L’Europa può ancora giocare un ruolo centrale nel futuro dell’IA investendo in ricerca di base, scienza aperta e innovazione radicale. DeepSeek lo ha dimostrato: con un po’ di creatività, la partita sugli applicativi è tutt’altro che chiusa. Perché non puntare su nuove scoperte e tecnologie di frontiera?
Il Cern ha dimostrato che il progresso nasce dalla ricerca aperta e dalla cooperazione internazionale. Se la Commissione von der Leyen vuole replicarne il modello, deve farlo fino in fondo, con una visione non solo economica, ma anche politica. L’Ue ha un bisogno urgente di un mercato unico dei capitali per attrarre investimenti e favorire un’innovazione realmente autonoma. La liquidità esiste, ma continua a fluire verso gli Stati Uniti a causa della mancanza di un sistema finanziario europeo solido. L’Europa, per massimizzare i suoi investimenti nell’IA, deve tracciare una terza via, distinta sia dagli Stati Uniti che dalla Cina. Ha stabilito regole e stanziato fondi, ma ora serve il coraggio di attuare una politica tecnologica che possa coinvolgere tutto il resto del mondo e che possa portare a una nuova produzione tecnologica propria. Solo così si potrà trasformare l’attuale immobilismo in un vero e proprio “ruggito del coniglio”.