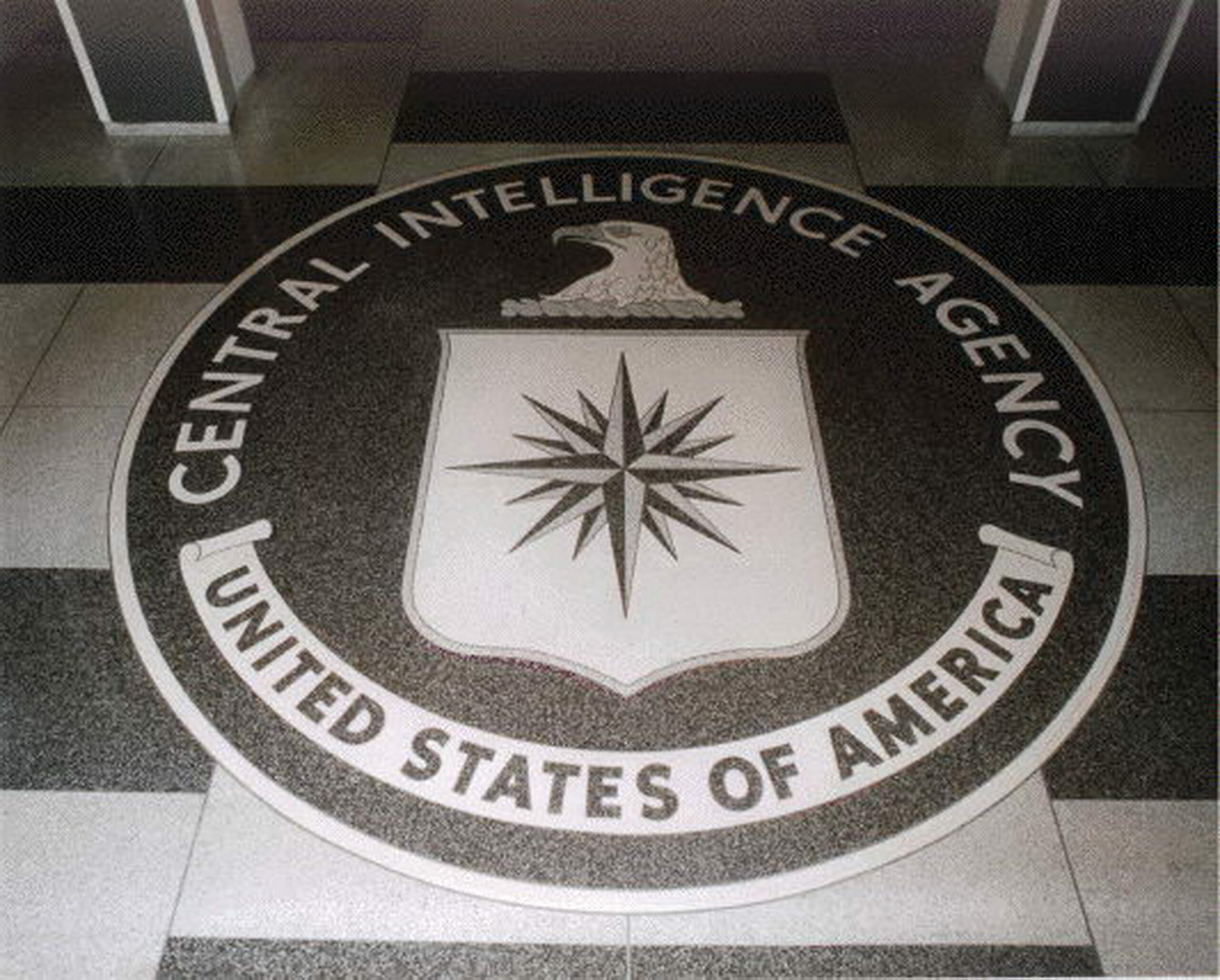Il Comitato Intelligence del Senato statunitense ha approvato a larga maggioranza l’Intelligence Authorization Act per il 2026, un pacchetto normativo che ridefinisce priorità e strumenti dell’Intelligence Community (Ic) in un contesto di crescente competizione strategica con Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Ecco le riforme strutturali che il provvedimento introduce
Il Senate Select Committee on Intelligence ha approvato a grande maggioranza l’Intelligence Authorization Act per l’anno fiscale 2026, che ridefinisce priorità strategiche, risorse e strumenti operativi e giuridici della intelligence community Usa. Sostenuto dal presidente della Commissione, Tom Cotton, e dal vicepresidente Mark Warner, il provvedimento introduce sostanziali riforme all’Ufficio del direttore della National Intelligence e rafforza al contempo la sicurezza nazionale contro minacce emergenti, dalla biotecnologia alla cybersicurezza.
Le priorità dell’Intelligence Authorization Act
La legge disegna un nuovo approccio sistemico per la sicurezza delle infrastrutture informatiche, tecnologiche e digitali: vieta contratti con aziende militari cinesi nel biotech, innalza i requisiti di cybersecurity per le reti di telecomunicazione e punta a potenziare l’uso dell’intelligenza artificiale all’interno della intelligence community. Con particolare meticolosità e cura riguardo il contrasto delle minacce biotecnologiche, alla protezione dei dati genomici da infiltrazioni della Repubblica Popolare Cinese e alla resilienza energetica attraverso tecnologie nucleari avanzate, il provvedimento rafforza le misure di controspionaggio nelle infrastrutture di comunicazione. Sul piano politico, Washington ribadisce la necessità di approntare le proprie strutture di intelligence alle sfide future, che vedranno, oltre ai conflitti cinetici tradizionali, tecnologia, bioingegneria e conflitto ibrido e cognitivo come i principali campi di battaglia tra potenze rivali ed emergenti.
Le sfide ai sistemi di intelligence e controspionaggio
Nel contesto delle rivalità strategiche contemporanee, il paradigma concettuale del confronto tra sistemi (systems confrontation) struttura una modalità di competizione che si sviluppa attraverso una grande molteplicità ed eterogeneità di domini: la systems-destruction warfare si struttura sulla neutralizzazione delle abilità capacitive, operative, cognitive e logistiche avversarie grazie all’impiego coordinato ed integrato di strumenti e risorse tecnologiche, militari, biologiche, informative e psicologiche, mirando alla supremazia in questi domini interconnessi.
La concezione cinese di guerra senza limiti, o guerra moderna, rappresenta una sfida ulteriore per le strutture di intelligence occidentali, estendendo il concetto di conflitto e la conduzione di questo ad una dimensione olistica, senza limiti di spazio o tempo, inserendo le attività malevoli e belliche all’interno di una soluzione di continuità strategica, nella quale ogni leva del potere nazionale può essere utilizzata come superficie d’attacco.
La natura onnidirezionale, illimitata ed asimmetrica delle minacce obbliga le strutture di intelligence ad una revisione della propria postura strategica, già immaginata da riforme come la Presidential decision Directive 75 del 2000 – che auspicava un sistema predittivo e integrato – e l’istituzione di organismi come il National Counterintelligence and Security Center ed invocata quarant’anni fa da studiosi ed esperti del settore, come George Kalaris e Leonard McCoy, i quali sottolineavano l’esigenza di una ridefinizione delle strutture di intelligence e counter intelligence, anche alla luce delle crescenti sfide tecnologiche e multidimensionali.
Questo mutamento paradigmatico ha messo in crisi il sistema di controintelligence (CI) statunitense, storicamente ancorato a una visione difensiva e settoriale, più orientata alla protezione delle informazioni che alla competizione attiva contro i servizi d’intelligence stranieri. Da decenni, il mondo della CI soffre di una duplice crisi di identità e responsabilità. Secondo analisti come Michelle Van Cleave e James Olson, la controintelligence americana si è dimostrata “frammentata, miope e marginalmente efficace” perché priva di una dottrina operativa coerente capace di affrontare minacce sistemiche.
Dal grande gioco alla competizione a spettro completo
Lo scacchiere internazionale odierno è caratterizzato da una sfida a spettro completo (full-spectrum contest), in cui la competizione per il vantaggio strategico si sviluppa simultaneamente su più livelli: diplomazia, potere militare, supremazia tecnologica e influenza economica. In questo contesto, potenze revisioniste come Russia e Cina hanno adottato una visione system-of-systems, integrando in modo sistemico tutti i domini operativi in un’unica architettura modulare e flessibile, capace di incorporare nuove tecnologie e funzioni nel tempo. In questa logica, ogni elemento (militare, economico, tecnologico o informativo), può essere combinato in modo sinergico per raggiungere la superiorità contro sistemi rivali, colpendo la rete vitale su cui si fonda il funzionamento della società e della potenza avversaria.
Adattarsi alle minacce
I nuovi modelli operativi e le nuove architetture strategiche delle agenzie di intelligence occidentali delineano chiare direttrici strategiche. Abbandonare la frammentazione funzionale e l’eccessiva compartimentazione, modelli che minano la capacità di visione d’insieme delle minacce e ne limitano le capacità di lettura, anticipazione e contrasto integrato. Adottare nuove chiavi di lettura ed analisi delle minacce, con l’assunzione di nuovi paradigmi bellici concettuali e culturali in favore di più efficaci dottrine di sicurezza nazionale. Implementare le proprie infrastrutture tecnologiche e la loro autonomia operativa, lavorando sul controllo e la gestione dei software stranieri e sulle politiche estere di trasmissione di dati. Coltivare modelli di resilienza e deterrenza per ogni dominio bellico oggi esistente, nella consapevolezza che oggi i conflitti includono la weaponizzazione di ogni elemento utilizzabile, sociale, politico, economico e cognitivo, predisponendo così le proprie agenzie di intelligence e counter intelligence non come un mero strumento reattivo, ma come strutture capaci di analisi preventiva ed efficacia operativa.