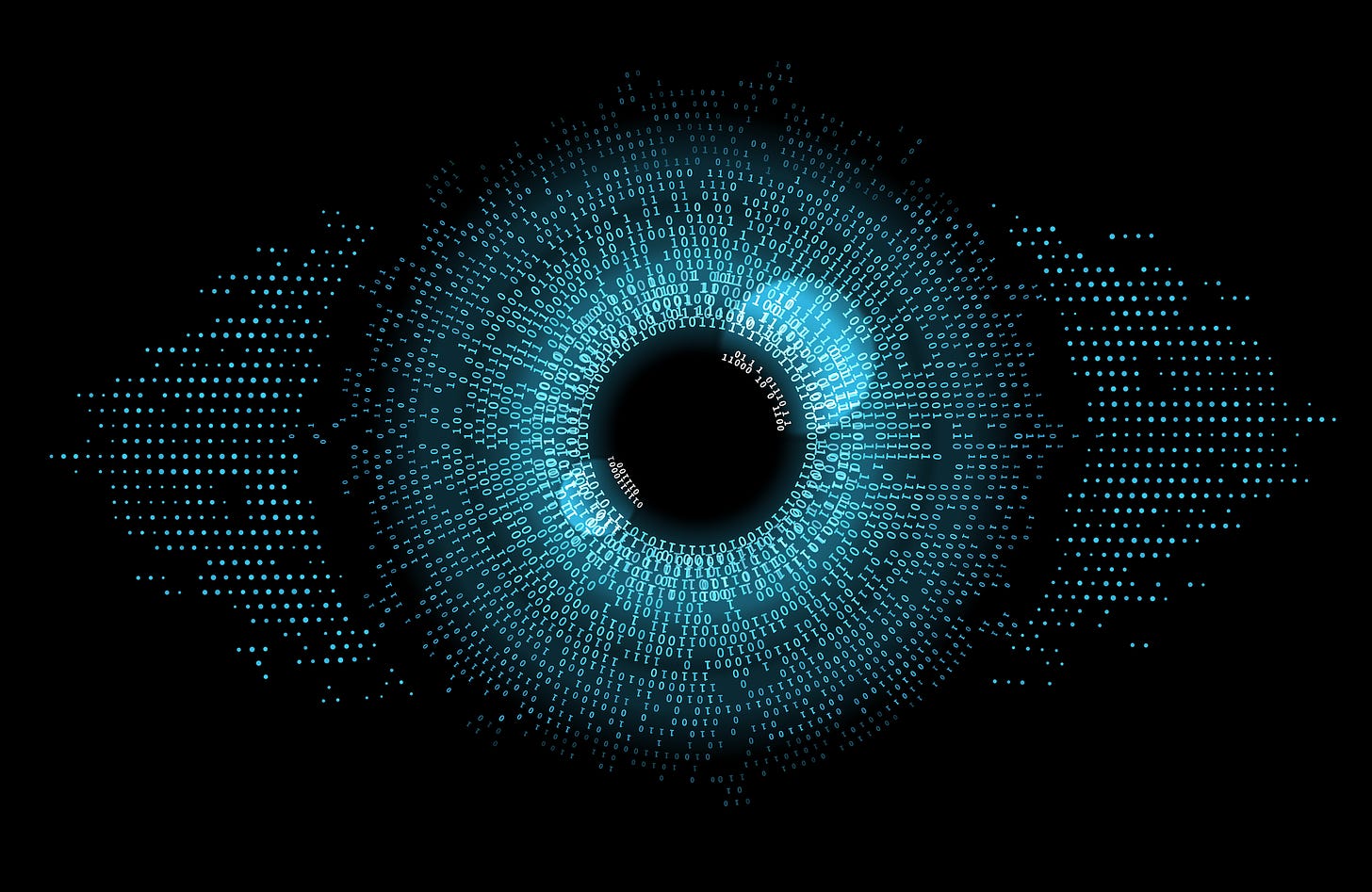La guerra informativa è oggi una delle principali minacce dirette verso le democrazie liberali occidentali. Il Research Report dell’Hybrid CoE rappresenta una delle più approfondite analisi comparate sullo stato delle politiche di contrasto alla disinformazione nel contesto euro-atlantico. Ecco cosa dice
Da oltre un decennio il dominio informativo è diventato terreno di conflitto sistematico tra democrazie occidentali e potenze revisioniste. Dal 2013-2014, con la Rivoluzione della dignità a Kyiv e l’annessione della Crimea, Mosca ha rilanciato un’offensiva cognitiva quotidiana e pervasiva che non ha più conosciuto tregua. Da allora, la disinformazione si è consolidata come strumento a basso costo e ad alto impatto, capace di produrre effetti destabilizzanti sia in termini elettorali che di coesione sociale. A distanza di dieci anni, un nuovo rapporto del Centro di Eccellenza per il contrasto alle minacce ibride di Helsinki (Hybrid CoE) misura lo stato di preparazione del fronte euro-atlantico. Ne emerge un quadro complesso, nel quale le esperienze accumulate convivono con criticità strutturali ancora irrisolte.
Quattro linee per la difesa
Il rapporto utilizza la griglia concettuale delle “Four Lines of Defence”: rilevamento e debunking tempestivo delle narrazioni ostili, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, rafforzamento delle vulnerabilità sistemiche e imposizione di costi agli aggressori.
La prima linea, quella della situational awareness, appare la più consolidata. L’83% dei rispondenti riconosce la disinformazione come minaccia significativa alla sicurezza nazionale, oltre il 70% dei governi monitora sistematicamente campagne esterne, e una percentuale simile osserva quelle domestiche. Russia e Cina risultano gli attori più monitorati, seguiti da Iran, jihadisti e Corea del Nord. Tuttavia, solo cinque Paesi hanno metodologie avanzate per l’individuazione di campagne inautentiche, due possiedono metriche per valutarne l’impatto persuasivo e tre dispongono di sistemi per stimarne la pericolosità. Il gap metodologico compromette la possibilità di calibrare risposte proporzionate. Inoltre, dal report emerge come soltanto sette Stati hanno adottato strumenti di intelligenza artificiale, nonostante le evidenze dimostrino la loro efficacia nel rilevamento di bot e contenuti sintetici.
La seconda linea, l’awareness raising, è implementata da due terzi dei governi attraverso campagne pubbliche, ma l’efficacia è percepita come limitata. Pochi Paesi pubblicano report aperti sulle tendenze disinformative, e solo quattro hanno redatto liste ufficiali di fonti manipolative. Gli strumenti restano prevalentemente tradizionali, raccontano gli analisti dell’Hybird CoE, con scarso ricorso a tecniche innovative di pre-bunking o ingaggio di influencer. Inoltre, il target principale resta il “pubblico generale”, con scarsa attenzione a gruppi vulnerabili o marginalizzati, particolarmente esposti agli attacchi cognitivi.
La terza linea, il repairing weaknesses, evidenzia invece carenze gravi. Meno della metà dei Paesi ha integrato programmi di alfabetizzazione mediatica nei curricula scolastici; la fiducia istituzionale non è oggetto di strategie sistematiche e la polarizzazione resta un vulnus sfruttabile dagli aggressori. Anche la cooperazione con le piattaforme digitali è episodica e poco strutturata.
Infine, la quarta linea, ovvero l’imposizione di costi agli aggressori, risulta essere la più fragile. Solo un quinto degli Stati ritiene di avere un quadro normativo adeguato, mentre la maggioranza si limita ad applicare leggi preesistenti su hate speech o incitamento all’odio. Strumenti più incisivi come sanzioni finanziarie, oscuramento di siti, etichettatura delle fonti o esclusione da conferenze stampa restano marginali. Dal report emerge come la cooperazione con le piattaforme social è limitata. Un terzo dei governi segnala rapporti operativi con i provider, benché i dati provenienti dai social siano considerati essenziali per identificare gli attori manipolativi.
Il fronte cognitivo occidentale
Secondo i dati riportati dal report, solo sei Paesi hanno istituito agenzie specifiche, mentre la maggioranza adotta un approccio decentrato, con rischi di duplicazioni e gap di coordinamento. Nonostante il 70% indichi la presenza di meccanismi di cooperazione interministeriale, meno del 40% considera adeguata la comunicazione pubblica delle politiche di contrasto, con conseguente difficoltà nel consolidare la fiducia sociale, fattore chiave nella resilienza cognitiva.
L’asimmetria con gli aggressori informativi
Gli attori ibridi autoritari continuano a investire più risorse delle democrazie nel dominio informativo. Il documento mette nero su bianco che Mosca e Pechino restano i principali attori monitorati, seguite da Iran, attori non statali (cellule jihadiste) e Corea del Nord. Ma l’elemento di maggiore criticità risulta essere la capacità di imporre costi concreti ai responsabili o, addirittura, di attribuire responsabilità e accountability.
Ci sono esempi virtuosi. In Canada, dopo le polemiche sulle interferenze straniere nelle elezioni federali, una commissione d’inchiesta ha formulato 51 raccomandazioni per rafforzare la difesa cognitiva, dal monitoraggio centralizzato a un numero verde per segnalare tentativi di influenza. Nei Paesi nordici, già dal 2017, politici locali vengono formati a riconoscere le manipolazioni, mentre la Svezia ha creato un’Agenzia per la difesa psicologica che produce manuali per giornalisti. Kyiv, in prima linea, ha esteso la formazione anche alle autorità locali con la sua “School for Strategic Communications”, dimostrando che la resilienza informativa non può restare confinata alle capitali. Il centro di analisi europeo, conclude avvisando che, finché gli aggressori investiranno più risorse di quante ne mobilitino le democrazie, la sproporzione resterà. E l’Europa continuerà ad inseguire. Occorrono più strumenti.