Ambientato nella Messina del secondo dopoguerra, Giuseppe Marchetti Tricamo, saggista e già direttore di Rai Eri, racconta a Formiche.net il suo primo romanzo, “Sciabica. Storia siciliana di vizi, virtù, trappole, passioni e disincanti”, edito da Ibiskos-Ulivieri
“La nostra vita è quella che ricordiamo, l’altra, la parte dimenticata, sembra non appartenerci più. E prima che la mia memoria avvizzisca e i ricordi insieme alle emozioni, vengano dispersi e prima di essere costretto – per esercitarla – a dover ricorrere alla cura suggerita da Umberto Eco, cioè, imparare tutti i versi de La vispa Teresa ho affidato a questo libro i miei ricordi di vita, di letture, di studi un po’ lontani nel tempo”. Giuseppe Marchetti Tricamo, saggista, già direttore di Rai Eri e docente di Editoria all’Università Sapienza di Roma racconta così a Formiche.net cosa lo ha spinto e perché a mettere nero su bianco il suo primo romanzo.
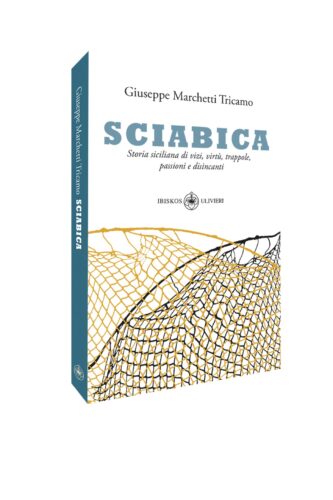 “Sciabica. Storia siciliana di vizi, virtù, trappole, passioni e disincanti”, edito da Ibiskos-Ulivieri, è in effetti quel tuffo nella memoria del Secondo dopoguerra dell’isola dove i profumi, i sapori e i suggestivi luoghi vengono narrati da un autore che ben li conosce. Ambientato nella Messina di quell’epoca, Marchetti Tricamo intreccia storia e mistero con una scrittura molto elegante che immerge il lettore, anche digiuno di quei posti, in un’atmosfera che diventa vivida e familiare.
“Sciabica. Storia siciliana di vizi, virtù, trappole, passioni e disincanti”, edito da Ibiskos-Ulivieri, è in effetti quel tuffo nella memoria del Secondo dopoguerra dell’isola dove i profumi, i sapori e i suggestivi luoghi vengono narrati da un autore che ben li conosce. Ambientato nella Messina di quell’epoca, Marchetti Tricamo intreccia storia e mistero con una scrittura molto elegante che immerge il lettore, anche digiuno di quei posti, in un’atmosfera che diventa vivida e familiare.
Sciabica è un romanzo, la sua prima opera narrativa, ma in fondo è anche un’accurata ricostruzione storica. Che tipo di ricerche ha svolto?
Il Nobel Gabriel Garcia Márquez, uno dei miei scrittori preferiti, in Vivere per raccontarla afferma che la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Un pensiero che è condiviso dal catalano Carlos Ruiz Zafón che dice che noi siamo quello che ricordiamo. Quindi, la nostra vita è quella che ricordiamo, l’altra, la parte dimenticata, sembra non appartenerci più. E prima che la mia memoria avvizzisca e i ricordi insieme alle emozioni, vengano dispersi e prima di essere costretto – per esercitarla – a dover ricorrere alla cura suggerita da Umberto Eco, cioè, imparare tutti i versi de La vispa Teresa ho affidato a questo libro i miei ricordi di vita, di letture, di studi un po’ lontani nel tempo. Ne è scaturita una mescolanza di storia, di realtà e di fantasia. Mescola, mescola… temevo che il libro fosse diventato un intruglio. Oggi, invece, mi sento un po’ tranquillizzato e, anzi, resto fortemente sorpreso per i molti commenti lusinghieri.
Un mix fra storia, fantasia e ricordi personali quindi.
Il racconto è appunto come una sciabica, raccoglie fatti, personaggi, momenti familiari, sentimenti. Il tutto si è talmente amalgamato da non riuscire a separare i vari componenti. Sappiamo bene che, secondo un’apprezzabile tradizione letteraria italiana, il narrare non è soltanto narrare una storia, ma narrarla sullo sfondo generoso della storia. Dedicandomi alla scrittura di Sciabica, mi sono tornati utili i miei approfondimenti di storia diventati in passato alcuni saggi editi da Mondadori.
Messina è la sua città natale. Una città che ha avuto tante vite. Da Garibaldi, al terribile terremoto, fino alla Seconda guerra mondiale. Si può dire che in qualche modo è la vera protagonista del libro?
Ho scritto questo libro anche per mantenere attivo il mio rapporto con la mia terra di origine: Messina una città allo stesso tempo tormentata. Una città dilaniata (le cannonate dei Borbone, i Vespri, il terremoto) ma sempre orgogliosamente risorta (Garibaldi e Mazzini e il piano della ricostruzione che ne ha fatto un’armoniosa città giardino), della quale amo tutto, anche le giornate sferzate dal vento di scirocco. I luoghi, i monumenti, i palazzi, ogni angolo della città fanno riaffiorare quella memoria storica normalmente fredda ma che nel libro si fa calda per effetto della gente che vive in un affascinante labirinto di emozioni, di odori. Un continuo flusso, quindi, di memorie storiche, urbane, per la prima volta disvelate in un percorso che trova in un emblematico personaggio, di nome don Pietro, la guida esperta e nostalgica di un viaggio sentimentale.

Da quanto tempo è lontano dalla Sicilia e quale è il ricordo più impresso nella sua memoria che ha della sua città?
Lo troviamo nell’incipit del libro. Lo Stretto con la sua luce, i suoi colori, i suoi profumi, le sue albe e i suoi tramonti e la vita che si svolge intorno. La pesca del pescespada. I traghetti che si incrociano fischiando su quel mare color del vino, direbbe Sciascia. Un mare che ci ricorda l’Horcynus Orca e ’Ndria Cambria, come Ulisse alla ricerca della sua Itaca. Ma il ricordo “storico” indelebile è rappresentato da sei bandiere – tra esse, il Tricolore a fare gli onori di casa – che sventolavano sulla facciata neoclassica di palazzo Zanca. Erano mosse da un leggero vento di grecale. Sei signori in elegante doppiopetto di grisaglia scesero lo scalone dedicato ad Antonello, per concedersi ai flash dei fotografi. Si chiamavano Spaak, Hallstein, Pinay, Bech, Martino e Beyen e rimasero in posa in riva allo Stretto. Era l’inizio del mese di giugno del 1955. Io ero ragazzo e non mi resi conto, al momento, di essermi imbattuto in un momento storico. Quei signori erano i ministri degli Esteri di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Italia e Paesi Bassi e in quel palazzo stavano ponendo un’altra pietra alle fondamenta della costruzione europea.
Perché questo titolo “Sciabica”?
Ne ho brevemente accennato prima. “Sciabica”, anche perché la pesca con la sciabica mi ha sempre affascinato. Ricordo i pescatori che si dannavano su quella rete che sembrava imprigionasse tutto il mare. La rete si stringeva sempre più fino a formare un piccolo cerchio e alla fine dentro trovavano un modestissimo pescato. Sciabica anche come metafora della vita di don Pietro.
Il racconto non si caratterizza soltanto per il flusso di memorie storiche, urbane in un percorso coinvolgente ma anche per un sottile fil rouge di un enigma che andrà disvelato.
Ha scelto di raccontare gli odori, i sapori e gli umori siciliani anche in dialetto. Con un glossario alla fine del testo. Quanto è stato importante ai fini della narrazione?
Il linguaggio usato è un intreccio di siciliano e di italiano. Il dialetto è il sale che dà sapore e forza al racconto. E poi, confesso, alcuni personaggi del libro hanno preteso di parlare in dialetto e ho dovuto accontentarli perché per loro sarebbe stato impossibile raccontarsi in italiano.
Quanto, secondo lei, è ancora importante coltivare le radici linguistiche del dialetto.
Vivere le radici è l’opposto del localismo folcloristico. Sentirsi saldamente legati al luogo in cui si è venuti al mondo. Amare la sua storia, la sua letteratura, le sue tradizioni, i suoi colori, i suoi suoni, i suoi sapori. È essere se stessi, in sintonia con il luogo natio o che ci ha adottato. Senza forzature. Per essere se stessi, sempre.
Manteniamo la nostra identità, coltiviamo le nostre radici linguistiche, e non dobbiamo disperdere nulla della nostra storia, ma continuiamo a riversarla in un contenitore più ampio.
Nel tempo, è stato cancellato il dialetto inteso come discriminazione sociale, sfruttamento, emarginazione. Ha continuato invece, e dobbiamo esserne contenti, a fiorire come contributo alla vivacità della nostra letteratura. Il doppio registro lingua-dialetto è il tipico dualismo di molti scrittori.
Don Pietro de Guevara, personaggio affascinante, racconta la nobiltà siciliana. Ma il suo ritratto in fondo narra soprattutto, a mio avviso, la nobiltà d’animo. Forse è questo che il nipote Filippo, oltre alla Terra, si porta dentro quando “lascerà” la Sicilia?
Ci sono parole che rischiano di sparire. Altruismo, bontà, carità, dignità, ideale, etica, rispetto, uguaglianza, giustizia: sono parole che rischiano l’oblio perché i comportamenti dell’essere umano non ne rivendicano l’uso. La nostra è una società che non riconosce più il valore e il significato di queste parole. Don Pietro ne faceva oggetto dei suoi comportamenti, della sua vita. Fu anche un precursore delle battaglie ambientali e cercò di ostacolare il sacco edilizio dei dolci pendii dei peloritani che fecero da sfondo alle tele di Antonello da Messina.
E i cantastorie cantarono e continuano a cantare: Don Pietro de Guevara, un gran signore/fu duca di Belviso e di Ucria Barone/conobbe paesi genti /fimmini di ieri/donò i suoi campi ai mitateri.
Sì, sì, propria una grande eredità morale di valori e di conoscenza che il nipote Filippo si porterà dietro, lasciando l’isola, pur mantenendo legami antichi e forti, per il continente. Perché dalla Sicilia non si scappa.








