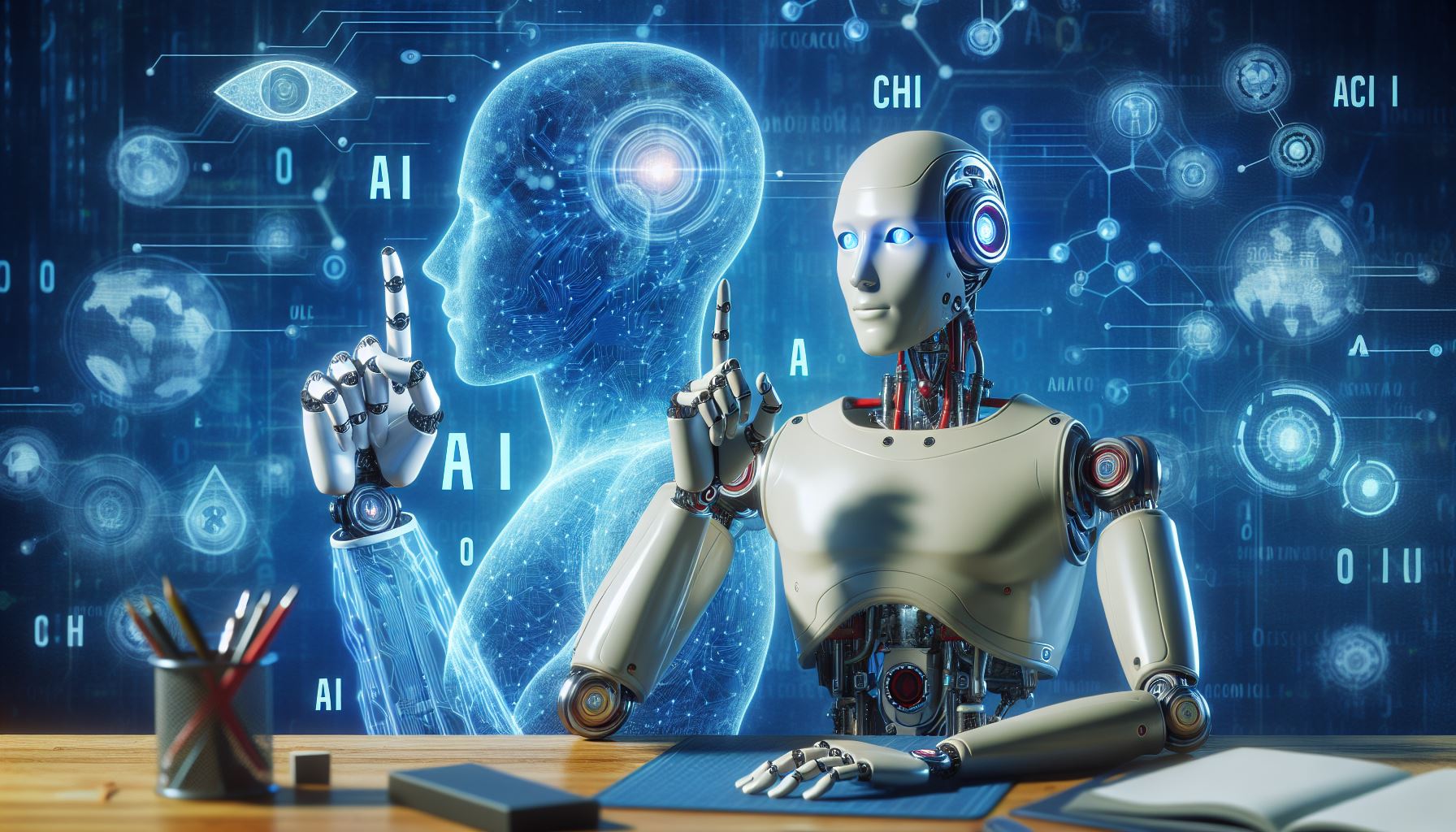La comparazione fra il documento della Casa Bianca “Winning the Race” e il “Piano d’azione per la governance globale dell’intelligenza artificiale” altrettanto recentemente diffuso da Pechino evidenzia che nella competizione per la leadership globale nell’IA le due superpotenze adottano filosofie e metodologie operative fondamentalmente diverse ma finalizzate allo stesso obiettivo: la creazione di sfere di influenza tecnologica. L’analisi di Andrea Monti, docente di Identità digitale, privacy e cybersecurity nell’Università di Roma-Sapienza
Sintetizzando al massimo il contenuto dei due documenti, si può affermare che gli Stati Uniti perseguono una strategia esplicita di dominio tecnologico dell’AI tramite un programma che mette al primo posto il mercato, sfruttando il proprio settore privato e promuovendo l’innovazione open source nel quadro dei “valori americani”. Questo significa inserire strutturalmente Big Tech all’interno della strategia, affidandole il compito di “colonizzare” le infrastrutture di altri Paesi impedendo —o comunque rallentando— lo sviluppo di tecnologie, anche europee, concorrenti. Mentre la Cina, al contrario, promuove una strategia di attacco ai mercati globali tramite la disponibilità di tecnologie AI a basso costo in grado di competere con quelle occidentali. Dunque, grazie a una radicata dimestichezza con i principi neoconfuciani, l'”apertura” e la “cooperazione” poste alla base del documento strategico di Pechino si traducono in una forma di colonialismo tecnologico non dissimile da quello Usa, diretto a stabilire un’influenza gerarchica sulle economie emergenti e, potenzialmente, su quei Paesi occidentali che non sono pienamente schierati con il blocco atlantico.
Gli Usa: potenziamento interno e riduzione dell’autonomia degli Stati all’interno della propria sfera di influenza
La strategia statunitense è estremamente chiara e non fa mistero della volontà di raggiungere il dominio sull’AI e sul suo impiego con qualsiasi mezzo incluso —come dimostra la trattativa sui dazi— il ricorso alla forza anche nei confronti dei Paesi likeminded.
Dunque, da un lato, sul fronte interno sarà avviato un processo di sburocratizzazione e deregulation sull’intera filiera dell’AI, dalla creazione delle infrastrutture, al riutilizzo dei dati (il che, inevitabilmente, dovrà comportare l’apertura di un altro fronte nello scontro con la Ue, che da tempo sta cercando di imporre limiti all’accesso di Big Tech ai dati dei cittadini degli Stati membri). Parallelamente, e senza ipocrisie, la strategia prevede esplicitamente lo sviluppo di applicazioni belliche dell’intelligenza artificiale estese fino alla biosecurity (che si potrebbe anche tradurre come difesa da agenti patogeni e dunque “guerra batteriologica”).
Il fronte esterno, come già accennato, è affidato innanzi tutto al presidio di Big Tech e delle AI company che rappresentano la punta di lancia il cui compito è “occupare” commercialmente le infrastrutture straniere, così rendendo antieconomici gli investimenti in tecnologie nazionali, secondo una dinamica peraltro non estranea anche ai rapporti tecnologici fra Paesi della Ue. La seconda linea di azione riguarda il controllo sull’accesso alla conoscenza per lo sviluppo delle tecnologie AI. Questo può significare messa a disposizione dei partner stranieri di tecnologie sub-ottimali rispetto a quelle disponibili, espansione dei divieti di esportazione di tecnologie dual-use e limitazione all’ingresso nella comunità scientifica Usa.
La Cina: cooperazione gerarchica e colonialismo tecnologico “aperto”
La strategia cinese presenta un approccio sfumato che, pur enfatizzando all’esterno la cooperazione e l’apertura, serve implicitamente un obiettivo geopolitico a lungo termine: stabilire la leadership tecnologica attraverso un sistema di valori diverso da quello occidentale e basato sulla controversa categoria degli “Asian Values”.
L’approccio della Cina alla governance dell’IA è profondamente radicato in una filosofia del rule-by-law in cui le norme giuridiche sono modellate e adeguate per allinearsi alle esigenze politiche e ai valori definiti dal Partito Comunista Cinese, invece di fungere da limite invalicabile al potere dello Stato (rule-of-law). Questa visione è basata su un’idea —per così dire— “laica” della legge, scevra da limitazioni morali e funzionale all’esercizio del potere, basata sulla prevalenza della funzione pubblicistica delle norme sugli interessi del singolo. Questo quadro incorpora, come detto, i principi neoconfuciani, secondo i quali l’armonia e l’ordine sociale si raggiungono attraverso il rispetto morale dei valori definiti dallo Stato, riducendo così la dipendenza dalla “mera” legislazione. La promozione dei concetti di armonia e ordine sembra dunque orientata a costruire un sistema di riferimento culturale e geopolitico unificante nell’Estremo Oriente, posizionando implicitamente Pechino come arbitro di questi valori e favorendo una forma gerarchica di cooperazione con (almeno alcuni fra) i paesi asiatici sinicizzati.
Mentre gli Stati Uniti considerano l’open source uno strumento per l’innovazione indipendente, la Cina “arma” l’open source come leva geopolitica. Il “Piano d’azione” invita ad aderire allo spirito di apertura e condivisione, a costruire piattaforme di cooperazione internazionale e a promuovere comunità e piattaforme “libere”. Ma questa “condivisione aperta delle risorse di base” (ad esempio, documenti tecnici, documenti di interfaccia) e il rafforzamento dell’“ecosistema open source” mirano a, o comunque hanno come effetto quello di abbassare la soglia per l’accesso all’innovazione tecnologica per altri Paesi, in particolare nel Sud del mondo.
Una strategia del genere consente alla Cina di fornire alternative alle tecnologie occidentali, favorendo la dipendenza di fatto dal proprio ecosistema al posto del controllo diretto dell’Occidente. Lo sviluppo da parte di Huawei di HarmonyOS Next e della sua versione open source, OpenHarmony, ne è un esempio, dato che offre un ecosistema alternativo ad Android e aumenta potenzialmente il potere negoziale della Cina con i Paesi che in precedenza dipendevano infrastrutture occidentali. Questo approccio può diventare particolarmente attraente per quei Paesi che non sono in grado di sviluppare autonomamente soluzioni high-tech, creando di fatto una forma di “colonialismo tecnologico” in cui altre nazioni costruiscono da soli la propria dipendenza dalle infrastrutture, dai componenti e dagli standard cinesi.
Infine, in continuità con le norme sulla protezione dei dati e quelle sulla sicurezza nazionale, la strategia cinese pone un’enfasi significativa sulla sovranità dei dati.
Similarità, differenze e implicazioni strategiche
L’analisi comparativa dei due documenti rivela una critica comunanza di obiettivi, a fronte di differenze altrettanto critiche per il loro impatto sulle relazioni internazionali.
Sotto il primo profilo, entrambe le superpotenze basano le proprie strategie sull’affermazione dei propri valori, sul colonialismo tecnologico e sul controllo sui dati. Il che si traduce nella costruzione di sfere di influenza all’interno delle quali esercitare, direttamente o indirettamente, un ruolo condizionante sulla sovranità dei Paesi che ne fanno, rispettivamente, parte.
Si può discutere del fatto che gli Stati Uniti difendono le libertà individuali e l’innovazione guidata dal mercato, mentre la Cina, al contrario, dà priorità all’armonia collettiva e alla stabilità dello Stato, ma in termini geopolitici la sostanza dei fatti non cambia. Sebbene, infatti, entrambi sostengano la volontà di “aprire” le tecnologie AI, tramite un’innovazione senza ostacoli e l’accesso al mercato per i propri prodotti (Usa) o l’offerta di alternative accessibili ed economiche (Cina), l’effetto finale è lo stesso: coltivare influenza e creare dipendenze tecnologiche, sulle quali costruire un nuovo ordine mondiale.
Un quadro del genere, evidentemente, non è dipinto in bianco e nero. Entrambi i Paesi devono confrontarsi, quanto agli Usa, con le inevitabili tensioni fra sicurezza (che porta alla chiusura) e mercato (che richiede invece apertura) e, quanto alla Cina, con la necessità di reagire in modo calibrato alle azioni occidentali in aggiunta a quella della creazione della propria sfera di influenza.
Su tutto, poi, pesa il monito del generale von Moltke: nessun piano resiste al contatto con la battaglia.
Il ruolo assente dell’Unione europea e quello degli altri attori internazionali
Nella gara senza esclusione di colpi per occupare il vertice di questo nuovo ordine mondiale, il grande assente è l’Unione europea, paralizzata da regolamenti elefantiaci e burocratici e hegelianamente convinta di poter piegare la realtà internazionale alle proprie decisioni. Né Washington DC né Pechino considerano Bruxelles un interlocutore strategico, visto che le sue politiche non producono influenza esterna e generano inerzia sul fronte interno. Non è un caso, infatti, che mentre la ricerca europea continua a fare passi importanti nell’avanzamento teorico dell’AI, la capacità di competere efficacemente sui mercati esteri e la ricaduta industriale ed operativa per cittadini, imprese ed istituzioni siano ancora di là da venire.
Quanto agli altri attori internazionali, limitandoci a Giappone e India che per ragioni diverse hanno un ruolo importante nei rapporti con la Ue, il primo ha appena tradotto in legge la propria politica per lo sviluppo delle infrastrutture IA, adottando una scelta che privilegia il medio-lungo periodo e un approccio basato sull’attribuzione all’esecutivo del potere di compiere scelte strategiche, mentre l’India ha da pochissimo rilasciato il proprio documento strategico sull’argomento, dal quale emerge la volontà di Nuova Dehli di concentrarsi sull’uso dell’AI nel fronte interno e puntare —come già accade in altri settori— nel trasformare l’India in un “AI Garage”, una fabbrica di intelligenza artificiale da mettere a disposizione dei Paesi emergenti.
Per quanto ambiziosi e potenzialmente in grado di ridisegnare la geopolitica dell’AI, questi programmi sono ancora ad uno stato meno che embrionale e quindi non potranno avere un’efficacia diretta in quella che, per il momento, si configura ancora come una corsa con due soli concorrenti nella quale —va ricordato— non ci sono arbitri indipendenti a decidere chi deve arrivare secondo.