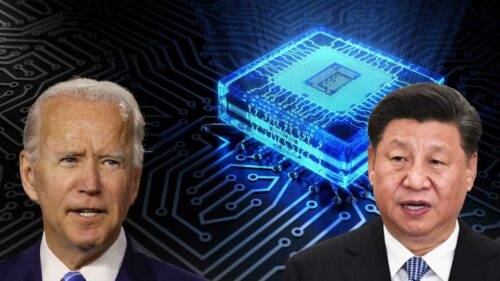Superato l’errore di comunicazione del nuovo Redditometro, derubricato a sistema di controllo per i grandi evasori, la riforma Leo-Meloni riprende la sua road map con il fermo proposito di rispettare i termini stabiliti e di completare l’opera in 24 mesi. A dieci mesi di distanza, con 8 decreti-legge approvati in via definitiva e altri 5 in dirittura d’arrivo, il nuovo sistema prende forma. L’analisi di Domenico Fracchiolla, professore di Storia delle Relazioni internazionali Università Mercatorum, Luiss
La riforma fiscale, considerata necessaria da tutti i governi della Seconda Repubblica, ma mai affrontata in modo organico, salvo piccoli aggiustamenti e un intervento parziale di Giulio Tremonti, è uno dei pilastri che qualificano il governo Meloni, prima ancora che sul piano economico e strettamente fiscale, sul piano politico e culturale. Si tratta della terza grande riforma organica del sistema fiscale della Repubblica, dopo la riforma Vanoni degli anni ‘50 e la riforma Visentini degli anni ‘70. Superato l’errore di comunicazione del nuovo Redditometro, derubricato a sistema di controllo per i grandi evasori, la riforma Leo-Meloni riprende la sua road map con il fermo proposito di rispettare i termini stabiliti dalla Delega del Governo del 29 agosto 2023 di completare l’opera in 24 mesi. A dieci mesi di distanza, con 8 decreti-legge approvati in via definitiva e altri 5 in dirittura d’arrivo, il nuovo sistema prende forma.
La cultura economica dell’equità perseguita con spesa pubblica sostenibile grazie al maggiore sviluppo (anche per l’imposizione fiscale competitiva) segue una strada opposta a quella della equità per redistribuzione, della crescita per il moltiplicatore della spesa pubblica a indebitamento crescente o, nel versante opposto, del rigore dei conti pubblici a tassazione alta (e crescita bloccata).
L’impresa privata e il cittadino sono posti al centro del sistema, che scommette sul talento degli individui e sulla capacità di lavorare e di realizzare i propri obiettivi di vita. In questa direzione, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, architetto del nuovo sistema, dopo aver lavorato soprattutto sulle misure procedurali, si sta concentrando sulla revisione dell’imposizione fiscale sul ceto medio, atteso da molti da decenni. Entrare nel merito della riforma richiede necessariamente due considerazioni preliminari.
In primo luogo, la variabile di contesto: la profonda incertezza e instabilità internazionale si inseriscono all’interno dei grandi processi di cambiamento che impattano sull’economia italiana, dal ritorno della geopolitica del Mediterraneo alla necessità di concludere la guerra in Ucraina, dalla Twin transition all’esecuzione del Pnrr, dalle nuove regole del Patto di Stabilità (che fissa la spesa pubblica per 5 anni) alla Zes, dalle riforme sulla competitività ad una nuova cultura d’impresa, alla promozione della produttività. Questi cambiamenti avranno un impatto importante che potrebbe annullare, distorcere o approfondire gli effetti della riforma fiscale. L’ambizione di curvare l’impatto in effetti positivi esprime non solo la volontà di costruire un diverso rapporto tra fisco e cittadini, ma evidenzia anche il proposito storico di contribuire alla modernizzazione dell’economia italiana nel suo complesso.
In secondo luogo, le critiche che riceve la riforma da più parti sono spesso viziate da un forte pregiudizio ideologico, perché ferme al pensiero unico della neutralità tecnocratica dei provvedimenti, che in realtà esprimono culture politiche diverse. Per quanto complesso, il moloch del sistema fiscale non appartiene, o almeno non dovrebbe appartenere, ad un unico sistema di valori e di culture politiche uguali per tutti, per cui gli interventi hanno tutti gli stessi obiettivi di fondo e le uniche differenze risiedono nella (in)capacità tecnica (soprattutto dei governi di centro destra) di riformare gli aspetti devianti per raggiungere equità, redistribuzione e sviluppo.
Nella Seconda Repubblica dell’alternanza, le culture social – democratica e liberale – conservatrice dovrebbero esprimere riforme fiscali alternative, espressioni di diverse politiche economiche e visioni di paese. Invece questo non accade. Sminuire la riforma, giudicandola una “non riforma”, come ha fatto Romano Prodi in una recente intervista da Corrado Formigli, o come una promessa mancata perché focalizzata principalmente sulle procedure, come sostenuto da Tito Boeri e dai liberali neocentristi di sinistra come Marattin, è fuorviante e non restituisce la complessità della questione.
La critica più autentica, ma ugualmente infondata, proviene dalla sinistra radicale che rispolvera l’opposizione ai neoconservatori e alla rivoluzione liberale di Berlusconi, di cui la riforma sarebbe la rappresentazione. Stefano Ungaro sul Manifesto parla di piena realizzazione di un’egemonia culturale, frutto di un’ideologia trentennale, che vede il pubblico come sempre inefficiente e corrotto e il privato come efficace e positivo. La critica è mal posta perché persistenze di egemonia culturale si riscontrano oggi, ma nella cultura statalista di sinistra, fortemente radicata in diversi strati della pubblica amministrazione, nei gangli della cultura e dell’Accademia. Il sistema consociativo ad economia mista della Prima Repubblica, a livelli di tassazione crescenti per coprire la spesa pubblica inefficiente ed esplosiva ha lasciato una profonda impronta, la cui eredità è ancora forte nel tessuto socioeconomico e culturale del Paese.
Passando ai contenuti, le nuove misure procedurali adottate rappresentano una parte fondamentale della riforma di tutto il sistema economico, non solo della parte tributaria, poiché consolidano la certezza del diritto e rafforzano la qualità della democrazia italiana. Il sistema è migliorato, secondo queste direttrici, grazie a diversi provvedimenti, ispirati ad una logica comune.
In primo luogo, il concordato preventivo biennale, che pone le basi per una nuova cultura fiscale, basata su accertamento ex ante, fiscal planning e collaborazione tra fisco e contribuente. In secondo luogo, il nuovo contenzioso, basato sulla conciliazione, che alleggerisce l’intero sistema giudiziario, appesantito dal 44% di controversie civili pendenti in Cassazione di natura tributaria, come osserva Gianluca Zapponini su Formiche.net. In terzo luogo, la riforma delle sanzioni e le nuove riscossioni, che allineano le sanzioni italiane a quelle europee, superando la logica punitiva da esproprio, lesiva della libertà d’impresa. Inoltre, consentono di eliminare dal magazzino dei debiti tributari una parte dei crediti ormai inesigibili (1.185 miliardi in totale) che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà mai recuperare. Infine, il nuovo calendario fiscale, le premialità, la depenalizzazione dei contribuenti in compliance e la cedolare secca agli immobili commerciali promuovono la competitività, l’efficienza e la produttività dell’intero sistema economico. Su questo impianto “procedurale”, la “forma” della riforma è già “sostanza”.
Il passaggio da quattro a tre aliquote della Riforma Irpef (23% per i redditi fino a 28 mila euro, 35% per i redditi compresi tra 28 mila euro e a 50 mila e 43% per i redditi che superano 50 mila euro) con la promessa di passare a due aliquote e – in prospettiva meno realistica – ad una sola aliquota, apre la strada all’eterno ritorno della classe media, nerbo di ogni democrazia liberale di massa, senza la quale i sistemi democratici sono destinati a stagnazione e crisi irreversibili. Un dato evidenzia l’importanza di questo provvedimento (come rilevato ancora da Zapponini): la parte più cospicua dell’Irpef è sostenuta proprio dal ceto medio, con 13 italiani su 100 che pagano il 60% dell’imposta. In questa direzione, il viceministro Leo ha dichiarato a margine del convegno alla Camera, che l’obiettivo è ridurre l’aliquota marginale del 43% che pesa molto sulle classi medie e induce l’evasione.
La riforma si propone di risvegliare la speranza e la voglia di scommettere sul futuro, di fermare in Italia gli spiriti più intraprendenti, di realizzare il mai superato sogno americano o semplicemente un progetto di vita, in Italia. D’altra parte, invece, come osserva Serena Sileoni dell’Istituto Bruno Leoni, le politiche del passato recente dei (super)bonus, la spesa pubblica per decenni concentrata su pensioni e stipendi pubblici, la politica sindacale che si occupa solo di licenziamenti e precarietà, alimentano e consolidano la tendenza all’immobilismo e alla conservazione ostinata del passato. Anche se i dati dell’aumento dell’occupazione sono confortanti e la crescita è superiore che altrove, inimmaginabile per l’Italia fino a qualche semestre addietro, la fiducia e la speranza nel futuro sono ancora minime: secondo sondaggi di opinione, l’opportunità maggiore, oggi, per i giovani, è individuata nell’impiego pubblico. Per gli eredi dell’Italia liberale delle professioni, del Risorgimento e del miracolo economico è una tendenza da invertire al più presto.
L’evidente senescenza demografica nasconde una senescenza culturale, che blocca il mercato del lavoro e rallenta tutta l’economia italiana. A parte una corretta comunicazione, serve il coraggio di un’importante azione culturale, che evidenzi i riferimenti dei valori politici liberali e conservatori della riforma. I sentimenti di fiducia e di speranza, la preferenza per investimenti privati e il coraggio di rischiare sono determinati dalla percezione di maggiori opportunità. Un Paese per giovani, non più un Paese solo per vecchi, capace di guardare al futuro e non fermo nella conservazione e sopravvivenza. La storia del libero mercato nelle democrazie avanzate, anche di terza o quarta ondata di democratizzazione, è ricca di successi caratterizzati da sistemi fiscali favorevoli alle imprese, alla concorrenza e all’iniziativa privata, che privilegiano l’attrattività e gli incentivi a fare impresa.
Ad altre latitudini, i meriti in termini di promozione dello sviluppo economico di alcune correnti di pensiero liberiste, ad esempio le riforme neoconservatrici di Margaret Thatcher in Gran Bretagna, la Reaganomics di Ronald Reagan, negli Stati Uniti e i Chicago Boys della Scuola Monetarista di Friedman in alcuni Paesi dell’America Latina e non solo, sono ricordati ancora come storie di successo, senza dimenticarne i limiti. L’indice annuale dell’Economic Freedom del think tank liberista Heritage Foundation, che si occupa di misurare la libertà economica dei singoli Paesi nel tempo, evidenzia proprio queste tendenze storiche. I riferimenti culturali al libero mercato e alla Scuola Austriaca e i suoi epigoni dovrebbero essere valorizzati. Una volta fatta la riforma, bisognerà fare gli italiani (ci perdoni Mazzini).