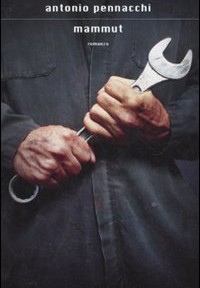La storia è esemplare: a Latina, nel quadro degli interventi che favorirono lo sviluppo del Mezzogiorno, sorge negli anni d’oro del “boom” un nuovo stabilimento che produce cavi di rame; si lavora a triplo turno, di giorno e di notte, e si impara a difendere i propri diritti, a organizzare il consenso dei lavoratori, a gestire i contratti e le lotte. La fabbrica “tira” e il lavoro è garantito, gli operai hanno un Consiglio di fabbrica duro e un “capo” senza paura, Benassa.
La storia di Mammut – il romanzo di Antonio Pennacchi che ora, diciassette anni dopo la prima edizione, Mondadori ripropone (pp. 190, euro 17,00) – è la sua, di un operaio, cioè, che sa comandare, ma che alla fine si convincerà ad andarsene, a mettersi da parte, perché il suo ruolo si è esaurito. La storia di Benassa è la storia di una sconfitta politica, di una crisi esistenziale, di un capovolgimento storico: la lotta operaia finisce in un vicolo cieco e una stagione generosa e persino eroica scolora nella memoria.
Di romanzi di fabbrica ce ne sono stati tanti nel secolo scorso, ma questo è diverso: la fabbrica e gli operai sono raccontati perché appartengono a un mondo che non c’è più, verso il quale è vivo un sentimento di malinconia, ma è impossibile nutrire una vera e propria nostalgia, perché in fondo di essercene liberati siamo anche contenti.
L’operaio Pennacchi, intanto, è diventato dottore, la fabbrica non è più sinonimo di benessere, il padrone è stato costretto alla resa; persino il sindacato ha cambiato l’anima. La lotta, quella vera e dura, non ha più senso, perché l’obiettivo è diventato la difesa del “posto” e così i lavoratori, paradossalmente, diventano dei privilegiati.
Mammut racconta questo capovolgimento di posizioni: inizia nel 1963, quando in quattro e quattr’otto si tirano su, nuovi di zecca, dei capannoni di cemento. Sotto, tutte le stagioni sono uguali e persino le ore del giorno e della notte contano poco perché il ritmo lo dà la produzione con i suoi macchinari.
All’inizio di sindacato non se ne parlava neanche, l’azienda “faceva quello che voleva” e ai renitenti non risparmiava neppure le botte. Poi “arrivò il ‘68” e le cose presero un corso diverso: con l’aiuto degli studenti dopo «sei giorni e sei notti di sciopero a oltranza» vennero le prime conquiste. Qualche anno dopo – nel ‘74 – scoppiò la crisi del petrolio e subito dopo quella dell’azienda, senza soluzione di continuità.
Dopo anni senza ripresa arrivò il botto e il giorno di paga in cassa non c’era una lira: era l’aprile del 1981 e «ci fu la prima occupazione». Sette mesi dopo fu necessario ripetere l’impresa e per spuntarla gli operai assediarono persino la centrale nucleare, col rischio di combinare guai seri.
Questo, della marcia sulla centrale, è l’episodio decisivo di Mammut: Benassa guida l’assalto e non vede l’ora che lo fermino, cerca lo scontro con la polizia che non si fa vedere, scatena gli operai e non sa più come fermarli.
Alla fine l’hanno vinta gli operai, perché interviene lo Stato e la fabbrica è salva, sia pure a ruoli dimezzati; ma chi è stato “capo” durante l’avanzata, quando è il momento di retrocedere si sente un pesce fuor d’acqua e ha solo voglia di mollare.
Sono passati i terribili anni Settanta e la storia della Supercavi, invece di correre diritta verso l’avvenire, ha fatto un cerchio, avvitandosi su se stessa.
In Mammut per la prima volta gli operai si presentano come una specie in via di estinzione, i testimoni di un tempo trascorso, e la fabbrica appartiene a un universo che sta dissolvendosi: Pennacchi con acuta sensibilità e intelligenza se ne era accorto già allora tra i primi.