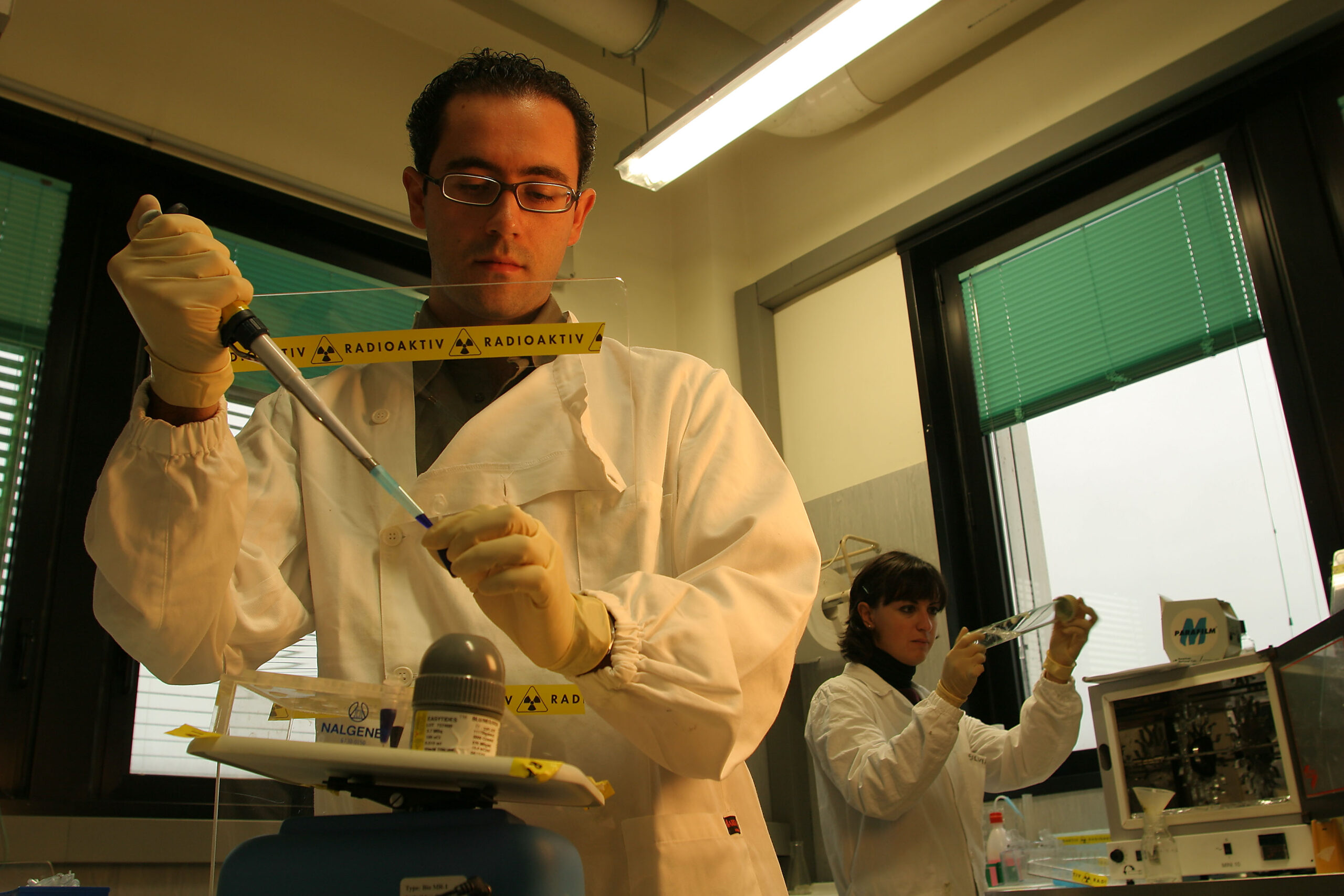Il meccanismo di reclutamento dei docenti universitari italiani ha dei riverberi sulla qualità degli scienziati selezionati? Se lo sono chiesto due ricercatori, Daniele Checchi e Stefano Verzillo, in un paper discusso qualche giorno fa nella sede di Bankitalia: ragionando sul fatto che il decentramento delle procedure di reclutamento a livello locale, introdotto più di un decennio fa in Italia (riforma Berlinguer nel 1998), abbia o meno modificato la capacità di ricerca dei docenti selezionati.
Come
Per condurre questa indagine è stato costruito un nuovo insieme di dati di ricerca internazionali per docenti italiani compresi nel periodo 1991-2010 grazie alla versione web di ISI Web of Knowledge, poi abbinato al singolo archivio amministrativo dei professori universitari italiani (assistente, associato e di cattedra) gestita dal MIUR. Il database finale contiene quasi un milione di registrazioni di articoli pubblicati su riviste scientifiche di studiosi italiani nel corso degli ultimi vent’anni. Alcune misure della produttività della ricerca (principalmente sulla quantità, la notorietà e l’impatto delle ricerche pubblicate) sono state calcolate, per ciascun docente, durante il periodo di campionamento.
Risultati
Sono stati estrapolati effetti negativi causati dal decentramento, sulla qualità della ricerca internazionale di ricercatori in termini di quantità, impatto e notorietà dei loro prodotti di ricerca pubblicati. Questo risultato si confronta con i cambiamenti nei criteri di promozione adottati da comitati di selezione nazionali e locali. Esistono risultati contrastanti: un complessivo peggioramento generale del decentramento sulla qualità dei reclutati non è stato chiaramente identificato. Tuttavia differenziando l’analisi per aree disciplinari sono visibili effetti negativi nel comparto scientifico, come Fisica, Chimica e Biologia. Un generale aumento della variabilità dei risultati di ricerca dei professori e promozioni sono associati con alla riforma del decentramento (dove i migliori candidati hanno più probabilità di essere selezionati in dipartimenti di qualità maggiore, rispetto a concorsi nazionali).
Tesi del paper
La tesi proposta dal paper è che le università italiane sono gestite in senso inverso. Mentre un docente giovane, energico e curioso, è tenuto a insegnare a numerosi corsi elementari e sostenere molte sessioni di esami, non ha materialmente lo stesso tempo da dedicare alla ricerca. Man mano che il docente diventa più grande e quindi invecchia, il suo carico didattico è dimezzato, il suo lavoro cartaceo delegato ad assistenti e il suo stipendio raddoppia. Ma non ha più la stessa freschezza per condurre un’attività di ricerca.
ISI-Web of Science
Lo studio ha preso in esame un singolo docente (assistente, associato o di cattedra) che ha operato nel mondo accademico italiano tra il 1991 e il 2010. Nella prima tabella è stato inserito il numero dei professori e la loro presenza nella banca dati ISI-WoS, mentre nella seconda tabella si è dato risalto alla loro produttività annuale. Le due tabelle dicono che l’accademia italiana ha registrato un trend di crescita della produttività registrata in WoS negli ultimi 20 anni.
Il dato nazionale vs locale
L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare se, spostando il docente da un sistema centralizzato ad una procedura di selezione decentrata, cambi la qualità dei candidati idonei a svolgere la docenza. L’analisi fornisce informazioni sulla qualità del reclutamento nelle università italiane negli ultimi due decenni. Emerge che i ricercatori promossi a professori sono più produttivi nel secondo sottoperiodo. Fattori influenti sono la notorietà (misurata dal numero di citazioni ricevute dai loro articoli) e il loro fattore di impatto (misurato per il fattore di impatto medio delle pubblicazioni di cui gli articoli sono stati pubblicati in quell’anno). Per cui i dati sulla “produttività” riguardano fattori diversi e determinai, come le promozioni oltre i potenziali candidati, per tipo di transizioni, per area di ricerca; la produttività scientifica dei professori promossi, le citazioni ricevute da docenti promossi, il fattore di medio impatto di professori promossi. E il tutto al fine di identificare un livello di riferimento, al fine di dare la tendenza. Prendendo ad esempio in esame il suddetto pool di candidati come punto di riferimento, è possibile calcolare la misura della qualità delle promozioni dove la qualità relativa del candidato emerge nel settore della ricerca a tempo.
Diamo i voti
I risultati finali, frutto dell’incrocio tra dati, trend e valori, indicano che non vi sono prove di un declino della qualità delle selezioni dopo la riforma che ha portato ai concorsi locali: la cosiddetta “pendenza” di tali elementi è più bassa nel secondo periodo mentre significativa eterogeneità è evidente per le aree di ricerca, suggerendo differenze a seconda del modello di cooptazione. Viceversa un giudizio complessivo negativo, anche se scarsamente significativo, è dato sugli effetti della riforma per quanto riguarda i fattori bibliografici, associati alle promozioni (a cattedra o associato).
twitter@FDepalo