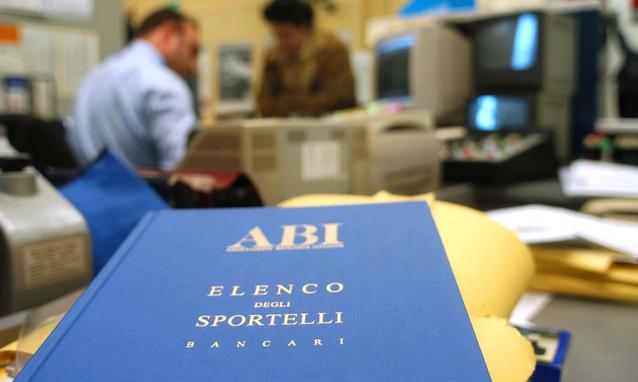Dopo che a metà settembre l’ABI (Associazione Bancaria Italiana, il “sindacato” di banche e banchieri) ha provveduto a disdettare, unilateralmente ed in anticipo rispetto alla scadenza naturale di giugno 2014, il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di categoria ed il Fondo esuberi, principale ammortizzatore sociale del settore, lo scorso 31 ottobre la stragrande maggioranza dei bancari ha incrociato le braccia aderendo allo sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali.
Secondo la Fabi, numericamente la più importante, oltre il 92% delle filiali e delle agenzie sono rimaste chiuse «nonostante banche e gruppi bancari si siano rifiutati di accettare l’adesione allo sciopero di quei lavoratori che avevano già programmato una giornata di ferie», a testimonianza dell’importanza di un evento raro (la categoria non scendeva in piazza da 13 anni) ed ancor oggi in grado di catalizzare l’attenzione verso un comparto che, nell’immaginario collettivo, viene ancora associato a retribuzioni e presunti privilegi ben al di là degli standard nazionali.
Il falso mito del posto in banca
Dopo essere stato un vero e proprio punto di riferimento del lavoro dipendente, ideale di sicurezza e solidità per più generazioni, il posto in banca, simbolo di scalata sociale e raggiungimento dell’agiatezza economica, oggi rappresenta un falso mito: la trasformazione del sistema bancario prima e la crisi finanziaria poi hanno livellato verso il basso retribuzioni e condizioni contrattuali, equiparando così alla stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti la categoria, alla quale si contrappongono le faraoniche retribuzioni milionarie di pochi amministratori delegati e dirigenti esecutivi, i veri banchieri.
Le difficoltà di un mercato di riferimento in cui, dopo il fallimento Lehman Brothers, è venuta a mancare qualsiasi tipo di fiducia, sia tra operatori che da parte della clientela, l’adozione e l’evoluzione di nuove tecnologie che hanno messo in crisi i modelli organizzativi e reso ridondante il numero degli addetti, l’esigenza di tagliare i costi ed ottimizzare il capitale per fronteggiare le rettifiche sui crediti e mantenere i requisiti patrimoniali richiesti dalle autorità di vigilanza, hanno portato negli ultimi anni ad una vera e propria rivoluzione in banca, tanto da spingere il vicepresidente dell’ABI, Francesco Micheli, ad affermare che «Il modello contrattuale non tiene più: ci sono troppi squilibri tra costi e ricavi che non crescono».
I nodi della contesa
I numeri rappresentativi del cambiamento sono importanti: secondo una stima del sindacato autonomo Fabi, tra il 2007 ed il 2011 il sistema creditizio ha perso circa 15.700 occupati, nella gestione dei quali il Fondo esuberi, ammortizzatore sociale di categoria unico nel suo genere perché auto-finanziato da imprese e lavoratori senza intervento pubblico, ha contribuito con la gestione di circa 48.000 prepensionamenti volontari dal 2000 ad oggi.
Quindi il primo vero nodo cruciale della vicenda è dato dal costo del lavoro che, secondo gli ultimi dati ABI disponibili (rapporto dicembre 2012), è secondo in Europa soltanto a quello della Germania ed assorbe circa il 42% dei ricavi, con un “cost/income” (rapporto dei costi rispetto ai ricavi) del 68,1%; da qui la necessità palesata dall’ABI «di dover gestire gli addetti in eccedenza, in crescita progressiva anche in ragione della riduzione dei volumi e delle attività produttive», rendendo «Imprescindibile la ricerca di nuovi equilibri tra livello dei salari e occupazione sostenibile”: un vero e proprio“aut aut” tra revisioni salariali e difesa del posto di lavoro.
A sostegno di questa tesi sembra essersi posto Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, secondo il quale per uscire da cinque anni di crisi e recessione «nel breve termine il recupero di redditività esige interventi decisi sui costi, inclusi quelli del lavoro che rappresentano oltre la metà del totale», in un ambito di modifica generale del sistema che contempli anche «una revisione, anch’essa decisa, delle remunerazioni dell’alta dirigenza»; diversa la posizione del ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, preoccupato dalla necessità di trovare un’intesa per salvaguardare i posti di lavoro e sostanzialmente contrario all’adozione di soluzioni unilaterali per la risoluzione della crisi in atto.
L’altro vero obiettivo dei banchieri riguarda l’ambito contrattuale: non più un unico CCNL a regolamentare quasi “in toto” il settore, quanto piuttosto una sorta di raccolta di principi generali ed a largo respiro da declinare puntualmente con la sottoscrizione di contratti singoli azienda per azienda, che da sempre vede la contrarietà dei sindacati.
La strumentalizzazione della protesta
La disdetta del contratto e le sue condizioni di rinnovo potrebbero poi rappresentare per l’ABI un’efficace leva con cui spingere il Governo a lavorare per legiferare un miglioramento della fiscalità delle perdite sui crediti, per le quali da tempo le banche del Bel Paese lamentano un trattamento peggiore rispetto a quello degli altri stati europei. Senza contare che, l’anno prossimo, gli effetti della revisione degli attivi da parte della BCE (Banca Centrale Europea) potrebbe costringere gli istituti di casa nostra a ricapitalizzazioni che oggi nessuno vuole o può pagare.
Nel frattempo un radicale ripensamento dei canali distributivi sta svuotando le filiali ed intasando i canali alternativi di utenza, ampliando la tradizionale offerta di servizi finanziari a prodotti che nulla hanno a che vedere con il risparmio tradizionale: un disperato tentativo di risollevare la redditività che, per usare le parole di Massimo Restelli pubblicate da Il Giornale, è ormai «ridotta a livelli da prefisso telefonico: 0,47% il ROE (Return On Equity, indice di redditività) dei primi 39 gruppi una volta depurati svalutazioni e avviamenti».
Complice l’accentuarsi della crisi ed una disoccupazione alle stelle, l’implicita minaccia della perdita del posto di lavoro potrebbe spingere i quasi 310mila bancari italiani a proseguire la metamorfosi, in parte già intrapresa, che li trasformerà da consulenti specializzati a meri venditori di servizi, magari estesi all’ambito delle prenotazioni per eventi teatrali, alla vendita di biglietti per tutti i settori dei trasporti se non di abbonamenti telefonici e dell’energia, o fors’anche di servizi immobiliari.
Una de-professionalizzazione che, nei “desiderata” dei banchieri, prelude all’istituzione di due differenti livelli contrattuali, uno per gli addetti del back office ed un altro per la rete di vendita, con gli “over 55” più esperti riconvertiti magari in figure (precarie) simili ai promotori finanziari.
L’altra faccia della medaglia
Che gli interessi dei lavoratori non sempre coincidano con quelli dei datori di lavoro è fatto naturale ed assodato, ma il confronto deve svolgersi ad armi pari ed essere aperto a tutti; oggi questo non avviene, con le banche diventate così importanti nell’economia da non poter di fatto fallire e così influenti da essere in grado perfino di condizionare l’arena politica, instaurando così un vero e proprio capitalismo clientelare: chi si conosce è più importante di cosa si conosce.
Di questo fenomeno abbiamo purtroppo triste conferma dalla continua proliferazione di casi di mala finanza: dalle inchieste della procura di Trani sui derivati emessi da Montepaschi, BNL, Unicredit, Credem e Intesa San Paolo al più recente “nodo banche” della vicenda FonSai, sino alle accuse di insider trading per Giuseppe Mussari, già alla guida di MPS ed al quale l’avvio delle indagini è costato la presidenza della stessa ABI.
L’ultimo report EBA (European Banking Authority) rileva poi che la retribuzione media dei primi cento top manager bancari in Italia ammonta a 1,64 milioni di euro, registrando uno squilibrio tra la busta paga di un dirigente apicale e quella di un impiegato di ben 42 volte più favorevole al primo, almeno secondo uno studio di Fiba/Cisl: una sproporzione della remunerazione alquanto imbarazzante per molti manager e presidenti che negli ultimi anni hanno fatto incetta di aiuti pubblici, soprattutto se rapportata a risultati di bilancio persino in deficit.
Agli errori di un management non più in grado di garantire redditività ed innovazione alle proprie aziende, si vuole ora rimediare con una revisione dei contratti di lavoro finalizzata alla cancellazione di ferie, welfare, orari di impiego, inquadramenti, contenimento dei costi e deregolamentazione dei salari dei nuovi assunti, eludendo per l’ennesima volta un’approfondita quanto necessaria riflessione su ruoli, remunerazione e responsabilità di una classe dirigente non più coerente con alcun modo di fare banca.
Ecco dunque per cosa hanno scioperato i bancari: non per mera difesa di presunti privilegi di cui negli ultimi trent’anni è stato farcito, strumentalmente, l’immaginario collettivo, ma per lo smantellamento di un sistema clientelare che non ammette critiche o dissensi, che cancella gli incentivi alla professionalità, che mette a repentaglio le opportunità di carriera, che per difendere i propri privilegi non esita ad addebitarne il costo alla società ed a quanti costituiscono la vera spina dorsale delle aziende di credito.