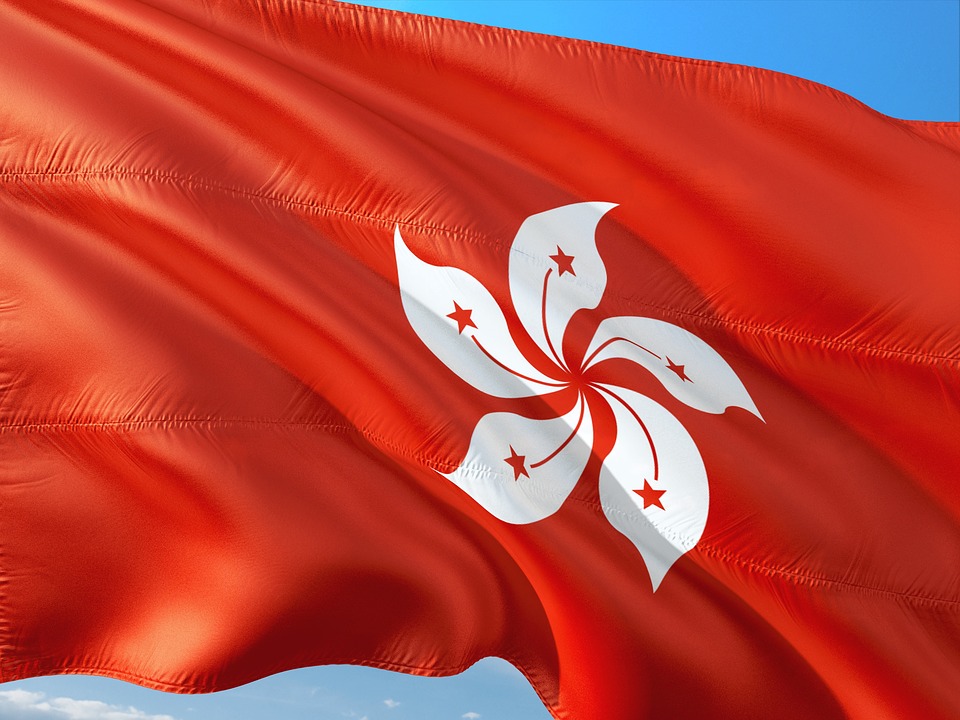Dopo circa tre mesi di proteste, spesso particolarmente violente e distruttive, la chief executive di Hong Kong, Carrie Lam, ovvero Chen Yuet-Ngor, il 23 ottobre 2019 ha ritirato la proposta di legge sulle estradizioni obbligatorie in Cina, che era stata la scintilla che aveva innescato le proteste nella ex-colonia britannica. Mai valutare una protesta di massa sulla base del suo motivo di innesco, che può essere spesso irrilevante.
Il ritiro della normativa, annunciato a settembre, è avvenuto a pochi giorni dalla ripresa dei lavori dell’assemblea di Hong Kong. La ormai ex-chief executive della città-Stato ha fatto ricorso, per sedare in parte la rivolta, alla legislazione di emergenza, utilizzando soprattutto la legge coloniale del 1922, quella che proibisce l’uso di maschere e travestimenti durante le manifestazioni pubbliche. I manifestanti sono stati, e sono tuttora, circa un milione, su circa otto milioni di abitanti.
Le rivolte successive, fatte per durare ben oltre il ritiro nella normativa contestata, hanno messo in crisi i rapporti, certo tesi da sempre, tra la ex-colonia di Londra e la Cina, con il risultato di porre in crisi anche la governance cinese sulla città-Stato del “Porto Profumato” e, in particolare, il modello canonico per Pechino, di “Una nazione. due Sistemi”.
Se fallisce questo criterio, la formula inventata da Deng Xiaoping non varrà nemmeno per il prossimo tassello, Taiwan, o magari le isole del Pacifico del Nord, e comunque metterà in crisi l’idea cinese attuale di espansione pacifica e di collaborazioni win-win tra la madrepatria cinese e tutte le aree confinanti, sia nel Pacifico sia nell’Asia Centrale.
Tutte le rivolte a Hong Kong, dal 1977, quando il Porto Profumato passò sotto il controllo cinese, sono state innescate da una forte insoddisfazione verso la madrepatria cinese. E il disagio economico e sociale, pur profondo, è sempre stato diretto contro la Cina, mai verso le élite locali. In psicanalisi si chiama transfert. Nel 2003, molte migliaia di abitanti della ex-colonia britannica hanno manifestato contro una legge che, secondo loro, avrebbe reso difficile l’espressione di visioni e sentimenti definiti come “anti-cinesi”, e la legge è stata comunque rinviata sine die.
Ancora altre rivolte sono avvenute nel 2012, quando fu proposto un programma scolastico nettamente pro-cinese, e anche lì il potere locale (su diretta indicazione di Pechino) ha evitato di applicare quella normativa.
Poi, nel 2014, c’è stato il movimento di Occupy Central, ovvero la “rivoluzione degli ombrelli”, che è durata, anche questa, tre mesi, nata per richiedere, stavolta senza successo, che il chief executive di Hong Kong fosse eletto a suffragio universale. Ma, oggi, il vero movente delle rivolte a Hong Kong non è tanto la richiesta di applicazione, nella ex-colonia britannica, di meccanismi democratici tipici della cultura occidentale, quanto la tensione derivata dalla fortissima ineguaglianza economica. Per non parlare del vero e proprio blocco dell’ascensore sociale, probabilmente è questo il reale innesco della rivolta giovanile nel Porto Profumato.
La gente, soprattutto se qualificata, non può garantirsi uno stipendio accettabile, ed è per questo che molti abitanti della vecchia città-Stato emigrano verso il Canada o Taiwan. Altro smacco per la Cina.
I salari per i giovani laureati si sono abbassati di almeno il 10% rispetto a 25 anni fa, la crisi degli alloggi è gravissima, ma comunque la scelta di creare una oligarchia locale che, poi, cerca di convincere gli altri abitanti, è una vecchia idea dei britannici.
A Hong Kong una oligarchia di pochissime famiglie domina il sistema economico locale, che vale un Pil di 343,5 miliardi di Usd. Le cinque famiglie più potenti sono ancora oggi quelle dirette da Li Ka-shing, Kwong Siu-hing, Lee Shau-kee, Henry Cheng e Joseph Lau.
Da sole, le cinque famiglie controllano il 70% dell’intero mercato di Hong Kong, compresi gli immobili e le telecomunicazioni, oltre alle Tv. Le 21 maggiori famiglie di Hong Kong controllano una ricchezza pari a 1.893 miliardi di Usd.
In Cina, ovviamente, nessuna famiglia controlla quote di ricchezza così colossali, nella Cina Popolare tutti e cinque i maggiori operatori immobiliari controllano, insieme, solo il 9% dell’intero mercato delle costruzioni cinesi.
Pechino, peraltro, ha cercato di guadagnare consensi a Hong Kong, e soprattutto tra gli imprenditori, con il piano della Greater Bay Area, la grande e nuova megalopoli sul delta del Fiume delle Perle tra Hong Kong, il Guangdong e Macao. Che è, di fatto, l’aggregazione infrastrutturale di Hong Kong alla Zona Economica Autonoma del delta del Fiume delle Perle, tra Guangzou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Jiangmen, le più dinamiche aree economiche di tutta la Cina.
Le tasse sono bassissime a Hong Kong, come in tutti i Paesi business-friendly, ma non c’è, guarda caso, alcuna tassa sull’eredità. La macchina amministrativa è quindi molto semplice: il governo del Porto Profumato non acquisisce sufficienti fondi dal suo fisco, e quindi non ha capitali da investire nelle scuole, negli ospedali e nelle infrastrutture.
Una città come Hong Kong, con oltre sette milioni di abitanti, prevede un salario minimo legale di 4,82 Usd l’ora, gli appartamenti sono quasi tutti illegali e talmente piccoli, dato il costo degli affitti e degli immobili, da essere circa la metà dei “mini-appartamenti” delle grandi città Usa, già decisamente minimi.
La media degli appartamenti di Hong Kong è, per abitante, di 16 metri quadri, mentre a Shangai la media di spazio per abitante è di 36 metri quadri. Il 45% degli abitanti del Porto Profumato vive in appartamenti di proprietà pubblica o sussidiati, il 90% dei cinesi possiede almeno la propria casa.
Le riserve fiscali di Hong Kong sono di almeno 147 miliardi di Usd, ma il sistema politico locale è troppo frazionato, anche dal punto di vista del complesso sistema elettorale, per mediare tra interessi diversi e per risolvere davvero i principali problemi del Porto: casa, salute, costo dell’istruzione.
Chi ha una qualche malattia deve aspettare una media di 150 settimane prima di essere sottoposto ad una visita, con 43 ospedali pubblici che, però, utilizzano il 40% dei medici disponibili, visto che il settore privato attira molti dei migliori professionisti.
La soluzione di impiegare dottori provenienti dall’estero non è molto praticabile, vista la scarsa attrattività degli stipendi di Hong Kong e la scarsa qualità delle strutture sanitarie. Una persona su sei, a Hong Kong, date le condizioni sociali, economiche e sanitarie, soffre di malattie mentali. Lo stipendio medio dei laureati del Porto ex-britannico è calato di oltre il 10% rispetto a un decennio fa, e oggi i laureati raggiungono facilmente il miglior salario dei lavoratori senza qualificazione universitaria.
E non c’è, lo ripetiamo, ascensore sociale. Il costo per metro quadro è largamente superiore, a Hong Kong, al prezzo medio di New York, zona centro.
Come accade anche in Occidente, le speranze di carriera dei giovani laureati del Porto Profumato sono minime, non prevedono mai una casa di proprietà, sono del tutto ridotte rispetto a quelle dei loro colleghi di Hong Kong di qualche decennio fa.
Il Coefficiente di Gini, l’indice che definisce l’ineguaglianza economica di un Paese, è per Hong Kong 5+, uno dei coefficienti più alti e ineguali del mondo. È qui il vero punto politico della questione: per quelli che protestavano a Hong Kong, come accade oggi ovunque nel mondo, “democrazia” nel senso euroamericano significa soprattutto maggiore eguaglianza sociale, tante opportunità, servizi pubblici efficienti.
Non è vero, ovviamente, ma è il modello che ha portato in piazza le masse della Primavera Araba, i cittadini dell’Euromaidan in Ucraina, le rivolte “colorate” in Georgia.
Paradossalmente, proprio quando le democrazie occidentali si trasformano in Stati della rendita e diminuiscono l’entità e qualità del loro Welfare, è proprio in quel momento che essi vengono mitizzati come efficienti e aperti.
Pareto avrebbe parlato, in questo caso, di “residui”, di memorie di un tempo che non esiste più ma che sono ancora in azione nella psiche profonda delle masse. Nel 1997, al momento dell’unificazione sul modello “Un Paese, due Sistemi”, il Pil di Hong Kong rappresentava il 18% di quello dell’intera Cina.
Oggi, dopo la rapida crescita di Pechino, il rilievo del Porto Profumato è pari a quello del Guangdong o dello Shenzhen. Le rivolte attuali, comunque, hanno messo in gravi difficoltà anche la business community di Hong Kong. La maggior parte delle società più importanti del Porto Profumato fa i maggiori affari proprio con la Cina, e non a caso la dirigenza di Pechino ha radunato a Shenzhen, l’agosto scorso, 500 tra i più importanti businessmen e dirigenti politici, per sostenere il governo di Hong Kong e, magari, migliorare sufficientemente la situazione sociale del Porto che, comunque, rimane esplosiva. Il mercato finanziario di Hong Kong ha subito i danni maggiori.
La cinese Alibaba ha posposto la quotazione alla Borsa locale fino a che la rivolta non si sia definitivamente placata, mentre Fitch ha abbassato il rating di Hong Kong.
In attesa di una integrazione sistemica con la rete normativa della mainland China. Altro problema che la rivolta nel Porto Profumato potrebbe generare è l’emigrazione.
Lo scorso anno se ne sono andati 24.300 giovani ad alta qualificazione, e il tasso di aumento delle richieste di emigrazione cresce del 15% l’anno.
Dove vanno? In Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e, si ricordi bene, a Taiwan. Sono diminuiti di ben 14.000 unità per anno, invece, i cinesi che emigrano nel Porto Profumato.
Questo novembre, poi, a Hong Kong ci saranno le elezioni del Consiglio di Distretto, ed è molto probabile che lo scontento giovanile troverà il modo di affermarsi nelle urne. Una società frazionata e in crisi crea molti problemi per chi programma i cicli delle imprese, ed è probabile che Hong Kong diminuirà il suo tasso di crescita di almeno il 3%. E dove andranno i capitali? Naturalmente, nell’area cinese al confine con il Porto Profumato, con una crescita prevista degli investimenti di quasi il 6,5%, rappresentata in gran parte da capitali in uscita da Hong Kong.
Le differenze tra Hong Kong e la Cina sono, però, ben più ampie di quelle mostratesi con violenza durante la lunga e recente rivolta, che spesso mutuava le tattiche delle colour revolutions organizzate dai Servizi Usa, secondo l’ormai vecchio modello elaborato dallo Einstein Institute.
Per la Cina, il criterio di Deng Xiaoping “un Paese, due Sistemi” vuol dire che Pechino assorbe Hong Kong malgrado la differenza dei sistemi politici ed economici, che tenderanno alla fine a sovrapporsi; per i dirigenti di Hong Kong, invece, il “Paese” è un lip service che serve a mantenere la separatezza dalla Cina, sia dal punto di vista culturale che economico e politico.
La Cina ha finora controllato Hong Kong con la stessa logica con la quale ha supervisionato i suoi territori “pericolosi”: il Tibet, lo Xingkiang, la Manciuria. La centralizzazione cinese attuale nasce dalla analisi della fine ingloriosa della quasi federalista Unione Sovietica, e si ricordi qui i sorrisi ironici che accolsero Gorbaciov a Pechino, proprio quando la rivolta di Piazza Tien An Men era arrivata al suo culmine.
Non importa che il diritto alla secessione sia stato stabilito nei Testi Sacri di Lenin, il fatto è che, per la dirigenza cinese, l’unità del Paese e la repressione di ogni secessione regionalista è basilare per la permanenza dello Stato. E del partito.
La Cina, però, dipende ancora dalla piazza finanziaria di Hong Kong, l’unica completamente aperta ai flussi mondiali di capitali. La Hong Kong Stock Exchange capitalizza, ai dati del 2018, 29,9 trilioni di dollari locali. Shenzhen e Shangai non possono rimpiazzare Hong Kong, da questo punto di vista.
Quindi, la Cina non ha potuto intervenire nel Porto Profumato, si sarebbe distrutta così, proprio per mano cinese, la via che connette la Cina al flusso internazionale dei capitali.
Inoltre, la repressione dei movimenti di Hong Kong avrebbe distrutto il modello “Un Paese due Sistemi” che è esattamente quello che verrà applicato, al momento giusto, per Taiwan.
E non bisogna nemmeno dimenticare che le potenze occidentali, nelle more della Nuova Via della Seta promossa da Pechino, stanno immaginando meccanismi politici di interruzione e possibilmente blocco della “Via”, organizzando rivolte e partiti anticinesi nei vari Paesi dove è progettato il passaggio della Obor di Pechino. E, naturalmente, la Cina non sta a guardare.
La rivolta di Hong Kong, da questo punto di vista, è un modello che verrà presto imitato, e che la Cina contrasterà esattamente con la stessa tecnica politica.
Come si dice nei 36 Stratagemmi, “alleati con uno Stato distante mentre attacchi uno vicino”.