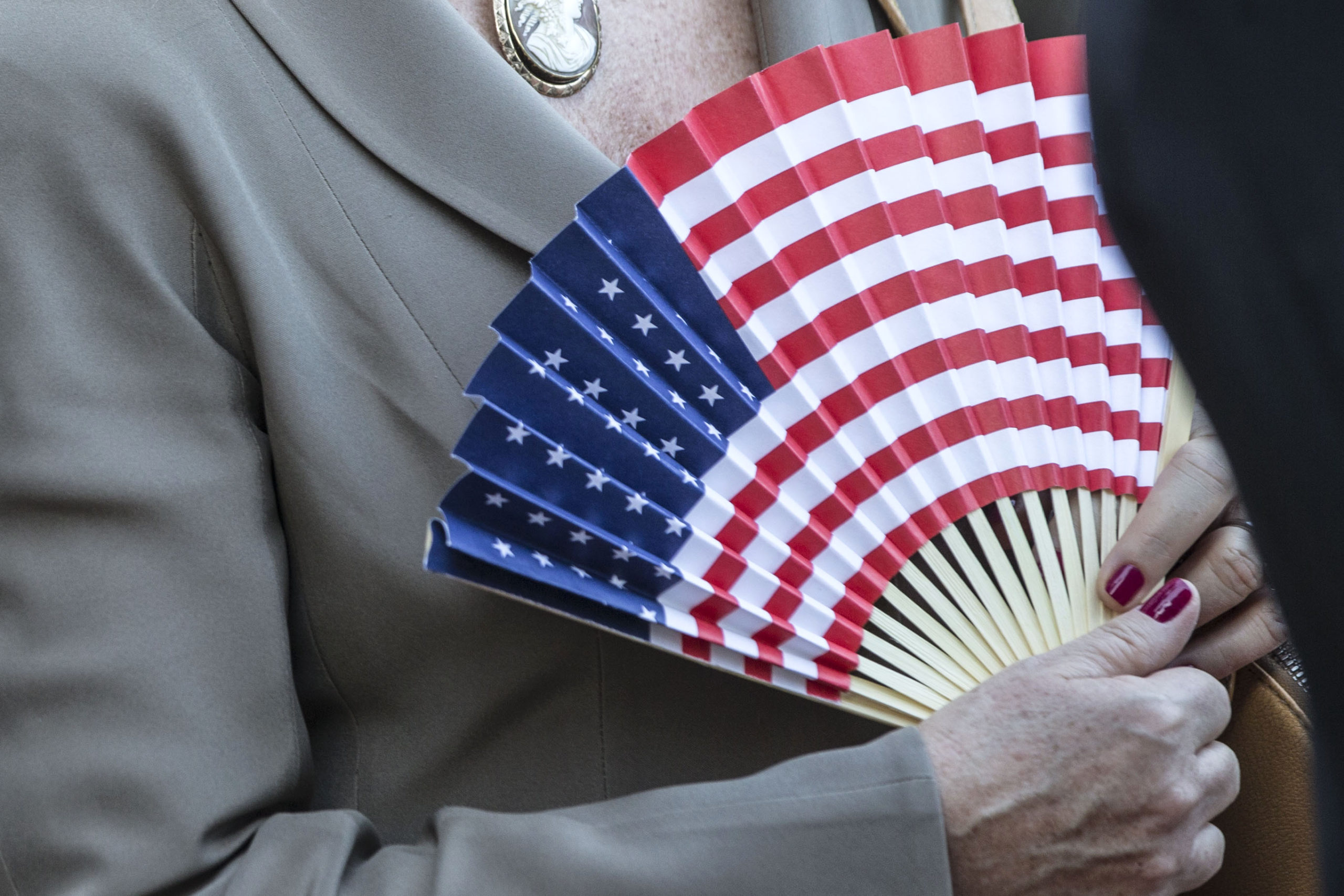L’Italia si muove all’interno di un momento “critico” per l’ordine liberale, i cui pilastri sono stati progressivamente messi in discussione a partire dall’attacco alle Torri Gemelle e, ancor di più, dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Da un lato le sue norme (diritti umani), i suoi modelli politici ed economici (democrazia e libero mercato) e la sua architettura istituzionale (Onu, Nato, Ue) stanno subendo una contestuale perdita di efficacia e di fascino.
Dall’altro il primato americano nella dimensione del potere e del prestigio è sotto l’attacco di una serie di potenze revisioniste il cui raggio d’azione è regionale – Iran e Corea del Nord – o si dipana su più quadranti strategici – Cina e Russia – ma comincia anche a essere mal tollerato da alleati tradizionali – Germania e Francia. Come tutte le crisi, ovviamente anche questa si trova dinanzi due possibili evoluzioni: il superamento dell’ordine liberale o il suo riconsolidamento.
Come tutte le crisi, inoltre, anche quella in atto impone la necessità di compiere una scelta di campo, quanto meno alle grandi e medie potenze (in caso di declino dell’egemone, i “piccoli” tendono a schierarsi con il Paese più minaccioso tra quelli geograficamente prossimi). Dunque, a dispetto della retorica declinista sul nostro Paese, l’Italia è chiamata a compiere una scelta cruciale per il suo futuro**.
Purtroppo, la nostra classe dirigente – un concetto che, come insegna Gaetano Mosca, è ben più ampio di quello di classe politica – non sembra averne pienamente contezza, come confermato dalle scarse tracce rinvenibili nel dibattito pubblico nazionale. La domanda che ci dobbiamo porre come sistema Paese, qualora fosse necessario esplicitarla, è: di fronte alla crisi dell’ordine internazionale a guida americana, da che parte stiamo? Sebbene, da tradizione italiana, la tentazione di restare a guardare alla finestra sia forte, la storia dell’ultimo secolo ci ha insegnato che essa comporta il rischio di essere trattati da sconfitti o da “non vincitori” pur avendo scelto – in ritardo – il cavallo vincente.
Al netto delle nostre preferenze ideologiche o della percezione di un debito storico nei confronti degli Stati Uniti – legato al ruolo che essi hanno giocato nell’ultimo conflitto mondiale, nella successiva fase di ricostruzione con il Piano Marshall o nella nostra difesa sia durante che dopo la Guerra fredda – la risposta che l’Italia deve formulare deve essere dettata da considerazioni di tipo strategico. Questo implica l’identificazione dei nostri obiettivi di sicurezza e, in base a essi, la definizione del migliore piano d’azione per conseguirli.
Semmai riuscissimo in tale impresa – cosa tutta da vedere vista l’aria che tira da queste parti sulla libertà di dibattito – con tutta probabilità il risultato di quello che potrebbe apparire a molti un ragionamento “cinico” – o, forse, solo razionale – sarebbe probabilmente lo stesso di quello “idealistico” – o, più banalmente, di natura epidermica. In sintesi, la nostra opzione migliore non solo resta quella americana, ma passa per un innalzamento di livello del rapporto tra i due Paesi a dispetto di chiunque ne sia alla guida. Non si pretende in questa sede di cogliere l’essenza di un tema dalle mille sfaccettature e per cui sono necessarie molte e molto più approfondite competenze di quelle possedute da chi scrive.
Più semplicemente, si tenterà di mettere nero su bianco alcuni appunti a sostegno dell’ipotesi di una relazione speciale tra Italia e Stati Uniti, sulla scorta di quelle evoluzioni politiche recenti che mettono in discussione la sicurezza – da intendersi non solo in senso militare, ma anche come benessere complessivo – del nostro Paese. Il tema che naturalmente tiene banco questi giorni è quello degli effetti prodotti dalla strategia di retrenchment messa in atto da Washington sin dal 2011 sugli impegni precedentemente contratti in Medio Oriente e Nord Africa (Mena).
Prima Barack Obama e poi Donald Trump, d’altronde, hanno chiarito come l’area vitale per gli interessi strategici americani sia l’Indo-Pacifico e non il Mena. Questo, tuttavia, non sottintende che gli Stati Uniti – come si legge diffusamente – vogliano abbandonare la regione a sé stessa. Al contrario, significa che non desiderano più impegnarsi in irrealistiche operazioni di ingegneria politico-sociale come fatto dall’amministrazione Bush, né sobbarcarsi da soli i costi del mantenimento dell’ordine, secondo il principio del leading from behind. Inutile mettere la testa sotto la sabbia per non pensare al fatto che l’Italia, ancor prima di essere una potenza europea, è una potenza mediterranea e che – per prima – subisce i contraccolpi dell’instabilità degli Stati che si affacciano sull’ex Mare Nostrum o che ne costituiscono l’immediato retroterra.
Si ricordi, inoltre, che dopo gli Stati Uniti è proprio il nostro Paese quello più esposto nell’area quanto a presenza militare. Tuttavia, il prestigio che l’Italia ne trae non appare proporzionale agli sforzi profusi, forse perché le sue – limitate – risorse appaiono investite in operazioni talvolta velleitarie nell’ottica dell’interesse nazionale (che ci stiamo a fare in Libano?)
Al contrario, sembriamo fare poco, almeno in relazione agli interessi che abbiamo in gioco, in un contesto vitale come quello della Libia. Per tale ragione, dovremmo confermare il nostro grande impegno a fianco degli Stati Uniti, a differenza di quanto fatto da altri Stati europei, e, al contempo, concertare con loro l’ottimizzazione delle nostre forze laddove ha più senso impegnarle. Dimostreremmo così la disponibilità ad assumere un ruolo di grande responsabilità all’interno dell’approccio strategico americano varato negli anni Dieci e che, presumibilmente, sarà confermato negli anni Venti.
È proprio questo il caso della Libia dove, oltre alle proxy locali (governo legittimo di Tripoli o milizie di Bengasi), sembra in atto un confronto tra potenze che – se non ne conoscessimo i nomi dei protagonisti – potrebbe anche sembrarci una cronaca di metà Ottocento, con turchi, russi, egiziani e francesi a decidere chi sta al potere e quali scelte deve compiere a pochi chilometri dalla nostra Penisola, con la variante costituita dai crescenti interessi cinesi nel Paese. Sicuramente, se Roma si dimostrasse disponibile a investire di più nel ripristino dell’ordine in Libia, Washington la considererebbe quale sua migliore opzione e, probabilmente, sarebbe disponibile a offrirgli copertura in termini di legittimità e di risorse, così come ad accettare una diminuzione dei suoi impegni altrove.
Non ci dimentichiamo, infatti, che come potenza marittima gli Stati Uniti hanno interesse alla stabilità del bacino del Mediterraneo e la presenza di un “buco nero” come quello libico al suo centro non lavora esattamente in tale direzione. Stesso discorso vale per il ruolo che l’Italia dovrebbe/potrebbe giocare nei Balcani, altro quadrante dove il vento del XIX secolo è tornato a spirare, con tedeschi, francesi, russi e turchi a muovere quelle che – a conferma del carattere squisitamente legalistico del principio di sovranità – sono più delle pedine su una scacchiera regionale che degli Stati indipendenti.
Non si dimentichi il recente caso del blocco del processo di adesione all’Unione europea della Macedonia del Nord – che aveva trovato nell’Italia uno dei suoi principali sponsor – da parte di quella che solo nominalmente si propone come potenza europeista par excellence, la Francia. Sembra quasi superfluo sottolineare – ma forse meglio farlo – che gli Stati Uniti avrebbero preferito una Macedonia del Nord perfettamente integrata nei sistemi di alleanza occidentali – tanto è che stavano contemporaneamente sostenendo la firma del protocollo della sua adesione alla Nato – piuttosto che esposta alle leve della Russia nella dimensione economica.
Non si dimentichi poi che Italia e Stati Uniti hanno un interesse comune in campo energetico, che per i secondi ha riflessi immediati anche in quello strategico: limitare il peso internazionale della Russia. In una recente telefonata, sembra che Vladimir Putin e Angela Merkel abbiano ribadito il loro impegno per portare a compimento il gasdotto Nord Stream 2. Nonostante la Germania ostenti fermezza sul tema delle sanzioni, si tratta di un ulteriore passo con cui Berlino si allontana da Washington per collocarsi in una posizione intermedia tra quest’ultima, che ambisce contemporaneamente ad aprire nuovi mercati al suo gas e a contenere la potenza russa, e Mosca.
Dal canto suo, l’Italia rischia di restare schiacciata dalla formazione di un hub tedesco dell’energia che, congiuntamente al depotenziamento delle rotte onshore del gas russo, la renderebbe più esposta alle politiche di Berlino e ne indebolirebbe il piano di costituzione di un hub meridionale per l’energia europea. È in questa prospettiva, d’altronde, che sono stati sviluppati i progetti della Trans-Adriatic Pipeline (Tap) e quello dell’esplorazione e dello sfruttamento dei giacimenti offshore nel Mediterraneo orientale. Entrambi favoriscono, oltre l’Italia, anche altri alleati tradizionali degli Stati Uniti, quali Israele, Cipro, Azerbaijan, Albania.
Al contrario, il Tap è in contraddizione con gli interessi della Russia, mentre la progressiva messa a regime delle risorse del Mediterraneo orientale – che la Russia ha digerito solo dopo l’inserimento della sua Rosneft nel progetto guidato da Eni – è visto come il fumo negli occhi dalla Turchia, come confermato dalla crisi del febbraio 2018 quando la marina militare di Ankara bloccò la nave perforatrice italiana “Saipem 12000” (l’Unione Europea dove era? Erdogan era tornato improvvisamente democratico?)
Altro capitolo che dovrebbe indurci a rinsaldare la relazione con gli Stati Uniti è quello con la C maiuscola nell’agenda internazionale, ossia i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese. Più nello specifico, al di là dei calcoli politici di corto respiro, assume una valenza fondamentale il tema della partecipazione o meno di Roma ad alcuni progetti strategici lanciati da Pechino. Si fa naturalmente riferimento alla Belt and Road Initiative e al piano di lancio del 5G di Huawei e non ai rapporti tra Italia e Repubblica Popolare Cinese in generale. Non si dimentichi, d’altronde, che l’Italia continuò ad avere rapporti di collaborazione scientifica ed economica anche con l’URSS durante la Guerra fredda e, quindi, nessuno ha l’ardire di proporre un taglio dei ponti con un partner economicamente importante come quello cinese.
Tuttavia, Roma non ha interesse a favorire l’incremento di un flusso economico di merci a basso costo (che, come confermato dai dati degli ultimi due anni, aumenta sostanzialmente in direzione unilaterale) che stanno progressivamente mettendo fuori mercato i prodotti delle nostre aziende piccole, medie e grandi attraverso procedure di dumping. Gli americani coltivano interessi simili a quelli italiani sul tema ma per ragioni diverse, poiché i beni che invadono i nostri mercati provengono da un’economia – direttamente o indirettamente – controllata dal governo di Pechino e funzionale al perseguimento dei suoi interessi strategici.
Nella stessa prospettiva, inoltre, la Casa Bianca ha fatto pressioni su Palazzo Chigi affinché receda dai propositi di concedere infrastrutture vitali come quelle legate al 5G ad aziende cinesi, favorendo l’ingerenza sulle nostre dinamiche politiche interne di un Paese autoritario (se qualcuno avesse il coraggio di applicare le categorie politologiche, potremmo tranquillamente definirlo “totalitario”) e sempre più avverso al sistema di alleanze nel quale siamo inseriti.
Infine, occorre sottolineare che con la Brexit la componente “atlantista” interna all’Unione Europea è destinata a diventare sempre più debole, viste le tensioni sempre più frequenti che – ricordiamolo, sin dai tempi di George W. Bush – stanno caratterizzando i rapporti tra Washington e le due “locomotive” del progetto di integrazione europea, Berlino e Parigi. Inutile stare qui a menzionare l’ormai infinita serie di colpi bassi che Roma si è scambiata negli ultimi anni con le due capitali “sorelle”.
Questo naturalmente non significa proporre l’ItalExit – che potrebbe solleticare le fantasie di Donald Trump, ma non necessariamente compiacere i suoi successori – ma compiere azioni volte a riportare in equilibrio i rapporti interni a Bruxelles, che da unione tra pari rischia di trasformarsi in un direttorio. Questa può essere realizzata solo con l’aiuto di un partner esterno di peso come gli Stati Uniti, che veda nell’Italia un garante della lealtà atlantista dell’intero continente europeo (che è molto meno scontata di quanto si pensi comunemente).
Se questi costituiscono solo alcuni degli incentivi sistemici alla definizione di una relazione speciale tra Italia e Stati Uniti, non bisogna dimenticare che – semmai al termine di un lungo dibattito potesse emergere questa opzione – sarebbe necessaria anche la volontà degli attori interni nel tradurla in politiche.
A questo punto la “palla” passerebbe in mano ai partiti sia di governo che di opposizione, perché una scelta strategica ha bisogno di un sostegno trasversale per essere realizzata, essendo per sua natura di lungo termine. Tuttavia, il “partito” dei sostenitori di una special relationship con gli Stati Uniti al momento sembra debole.
Se l’estrema sinistra è sempre stata, e, probabilmente, sempre sarà ideologicamente anti-americana, il Partito democratico sembra non aver colto il cambiamento dei tempi per cui europeismo e atlantismo non sono più due concetti sistematicamente conciliabili. Dal canto loro, Italia Viva e Forza Italia sembrano troppo impegnate con la lotta per la loro sopravvivenza per ragionare su questioni di medio-lungo termine. Infine, sulla Lega gravano ancora i sospetti del Russiagate, nonostante oggi sembri prevalere nel partito quell’impostazione filo-americana un tempo suggerita solo da Giancarlo Giorgetti, mentre il feeling tra Fratelli d’Italia e gli Stati Uniti, almeno per il momento, sembra dipendere troppo dalla figura dell’attuale inquilino della Casa Bianca.