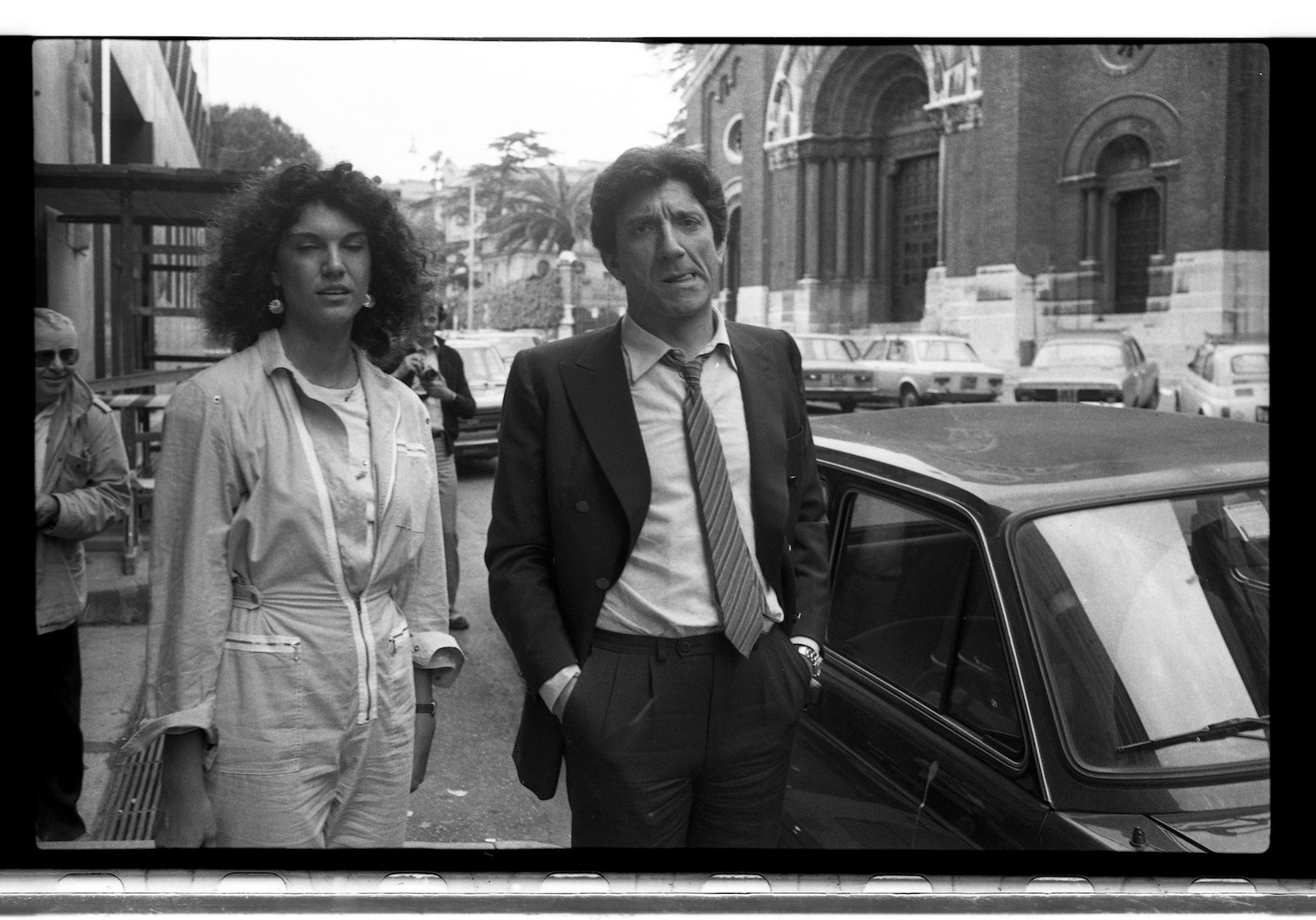I governi hanno raggiunto lunedì un accordo storico, anche se di compromesso. Sia per il principio, finora ignorato, della solidarietà nella raccolta e gestione di risorse comuni; sia per le rinunce che sono state imposte in termini di valori e programmi. Il compromesso sul Recovery Plan presentato da Michel ed approvato dai Capi di Stato e di Governo prevede un Next generation EU da 750 miliardi, ma un bilancio fermo a 1.074 miliardi per i sette anni 20201-2027, con l’inevitabile riduzione degli stanziamenti per programmi cruciali nella formazione ed il consolidamento dell’identità europea (Erasmus+, Europe for Citizens, etc).
In sostanza, fino a ieri ha vinto l’Europa dei governi su quella dei cittadini. Ma la partita non è conclusa. Perché sul bilancio pluriennale l’ultima parola spetta al Parlamento Europeo.
Ora, è difficile che nei negoziati qualcuno si sia dimenticato almeno di consultare il Parlamento Europeo sulla proposta di compromesso, la cui parte del bilancio coinvolge anche le responsabilità dell’Assemblea diretta espressione della democrazia diretta in Europa. È probabile, quindi, che il Parlamento sia già pronto ad accettare il compromesso al ribasso sul bilancio (magari con qualche ritocco per non perdere la faccia), che è servito per permettere ai governi di portare a casa l’accordo sul Recovery Plan.
Tuttavia, guardando la risoluzione che stanno preparando in maniera trasversale Popolari, Socialisti e Democratici, Renew Europe, Verdi, Sinistra Unitaria (in rappresentanza di 538 parlamentari su 704) ed ascoltando le dichiarazioni di oggi del Presidente Sassoli, potrebbero emergere delle sorprese. Potrebbe emergere cioè, accanto all’affermazione dell’Europa dei governi, anche un’affermazione dell’Europa dei cittadini.
Non solo per salvaguardare i livelli di spesa sui programmi comunitari pregressi. O per ribadire la necessità di tutelare lo stato di diritto nei paesi in cui esso è a rischio. Ma soprattutto per dare un orientamento collegiale alla gestione, cruciale, delle risorse per il finanziamento della spesa: sia del bilancio, sia del Next Generation Eu.
Perché la proposta di risoluzione chiede a gran voce l’adozione progressiva, a partire da gennaio 2021, di un sistema di finanziamento largamente basato su risorse proprie (vecchie e nuove: Emissions Trading System, Carbon Border Adjustment Mechanism, digital tax, Financial Transaction Tax, Common Consolidated Corporate Tax Base), ossia sull’autonomia impositiva della Ue; primo passo concreto verso quel “momento Hamiltoniano”, come lo ha chiamato qualcuno, di passaggio della Ue da soggetto sostanzialmente confederale a soggetto sostanzialmente federale.
Vedremo nelle prossime settimane se il Parlamento Europeo farà sul serio, ponendo subito con forza ed esplicitamente questo nodo politico, o se preferirà diluire lo scontro col Consiglio, lasciando magari che sia il lungo processo di riflessione che accompagnerà la Conferenza sul Futuro dell’Europa ad esporsi in tal senso; una volta che i giochi per il bilancio siano ormai fatti.
Se vogliamo che l’Europa cresca come soggetto capace di rispondere alle esigenze dei suoi citadini ed essere attore globale, è fondamentale che questa tensione fra Consiglio (nel quale sono rappresentati i governi nazionali) e Parlamento (espressione della battaglia politica fra i cittadini europei) sia alimentata in modo costante e costruttivo. Dall’esito di questo confronto, che ci auguriamo sinergico, dipenderà l’efficacia del progetto d’integrazione europea nei decenni a venire.