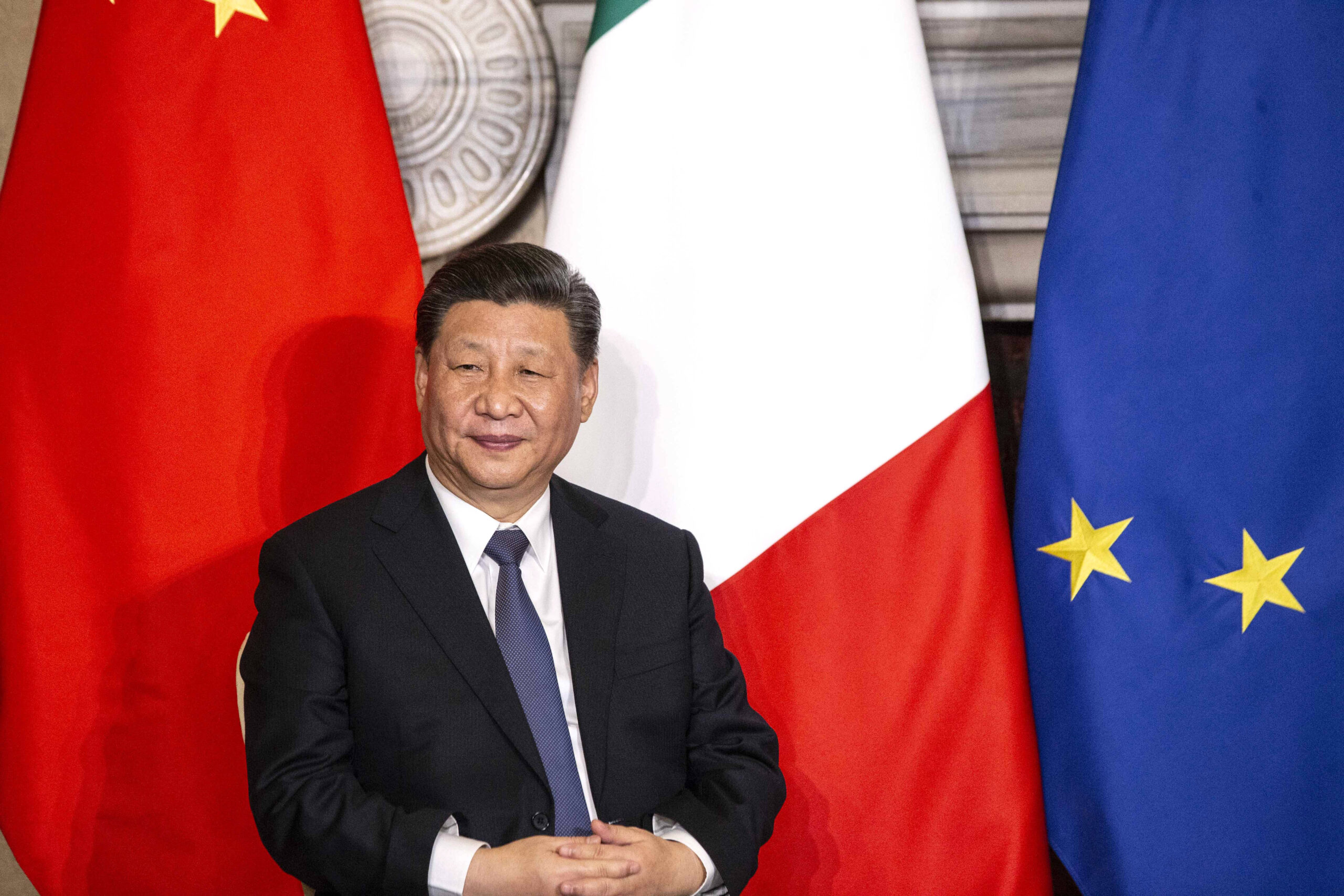Le ragioni per cui la Cina viene percepita uno stabile investitore dai Paesi dell’area Mena sono complesse e articolate e ruotano anche attorno al modello che propone
Il mese di gennaio è stato piuttosto significativo per ciò che la Cina intende essere nella regione articolata che gli Stati Uniti identificano con l’acronimo Mena, Middle East and North Africa: cinque ministri degli Esteri del Golfo sono andati in visita dal governo cinese per discutere progetti energetici e investimenti reciproci; lo stesso ha fatto il ministro turco in cerca di opportunità per collaborazioni economiche e quello iraniano (che rivendica come certe opportunità siano già state messe nero su bianco con un accordo di cooperazione venticinquennale dal valore di 400 miliardi di dollari).
La regione in cui si snodano queste dinamiche è una priorità strategica per l’Italia, la cui dottrina la definisce “Mediterraneo allargato”, e dove Roma è impegnata sia in forma diretta che nell’ambito di contesti multilaterali (pubblici, privati, misti) insieme a Unione Europea e Stati Uniti appunto. Il cambiamento di uno schema — gli Usa come punto di riferimento — potrebbe avere riflessi anche negli interessi che l’Italia proietta in quell’area, e dunque diventare questione di interesse nazionale.
In a nutshell, il fatto che i governi dell’area Mena inizino a guardare con maggiore attenzione alla Cina si lega alla concretizzazione della volontà di disimpegno da una regione che per le amministrazioni statunitensi ha significato più guerre che progetto di sviluppo; sia alla necessità degli Usa di concentrarsi maggiormente sul contenimento cinese in Asia; alla raggiunta indipendenza energetica che porta Washington a distaccarsi da quei pozzi che invece sono la principale fonte di approvvigionamento per Pechino.
Ma la questione è anche connessa all’angolazione con cui certi Paesi, dove i diritti civili e umani sono più contratti, guardano a un mondo come quello americano/occidentale che di quei diritti ha fatto un vettore di politica internazionale. È la parte più alta del confronto tra potenze che si sta costruendo, democrazie contro autoritarismi, che tocca attori terzi e diventa globale. Nelle “Osservazioni sulla Cina” tenute da George Soros alla Hoover Institution l’imprenditore e filantropo di origini ungheresi dice: “La caratteristica geopolitica dominante del mondo di oggi è l’escalation del conflitto tra due sistemi di governance diametralmente opposti”.
Per Soros, questi sistemi (o modelli) sono divisi in “una società aperta il ruolo dello Stato è quello di proteggere la libertà dell’individuo. In una società chiusa il ruolo dell’individuo è quello di servire chi governa lo Stato”. Dualismo reso ancora più evidente nell’allineamento che Cina e Russia — coopetitor — hanno espresso chiaramente nella dichiarazione per una “nuova era degli investimenti sostenibili globali”. Nel testo del comunicato congiunto: “Le parti condividono la comprensione che la democrazia è un valore umano universale, piuttosto che un privilegio di un numero limitato di Stati, e che la sua promozione e protezione è una responsabilità comune di tutta la comunità mondiale”.
Pechino (come Mosca) coglie il flusso come opportunità per espandere le proprie caratteristiche di visione del mondo ed estendere la propria influenza, e i leader arabi apprezzano che la Cina — che vanta la virtù della “non interferenza” negli affari degli altri Paesi — non sarà coinvolta nella loro politica interna o invierà militari a rovesciare dittatori ostili. E ciascuna parte può contare sul fatto che trascuri le violazioni dei diritti umani dell’altra.
Per esempio, tra i leader dell’area Mena recentemente presenti all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali cinesi (da cui esce lo statement russo-cinese) raramente si alzano critiche sulla repressione dei musulmani uiguri e di altri gruppi etnici islamici minori da parte delle autorità cinesi, e non si parla della situazione di Hong Kong o Taiwan — con cui hanno connessioni industriali e finanziarie. Anche fornendo come garanzia questa non interferenza reciproca, negli ultimi anni la Cina ha investito in infrastrutture critiche nella regione e ha fatto accordi per fornire le telecomunicazioni e la tecnologia militare. La Cina ha avviato cooperazioni anche nell’ambito della transizione energetica, che è il grande tema del momento in una regione fondata sugli idrocarburi. Uno scombussolamento per economie (e sistemi socio-culturali) basato sui proventi delle energie fossili.
Pechino condivide con Riad, o Abu Dhabi, o Doha e Teheran, più di una perplessità sul trend, ma è costretta a cavalcarlo — come tutti. D’altronde, “ci concentriamo sulla sostenibilità non perché siamo ecologisti, ma perché siamo capitalisti e siamo legati da un rapporto fiduciario verso i nostri clienti”, aveva scritto Larry Fink, il leader del gigantesco fondo BlackRock, nella sua lettera annuale agli investitori. Per i ricchi stati petroliferi e gasiferi del Golfo e (anche se meno ricchi) dell’Africa centro-settentrionale una posizione scettica ma pragmatica su questo enorme tema è certamente preferibile da un approccio quasi ideologizzato di certe istanze occidentali.
Tanto più se c’è il portato della narrazione politica-economica-commerciale-culturale della Belt & Road Initiative, dove la regione ha un ruolo centrale nel collegare Asia (Cina) all’Europa. La possibilità di investimenti infrastrutturali è vista come un’opzione valida e futuribile, adesso soprattutto da coloro che non temono (per capacità finanziare ed economiche) di finire nella trappola del debito.
“La Cina, nonostante tutto, viene percepita come stabile investitore, forse anche per la sua forma di governo, di certo più vicina a quella di svariati Paesi della regione rispetto alle democrazie liberali, dove vicende politiche interne spesso rallentano la strategia generale”, spiega Angelo Ciavarella, Ceo della struttura finanziaria londinese Blink Concept. “L’azione cinese è business-focus, spesso non in sovrapposizione diretta e aperta con gli Stati Uniti, sebbene promuova se stessa come partner alternativo per i paesi che mettono in discussione il modello di sviluppo di Washington, o la sua storia di interventi politici e militari”, spiega Ciavarella, che ricopre anche il ruolo di docente alla School of International Business and Economics dell’Università Greenwich a Londra.
Per i Paesi del Medio Oriente, i benefici della relazione sono chiari: la Cina promette nell’immediato di essere un acquirente affidabile e costante di petrolio e gas e una potenziale fonte di investimenti utili per il futuro decarbonizzato (quando sarà, e se), senza le complicazioni politiche che comporta fare affari con gli Stati Uniti. Iran e Siria, governi con cui Washington ha rotto le relazioni, ne sanno qualcosa trovando nella Cina il principale partner commerciale.
Molte aziende tecnologiche cinesi hanno raggiunto capacità all’avanguardia e stanno cercando di ampliare a livello globale il proprio business, ma non possono andare negli Stati Uniti o in Europa a causa dei regolamenti stretti su sostenibilità (intesa non solo nel senso ecologico) e competitività. La regione Mena offre ottimi clienti — e con le attività commerciali permette di affinare lo sviluppo tecnologico a quelle aziende. Un esempio: SenseTime, che fornisce tecnologie anche per la profilazione usata nelle campagne di rieducazione contro gli uiguri, nel 2019 ha aperto un quartier generale ad Abu Dhabi. la stessa società a dicembre è stata sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti per violazioni nei diritti umani.
Tuttavia la Cina non sta dimostrando interesse nell’emulare il ruolo statunitense e questo rappresenta un potenziale limite attorno a cui si snoda la competizione. Abu Dhabi per esempio nei mesi scorsi ha manifestato la volontà di uscire dalla linea di partnership con gli Usa costruita attorno alle forniture dei superjet F35 americani: scelta fatta per avere mani più libere nel business (con la Cina, sottinteso), ma adesso che i ribelli yemeniti Houthi hanno allargato i loro attacchi al territorio emiratino si rivolgono a Washington per ottenere maggiore difesa e sicurezza.
Recentemente la Commissione europea ha avvertito gli stati membri che rischiano di diluire l’impatto dei loro investimenti in Africa, l’altra sponda del Mena, se continuano a farli in modo frammentario e a perseguire interessi nazionali invece di una più ampia strategia dell’Unione. Se Bruxelles alza certi avvertimenti è anche perché davanti a un’apparente indecisione e divisione europea, gli Stati africani si trovano affascinati dalla decisione, dal realismo, dal pragmatismo con cui altre potenze, su tutte la Cina, si muovono. Rovescio della medaglia di tutto questo sono le trappole del debito: certi Paesi si sono trovati già a non riuscire a far fronte all’assistenza fornita da Pechino in progetti infrastrutturali e il governo cinese ha ottenuto in cambio il possesso di quelle infrastrutture.
Gli ultimi dati della Bri (non eccezionali in realtà) sono arrivati in mezzo a un rinnovato dibattito internazionale sul fatto che la Cina stesse spingendo i paesi in via di sviluppo nelle cosiddette trappole. L’ansia per il crescente dominio internazionale della Cina ha spinto gli Stati Uniti e l’Ue nell’ultimo anno a cercare di contrastare la Bri con nuovi sforzi finanziari internazionali per lo sviluppo. “Credevamo che il focus sarebbe stato molto più sul sud-est asiatico, comprese le infrastrutture”, ha detto Christoph Nedopil Wang, director del Green Finance & Development Center, “ma in realtà [c’è] e un forte spostamento verso l’Africa e i paesi del Medio Oriente”.