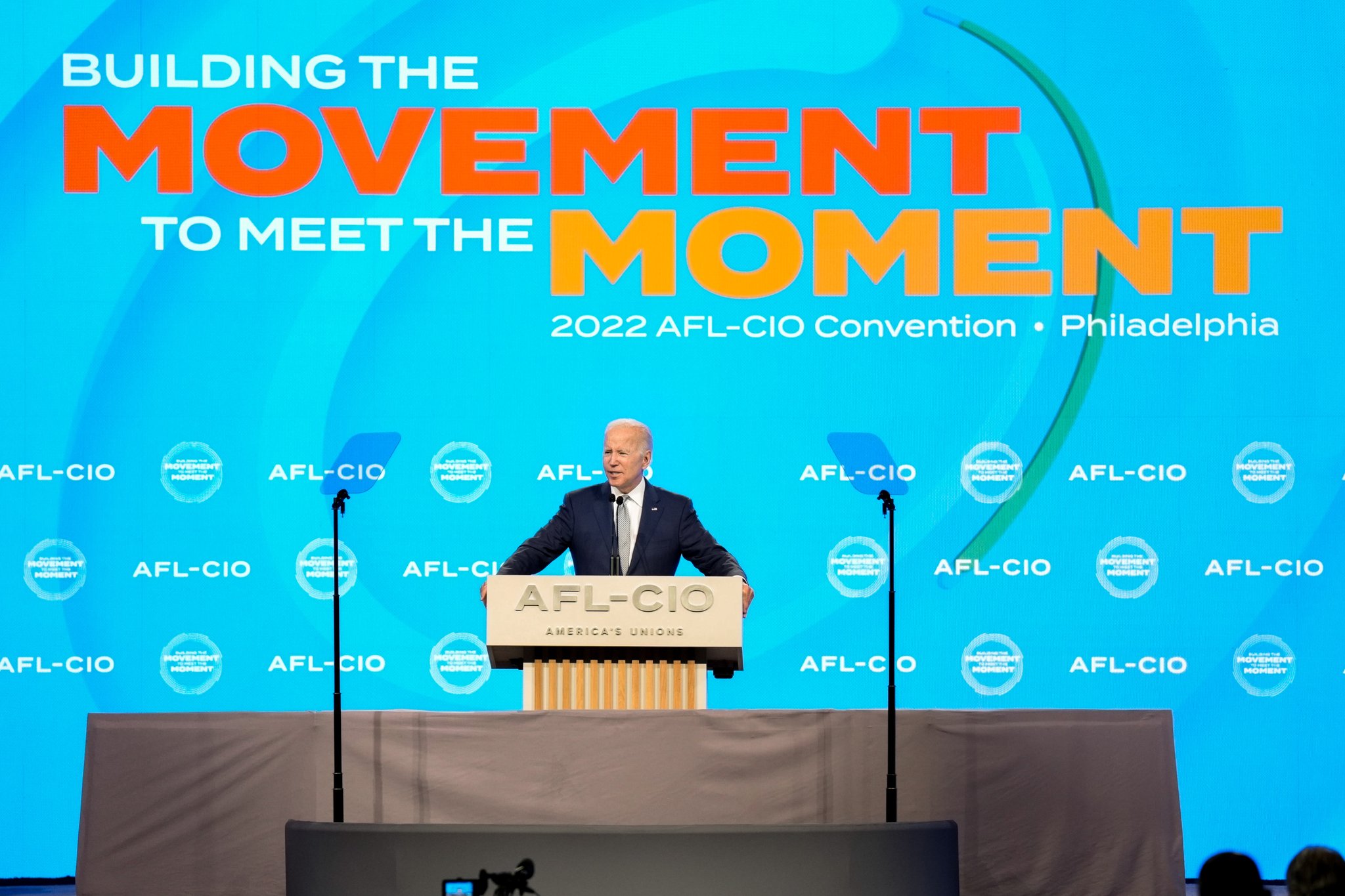La Cina (e in parte la Russia) è un fattore centrale della visita di Biden in Medio Oriente. Per Washington c’è la possibilità di confermarsi tutore della sicurezza nel Golfo, usandolo come leva su Pechino. Un lavoro complesso, spiega Scita (Durham)
“Sulla scia della trasformazione internazionale dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, gli Stati Uniti sembrano tentare di replicare il successo ottenuto nel rilanciare l’alleanza occidentale e riunificare la Nato in Europa, rinvigorendo e ripristinando un blocco a guida americana in Medio Oriente”, scrive Hussein Ibish in un’analisi per l’Arab Gulf States Institute di Washington.
Il viaggio di Joe Biden in Medio Oriente è uno dei temi del momento, e la lettura di Ibish ne fornisce il reale perimetro. Rinvigorire il ruolo americano nella regione dovrebbe servire come fattore strategico per limitare l’influenza crescente che nell’area stanno avendo le grandi potenze rivali degli Stati Uniti. La Russia, che nonostante tutto preserva ancora una capacità di muovere politica estera, e soprattutto la Cina.
Il momento per certe mosse non è dei peggiori. La Russia ha superato l’Arabia Saudita come fornitore di petrolio alla Cina. Mosca sfrutta una scontistica fuori mercato (circa del 30%) con cui vuole tenere vive le esportazioni mentre vengono colpite dalle decisioni europee di sganciarsi dalla dipendenza energetica russa — frutto di misure di ritorsione che seguono l’invasione dell’Ucraina.
“La Russia vende il suo petrolio a buon mercato e compete con il petrolio del Golfo Persico in Asia, la sola India ha aumentato i suoi acquisti di petrolio russo di 21 volte dopo che l’Europa ha abbandonato il petrolio russo”, ha scritto su Twitter Abdulkhaleq Abdulla, noto politologo emiratino molto ascoltato ad Abu Dhabi. “È giunto il momento — aggiunge — di non andare in accordo con la Russia in materia di petrolio, soprattutto di rendersi conto che la decisione sul petrolio è tanto politica quanto economica, e la decisione è nel Golfo, dove [si trova] il baricentro globale del petrolio”.
La Casa Bianca continua a ripetere che la missione mediorientale va oltre il petrolio — anche se un dialogo col Golfo servirà all’americano per equilibri di mercato sui prezzi, ma come mette in evidenza Abdulla anche per ragioni di affari internazionali. Se nell’incontro con la leadership Saudita (leggasi con l’erede al trono Mohammed bin Salman) sta la notizia più attraente a livello di narrazione politica, nel colloquio con Abu Dhabi si snodano maggiormente quelle dinamiche ampie.
Almeno dal novembre 2021, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati per ottenere le garanzie di difesa reciproca con gli Stati Uniti di cui adesso si discute con maggiore concretezza. Questo desiderio emiratino è diventato una necessità stringente da quando gli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell’Iran, hanno lanciato missili e droni contro Abu Dhabi. Ad aprile, il segretario di Stato, Antony Blinken si sarebbe scusato con l’allora principe ereditario di Abu Dhabi, l’attuale presidente emiratino Mohammed bin Zayed, per quella che Washington ha definito una risposta tardiva agli attacchi — e alle necessità di difesa emiratine.
A inizio mese si è iniziato a parlare di un “accordo quadro strategico” di cui il coordinatore per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, avrebbe consegnato una bozza preliminare ad Abu Dhabi a fine maggio. Non ci sono commenti ufficiali, ma diverse fonti hanno fatto sapere ai media che la firma sarebbe vicina. Al punto che si può arrivare a ipotizzare che la visita di Biden offra una perfetta cornice per istituzionalizzare l’intesa. Un accordo di questo tipo potrebbe rappresentare un’importante svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Paesi arabi del Golfo e andrebbe probabilmente oltre i benefici di cui godono Kuwait, Bahrein e Qatar in quanto “major non-NATO ally” degli Stati Uniti.
Il valore di questa potenziale intesa è doppio. Da una parte fornisce agli Emirati la garanzia di avere un ruolo di componente indispensabile dell’architettura di sicurezza, più coordinata e robusta, che guarda inevitabilmente contenimento e deterrenza contro l’Iran e i suoi proxy regionali. Aspetto che piace a Israele, viceré americano nell’area e nuovo alleato di ferro emiratino grazie agli Accordi di Abramo; il ministro della Difesa israeliano ha detto pubblicamente che il Paese sta aiutando a costruire una “alleanza per la difesa aerea del Medio Oriente” guidata dagli Stati Uniti. Inoltre diventa un passo fondamentale per convincere Abu Dhabi — e di riflesso Riad — che gli Stati Uniti non stanno voltando le spalle agli alleati arabi del Golfo e sono invece disposti a impegnarsi per la loro sicurezza fondamentale.
Qui sta parte della profondità dell’impegno americano. Il tentativo è di convincere questi Paesi, e persino Israele, ad abbandonare un decennio di diversificazione strategica, in particolare per quanto riguarda i legami con la Russia e la Cina, e a riprendere un quadro di sicurezza — e non solo — in cui Washington funge da centro di coordinamento. Su questo, l’amministrazione Biden avrà anche il compito di far percepire alle proprie collettività, civili e politiche, che questo rinvigorimento dell’impegno mediorientale è nell’interesse degli Stati Uniti (perché fondamentalmente l’America First di Donald Trump è stato abbandonato più nella forma che nella sostanza).
Questa struttura di sicurezza regionale, se si dimostrerà efficace e duratura, potrebbe essere un fattore chiave — non solo nella narrazione — per ridimensionare l’impronta militare statunitense nella regione e trasferire sempre più l’onere della difesa sui partner locali. Contemporaneamente rassicurando gli alleati della presenza Usa e tenendoli a distanza di sicurezza da un’influenza russa e soprattutto cinese, potrebbe produrre svantaggio strategico. Questo è il messaggio da far passare anche tra gli americani.
Non è un obiettivo semplice: se per esempio un accordo potrebbe sganciare gli Emirati da progetti dual use con la Cina, come quelli attenzionati dalla Cia al Khalifa Port della capitale emiratina (in un terminal gestito dalla Cosco), secondo Jacopo Scita — al Sabah doctoral fellow alla Durham University — Washington ha bisogno di maggiore spinta, magari includendo nell’intesa anche commercio, tecnologia e ricerca scientifica (e se ne parla in effetti).
“Se l’obbiettivo strategico principale della visita di Biden nel Golfo è quello di allontanare i paesi del GCC dalla Cina, io credo che i rischi di un insuccesso siano alti”, spiega Scita a Formiche.net: “Piuttosto, vedo più realistico immaginare un successo tattico, rilanciare l’idea che il principale partner di sicurezza dei Paesi arabi del Golfo rimanga Washington e rendere chiaro ai propri interlocutori arabi che questa dimensione rappresenta un punto particolarmente critico per gli Stati Uniti nella competizione con Pechino”.
Il punto cruciale è che sia l’Arabia Saudita che gli Emirati hanno siglato con la Cina le cosiddette Comprehensive Strategic Partnership, ovvero il tipo di partenariato che sta all’apice della gerarchia dei rapporti bilaterali che la Cina intrattiene con la regione. “A mio avviso — aggiunge Scita — l’errore è credere che la scelta di Riad e Abu Dhabi di coltivare i rapporti con la Cina sia in qualche modo conseguenza del supposto disengagement di Washington dal Golfo. Al contrario, soprattutto per quanto riguarda gli Emirati, il livello di interconnessione socio-economica con la Cina è sostanziale e riflette una volontà di espansione condivisa”. Basti pensare che del circa mezzo milione di cinesi che vivono in tutto il Medio Oriente, più della metà risiedono negli Emirati.
Per Scita, Arabia Saudita e UAE hanno consapevolezza che la Cina non ha né capacità né volontà di offrire un ombrello di sicurezza alternativo a quello statunitense, “di conseguenza è sbagliato leggere nei crescenti rapporti tra Golfo e Cina un tentativo di sostituzione degli Stati Uniti. Piuttosto, ci si può aspettare che paesi come gli Emirati tentino di utilizzare i rapporti con la Cina come strumento di leverage nei confronti di Washington”.
Allo stesso tempo, però, la Cina è una potenza in espansione che, soprattutto sotto la guida di Xi Jinping, ha aumentato “qualità e quantità” della propria proiezione nelle periferie. È chiaro che aree come il Golfo siano naturalmente più ricettive riguardo l’espansione cinese, sia perché esiste una significativa compatibilità economica, sia perché politicamente meno sensibili alle criticità del modello socio-politico cinese.
”In questo senso, per gli Stati Uniti diventa più difficile impostare una campagna di pressione sui paesi del Golfo, mancando quasi totalmente quell’aspetto di difesa dei valori occidentali che invece, per esempio, sembra essere tornato al centro delle relazioni euroatlantiche”, secondo il ricercatore di Durham: “La questione per gli Stati Uniti, dunque, mi sembra essere più quella di cercare una sorta di coabitazione con la Cina nel Golfo che tentare di arginarne la presenza”.
I termini di questa coabitazione sono difficili da definire. Per esempio, già dai tempi dell’amministrazione Obama, gli Stati Uniti avevano lamentato il free-riding di una Cina che accresceva la propria impronta economica nel Golfo sfruttando l’ombrello di sicurezza garantito da Washington. “Questo — aggiunge Scita — è un aspetto su cui l’amministrazione Biden potrebbe tentare di lavorare, cercando di responsabilizzare maggiormente Pechino senza rinunciare al proprio ruolo storico di principale partner di sicurezza dei paesi del Golfo”.