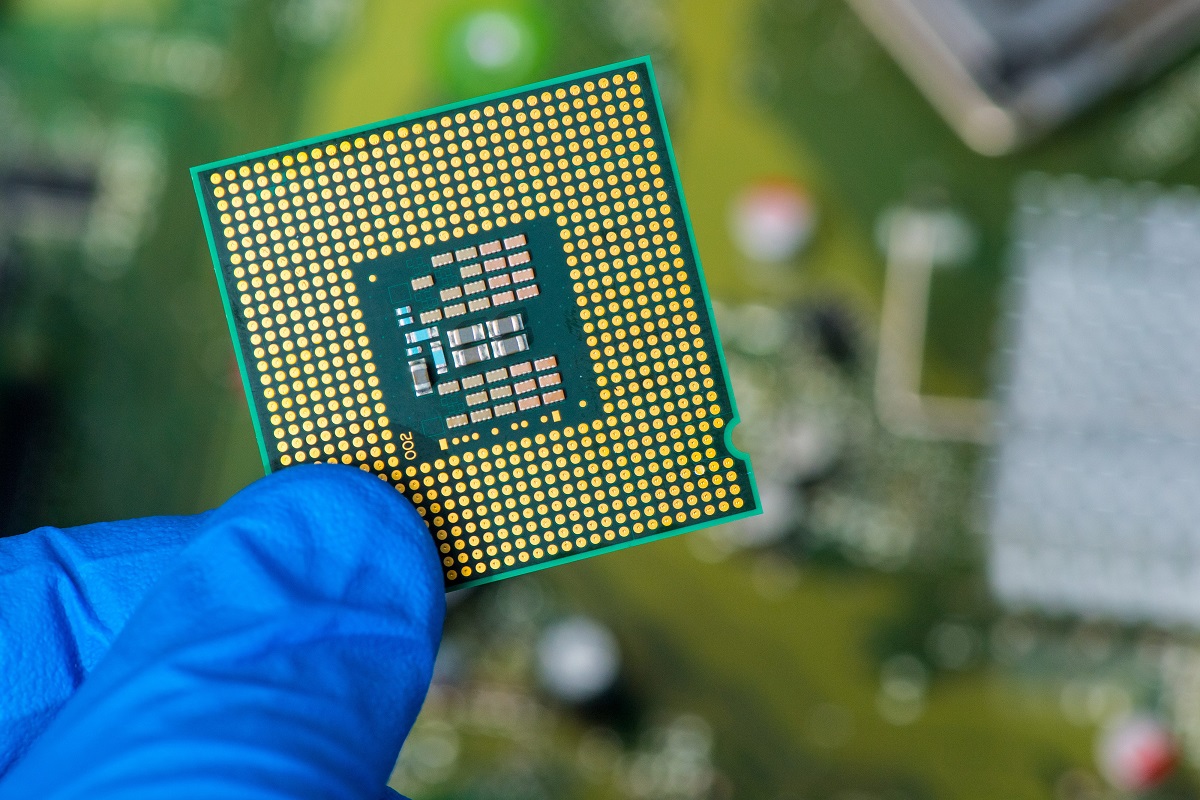Digitale, energia e farmaceutica. Un report evidenzia una perdita di competitività dell’Europa tuttora in atto. L’analisi comparativa di Stefano da Empoli, presidente Istituto per la Competitività (I-Com)
Lunedì a Washington, o meglio a poche miglia nel campus dell’Università del Maryland, è andato in scena il terzo atto del Trade and Technology Council, lo strumento di dialogo che Unione europea e Stati Uniti si sono dati per superare le incomprensioni dell’era trumpiana. Prendendo anche atto che, dopo il ventennio glorioso della globalizzazione, commercio estero e competitività tecnologica sono diventati un connubio troppo strategico per essere lasciato solo nelle mani del mercato e delle imprese private.
Casualmente, proprio il giorno dopo, alla presenza del presidente Biden, TSMC, l’azienda taiwanese che produce gran parte dei chip più sofisticati venduti nel mondo, annunciava in Arizona l’inaugurazione della sua prima fabbrica statunitense, ampiamente incoraggiata dall’establishment Usa, preoccupato dalle mire espansionistiche della Cina sull’isola, e dalle possibili conseguenze catastrofiche di uno stop all’export verso gli Stati Uniti, e al contempo desideroso di garantire un futuro manifatturiero al proprio Paese.
Sempre lo stesso giorno, per uno strano scherzo del destino, il libro “Chip War. The fight for the world’s most critical technology” dello storico statunitense Chris Miller, che racconta tra le altre la storia epica di TSMC, ha vinto il premio del Financial Times come migliore business book del 2022. Merito della qualità del libro, che racconta con stile godibilissimo questioni solitamente riservate a ingegneri e scienziati, ma anche dell’assoluta centralità dei semiconduttori per una serie di settori nevralgici di un’economia moderna, dall’ICT all’automotive. Così come della necessità crescente dei singoli Paesi di tenere sotto controllo le catene del valore, assicurandone l’operatività anche in situazioni di crisi, e provando a conservare o accumulare situazioni di vantaggio competitivo fondate su tecnologie chiave.
È stato certamente il secondo profilo, innescato dalla crescita impetuosa della Cina nell’ultimo ventennio, a determinare un primo cambio di paradigma delle élite occidentali, e in primis di quelle statunitensi, di fronte alla globalizzazione e a rivalutare il ruolo delle politiche industriali. Peraltro, a differenza del Giappone, la cui ascesa negli anni Ottanta aveva pure sollevato un’ondata di panico negli Stati Uniti, la Cina non pone solo una sfida economica ma anche politica, sia per dimensione che per sistema istituzionale e di valori. In questo caso, dunque, gli Stati Uniti hanno messo in campo negli ultimi anni, su una linea di sostanziale continuità tra le amministrazioni Trump e Biden, una serie di misure sempre più stringenti, da un lato per frenare il ritmo del progresso tecnico cinese, grazie essenzialmente a provvedimenti di controllo dell’export e alla messa al bando dei prodotti tecnologici di punta provenienti dall’impero di mezzo, dall’altro per aumentare la competitività dell’industria americana, a suon di sussidi multimiliardari e norme a favore del Buy American, contenuti ad esempio nel Chips and Science Act e nell’Inflation Reduction Act, approvati negli ultimi mesi.
L’Europa, pur avendo una maggiore tradizione di politica industriale rispetto agli alleati di Oltreoceano, ha aspettato a lungo prima di accorgersi che avrebbe dovuto mettere in campo strumenti comuni ad hoc per evitare di perdere competitività rispetto ad altre aree del mondo e soprattutto alla Cina. L’esempio del fotovoltaico rimane un caso di specie, con decine di miliardi di sussidi spesi dai singoli Stati membri, Italia in testa, in larga parte andati a gonfiare ricavi e profitti dei produttori cinesi di pannelli e di altri segmenti chiave di quella catena del valore.
Sono state le due crisi sistemiche degli ultimi tre anni, pandemia prima e invasione russa dopo, ad accelerare la presa d’atto europea. Imponendo un ripensamento complessivo, testimoniato dall’idea recentemente espressa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di un fondo sovrano europeo. Difficile da realizzare nell’immediato, a causa dell’ostilità tedesca e dei Paesi cosiddetti “frugali”, ma che sarebbe stata del tutto impensabile prima delle due recenti crisi. Che hanno testimoniato l’assenza di pensiero strategico in Europa (e non solo) in due settori chiave come l’energia e la farmaceutica. Due dei tre settori (il terzo è per l’appunto il digitale, nel quale ricadono ovviamente anche i semiconduttori) sui quali l’Istituto per la Competitività (I-Com) ha voluto fare il punto con uno studio dedicato all’autonomia strategica europea, presentato nei giorni scorsi a Bruxelles.
Il report I-Com evidenzia una perdita di competitività dell’Europa tuttora in atto. Ad esempio, in un filone tecnologico chiave come l’intelligenza artificiale (AI), dove gli investimenti privati europei, pur in aumento (a 6,4 miliardi di dollari nel 2021), risultano ancora un settimo di quelli statunitensi e poco più di un terzo di quelli cinesi. Questo dato di input si traduce in un output in termini di brevetti che riflette questa sproporzione. I brevetti registrati in information technology (che include l’AI, in assenza di una classificazione a parte) vedono nell’ultimo anno disponibile (2019) l’Europa rimanere lievemente al di sotto della soglia dei 10mila mentre Cina e Stati Uniti si contendono il primato, con la prima intorno ai 52mila e i secondi a 44mila. Meglio dell’Unione europea fanno anche Giappone e Corea del Sud.
A destare preoccupazione non è solo il dato quantitativo (i brevetti chiaramente vanno pesati per il loro valore effettivo). Se si prendono in esame le prime venticinque istituzioni di ricerca per numero di pubblicazioni scientifiche su temi AI, 18 hanno sede negli Usa, Cina, Regno Unito e Svizzera ne ospitano due ciascuna e 1 si trova in Corea del Sud. D’altronde, questo divario è correlato alla diversa capacità dei diversi Paesi di attrarre talenti dall’estero. Se gli Stati Uniti hanno dato i natali al 20% dei ricercatori top impegnati in campo AI a livello mondiale (buon dato ma secondo al 29% cinese e di poco superiore al 18% Ue), essi ne ospitano ben il 59%, mentre l’Ue vede contrarsi la percentuale degli scienziati residenti al 10%, a poca distanza dalla Cina all’11%. D’altronde, il libro di Miller, al pari di quello di Alessandro Aresu “Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia”, narra la storia dei tanti protagonisti non americani dell’industria dei semiconduttori, dall’ungherese Andy Grove al cinese Morris Chang, che hanno contribuito al successo scientifico e industriale degli Usa. Con la differenza che chi veniva dall’Estremo Oriente (Morris Chang) è tornato in patria (in questo caso non più la Cina continentale ma Taiwan) per dare un contributo determinante all’esplosione del settore, grazie alla nascita e allo sviluppo di TSMC.
Rispetto a Estremo Oriente e Stati Uniti, il ruolo dell’Europa nei semiconduttori è più marginale. Secondo il racconto di Miller e un’eccellente tabella contenuta nel libro di Aresu, l’unico segmento presidiato in maniera sostanzialmente esclusiva da aziende europee, in questo caso l’olandese ASML, è quello dei macchinari e in particolare le tecnologie a litografia ultravioletta per produrre i semiconduttori più sofisticati (sotto i 7 nanometri). Naturalmente ci sono tante altre imprese europee rilevanti, tra le quali l’italofrancese STMicroelectronics, ma nessuna ha un ruolo altrettanto strategico. Al contrario delle diverse asiatiche e statunitensi.
Rimanendo in ambito digitale, neppure il 5G, dove pure l’Europa conta una volta tanto due protagonisti industriali e tecnologici assoluti, la svedese Ericsson e la finlandese Nokia, dei 4-5 più affermati nel settore, regala a ben vedere grandi soddisfazioni. Né sul piano della ricerca, dove la Cina fa la parte del leone sui brevetti registrati con il 41,4% (davanti a Corea del Sud, con il 19,9%, e Stati Uniti, con il 15,4%); né su quello degli investimenti programmati dagli operatori telefonici tra 2022 e 2025 (più del doppio nell’area Asia-Pacifico e i due terzi in più negli Stati Uniti rispetto all’Europa).
Un altro settore nel quale il Vecchio Continente ha forti tradizioni è l’industria farmaceutica. Ma questa posizione privilegiata è andata a deteriorarsi nel tempo, come testimonia il trend di crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo, che, dopo essere stato superiore a quello dell’industria americana nel periodo 2007-2011, si è collocato stabilmente intorno alla metà nel decennio più recente. Non è forse un caso che, delle tante imprese che si sono cimentate con lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il Covid, al traguardo siano arrivate prime e con maggiore successo un’impresa americana e una certamente europea ma supportata in maniera decisiva a livello finanziario, produttivo e distributivo da un’azienda statunitense.
Anche sul fronte energetico, l’analisi di I-Com si sofferma su dati in gran parte sconfortanti. Se la dipendenza dalla Russia per l’approvvigionamento di combustibili fossili è sotto gli occhi di tutti, il quadro non è meno confortante sulle energie alternative (che hanno tuttavia il vantaggio di essere prodotte internamente). Della filiera manifatturiera del fotovoltaico abbiamo già accennato, con una catena del valore che ancora oggi vede un ruolo dell’Unione europea che non va al di là del 11% del valore aggiunto in nessun segmento, tranne il monitoraggio e il controllo (dove raggiunge il 23%). Sulle batterie, che oggi rappresentano il 40% circa dei costi di un’autovettura elettrica, si rischia di ripetere lo stesso film, passando dalla tragedia alla farsa per dirla con Karl Marx. Pagata però a caro prezzo da un altro settore industriale, quello dell’automotive, con profonde tradizioni e numeri imprenditoriali e occupazionali di valore assoluto.
Sarebbe certamente ingeneroso dire che l’Unione europea, con le sue istituzioni, sia rimasta inerte negli ultimi anni. D’altronde è facile sparare su Bruxelles quando le colpe sono spesso nella mancata capacità degli Stati membri di mettersi d’accordo, superando piccoli e grandi egoismi nazionali. Le tristi vicende dei budget comunitari, tagliati nelle notti decisive proprio nelle voci di spesa dedicate all’innovazione e alle nuove tecnologie, sono un ricordo che ancora brucia. Così come, rispetto al Chips Act, che prova faticosamente a inseguire gli investimenti di Asia orientale e Stati Uniti, vanno censurate le resistenze degli Stati membri a mettere a disposizione della Commissione europea risorse extra-budget di pochi miliardi di euro.
Certamente gli IPCEI (i progetti importanti di interesse comune europeo) e le alleanze industriali, i tasselli principali di una politica industriale europea in via di costruzione, sono strumenti utili ancorché imperfetti con i quali gli Stati membri provano a far fronte alla perdita di competitività dell’Ue. Così come fusioni e acquisizioni che diano vita a campioni europei in grado di farsi valere a livello mondiale in settori ad elevata intensità di capitale. In più occorre certamente accelerare la velocità di intervento. Il Chips and Science Act statunitense è già operativo (e grazie a quello TSMC ha annunciato in occasione della cerimonia di inaugurazione del proprio impianto in Arizona investimenti complessivi negli Usa di 40 miliardi di dollari), mentre il Chips Act europeo ha, bene che vada, diversi anni davanti a sé prima di giungere alla fase attuativa. Altre misure andranno probabilmente messe in campo dall’Ue e dai suoi Stati membri ma nel frattempo occorre fugare il dubbio da due equivoci di fondo, allorché si parla di autonomia strategica europea.
Il primo è scambiare il giusto riconoscimento delle interdipendenze tra nazioni con un atteggiamento protezionista. Sarebbe sbagliato tradire i principi del libero commercio, che pure hanno decretato il successo di tante economie europee nel dopoguerra, a cominciare da Germania e Italia. Piuttosto, occorre osservare quello che fanno gli altri Paesi e provare ad adattarsi di conseguenza. Se necessario, ad esempio, reagendo verso misure che potrebbero mettere a repentaglio la competitività europea, come nel caso dell’Inflation Reduction Act statunitense, che lega gli incentivi previsti all’acquisto di beni prodotti negli USA, salvo eventuali eccezioni. Tuttavia, questa presa d’atto deve avvenire in base a un principio di proporzionalità e attraverso una chiara definizione degli step da intraprendere per minimizzare i rischi di una guerra commerciale, dannosa per tutti (non solo economicamente ma anche strategicamente, specie se condotta contro Paesi alleati). Allo stesso tempo, una politica industriale proattiva non deve coincidere con un ritorno dello Stato imprenditore ma semmai con un maggiore riconoscimento della partnership pubblico-privato, sempre più necessaria per gestire le sfide del presente e soprattutto del futuro. Dal modo in cui l’Europa saprà mettere le dovute energie (e risorse) in questi due passaggi chiave, con un reset delle politiche commerciali e industriali, dipenderà un pezzo importante della propria competitività e soprattutto del benessere dei propri cittadini.