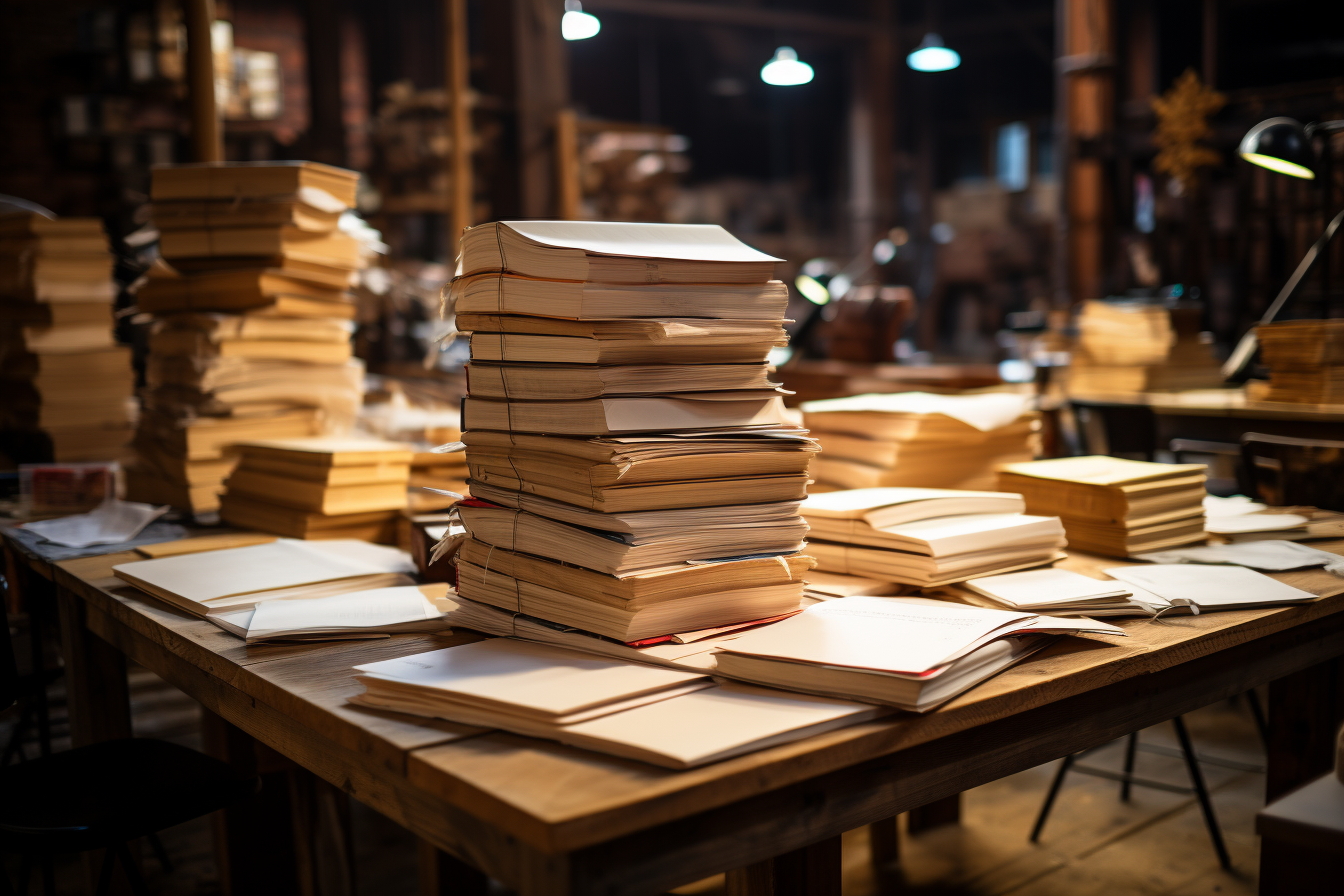Dalla cultura la cultura si gemma. Dal patrimonio nasce la produzione. Prima di guardarne gli aspetti manageriali, è forse importante iniziare a capire bene le ragioni per le quali, considerare come separate queste espressioni della nostra società è probabilmente un errore
Definire quali siano, o debbano essere, le funzioni della cultura, è un’operazione sempre delicata. È chiaro che, con l’estensione che è stata attribuita ormai a questo termine, la cultura può essere tutto e il contrario di tutto. Pur in questo scenario così relativista, ci sono alcuni punti fermi che possono aiutare a meglio comprendere la questione. Tra di essi, per quanto paradossale possa sembrare, c’è un principio di natura “economica” che, senza cedere al fascino dell’accademia, evidenzia come la cultura non si esaurisca con il suo consumo. Anzi, cresca.
È un principio quasi poetico, ma rigoroso, che ci incita a riflettere sul ruolo delle istituzioni culturali del nostro Paese. Dopo decenni di lotta, si può finalmente affermare che gli istituti culturali non devono inscenare una dinamica sacrale tra l’essere umano e la conoscenza. Non più musei senza didascalie. Non più termini eccessivamente ridondanti. Spazio alla chiarezza, alla volontà di attrarre i visitatori. Meno retorico orrore nei confronti del comprensibile.
La comprensione che la cultura possa essere anche divertente, e che non debba interpretare gli scritti critici come cilicio che avvicina alla divinità sapienza, ha generato non pochi progressi nei rapporti tra le istituzioni culturali e i cittadini, così come fatto sì che in alcune delle nostre città, la cultura divenisse concretamente una dimensione centrale dell’esistenza umana, e dell’essere parte della collettività. Ora che dunque la cultura si è emancipata dai suoi sacerdoti, ora che la divulgazione è persino più importante dell’erudizione, il nostro Patrimonio Culturale può guardare a sé stesso in modo completamente nuovo.
Superata, ormai, la faziosa attitudine di chi opponeva la tutela alla valorizzazione, con la pretesa di poter scindere l’atto della respirazione privilegiando l’inspirazione all’espirazione, si può guardare con più lucidità e maggiore onestà intellettuale a ciò che il nostro Colosseo, i nostri Musei Civici, le nostre Biblioteche, possono rappresentare per il nostro Paese. Una riflessione importante, in questo senso, può provenire proprio da queste ultime. Chi non frequenta con quotidiana passione il mondo della cultura probabilmente non se ne sarà accorto, ma le biblioteche, negli ultimissimi anni, stanno uscendo un po’ alla volta da una crisi d’identità che ha afflitto il settore della pubblica lettura per circa un decennio.
Una crisi che ha portato a riflessioni importanti che hanno riguardato elementi costitutivi dell’istituzione: quale ruolo nella società, quale funzione per i cittadini, quale unicità di servizio rispetto alla grande disponibilità di risorse online. Una delle più grandi leve che hanno dato nuova linfa vitale al settore bibliotecario è stato il concetto di “accessibilità” alla cultura. Un concetto molto potente, che ha visibilmente ringiovanito queste vecchie signore che abitavano malinconiche i nostri quartieri, e che oggi organizzano festival di videogame e incontri tra cittadini.
Ed è riuscito ad ottenere tale trasformazione semplicemente constatando che queste nostre biblioteche non erano, come si è pensato a lungo, delle casseforti che regalavano gioia soltanto a chi ne conoscesse la combinazione, non erano, in altri termini, dei luoghi in cui la cultura si conservava e basta. Al contrario, erano i luoghi che, per propria funzione ormai millenaria, conservavano la conoscenza e la cultura allo scopo di renderla accessibile a chi volesse. Una postilla, vero, ma che cambia completamente le carte in tavola.
Grazie a questa postilla, infatti, la Biblioteca non è soltanto il luogo in cui si conservano i libri, ma è anche l’Istituzione che si impegna affinché i libri vengano letti. Non è soltanto il luogo in cui si possono leggere gratuitamente i quotidiani locali e nazionali, è anche il luogo in cui si possono commentare tali quotidiani, con l’obiettivo di ripristinare un dialogo tra estranei conviventi all’interno dello stesso perimetro urbano, e stimolare così la rinascita di quel concetto di comunità che dopo anni di alienante individualismo adesso stiamo riscoprendo come un valore fondamentale della nostra storia (e della nostra specie).
Il nostro Patrimonio Culturale tutto, quindi, dovrebbe da questa vicenda prendere spunto. Non replicando pedissequamente quanto già formulato dalle biblioteche, ma interrogandosi su quale debba essere il proprio ruolo all’interno della nostra società, nel nostro tempo, nel nostro contesto comunitario e globale. Oggi, ad esempio, la nostra grande passione per le dicotomie ha trovato una nuova applicazione. E così, nei casi in cui è stata finalmente superata, abbiamo sostituito la divisione tra tutela e valorizzazione nella divisione tra Patrimonio Culturale e Produzione culturale.
A differenza della precedente, tale distinzione è fondata, ha senso, ed è importante tenerla ben chiara quando si parla di “caratteristiche”. Ma al pari dell’altra, diviene completamente vana e sterile se la distinzione si trasforma in distanza. Oggi che sappiamo che un bene culturale ha il valore che la collettività gli attribuisce; oggi che ci è noto che la cultura è un elemento che nel consumo cresce, e nella condivisione arricchisce; oggi che sappiamo che rendere accessibile la cultura non significa tenerla su uno scaffale, ma significa renderla desiderabile; ebbene, oggi, continuiamo ad interpretare il nostro Patrimonio Culturale come concettualmente separato dalle nostre produzioni.
Le nostre industrie culturali e creative (che vanno dal cinema alla produzione di opere d’arte figurative), seguono percorsi, processi completamente separati da quelli delle istituzioni culturali. Sono differenti le catene di creazione del valore, sono differenti gli interlocutori, sono differenti i fondi. Il contemporaneo non è continuità del tempo, ma è isolato dallo stesso. Abbiamo la Storia dell’Arte e abbiamo l’arte contemporanea. Abbiamo la musica classica, e poi abbiamo la produzione musicale.
Certo, sono mondi che si lambiscono, e che spesso si incrociano, ma trovarsi allo stesso tavolo di un convegno, e poi seguire strade separate, non significa essere amici. Dalla cultura la cultura si gemma. Dal patrimonio nasce la produzione. Prima di guardarne gli aspetti manageriali, è forse importante iniziare a capire bene le ragioni per le quali, considerare come separate queste espressioni della nostra società è probabilmente un errore.