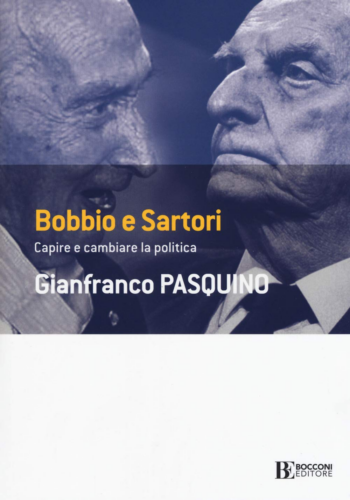Verso la fine della sua lunga e produttiva vita, riflettendo sul suo lascito culturale, Sartori esprimeva la preoccupazione di essere (già) stato dimenticato. Per fortuna è possibile suggerire perché i suoi scritti non solo mantengono grandissima rilevanza, ma non hanno perso quasi nulla della loro carica esplicativa, propulsiva, persino eversiva. Gianfranco Pasquino ricorda Giovanni Sartori a 100 anni dalla sua nascita a Firenze, il 13 maggio 1924
Nato cent’anni fa a Firenze, Giovanni Sartori è stato uno dei quattro/cinque più importanti studiosi di politica del XX secolo. Tutt’altro che autore di un solo grande libro, ha dato contributi fondamentali, non superati in tre settori: l’analisi della democrazia, lo studio dei sistemi di partiti, l’ingegneria costituzionale, vale a dire l’applicabilità/applicazione delle conoscenze politologiche alla riforma delle istituzioni. Talvolta, verso la fine (2017) della sua lunga e produttiva vita, riflettendo sul suo lascito culturale, Sartori esprimeva la preoccupazione di essere (già) stato dimenticato. Non bastano qualche sparsa citazione e interviste pop a smentire i suoi timori.

Per fortuna, senza fare ricorso alla classica ricerca di “ciò che è morto e ciò che è vivo”, è possibile, a mio modo di vedere, suggerire perché gli scritti di Sartori non solo mantengono grandissima rilevanza, ma non hanno perso quasi nulla della loro carica esplicativa, propulsiva, persino eversiva. Colloco a fondamento di qualsiasi analisi e proposta il principio metodologico formulato da Sartori e contenuto nella frase che segue: “Chi conosce un solo sistema politico non conosce neppure quel sistema politico”. Senza (saper) comparare non potremo mai dire ciò che è valido e perché e ciò che è fuori norma e perché. Né, meno che mai, saremo in grado di proporre cambiamenti migliorativi nel senso desiderato.
Facendo sua una cruciale considerazione di Karl Popper, che è preferibile avere una teoria anche sbagliata a nessuna teoria (sulla prima, correggendo, si può, costruire; sul nulla, no), Sartori, anzitutto, diffidava e rigettava le “narrazioni” e proponeva la elaborazione di teorie probabilistiche.
“Ogniqualvolta si presentano le condizioni a, b, e c è probabile che ne derivino le conseguenze x, y, z”. Ovviamente, cambiando le condizioni è molto probabile che le conseguenze siano differenti. Due altri fondamentali principi stanno alla base delle analisi e degli insegnamenti di Sartori: la conoscenza profonda dell’argomento in oggetto, vale a dire, nel suo lessico, “avere la bibliografia in ordine”, e la pulizia concettuale.
I concetti hanno una etimologia e una storia che non debbono essere né “stiracchiati” (su espressione) e stravolti né cancellati. No, i “novisti” non erano i suoi interlocutori preferiti, e neppure i cultori e i divulgatori del politicamente corretto.
Da ultimo, voglio ricordare quella che è stata ed è rimasta, sottovalutata e sostanzialmente incompresa, la sua aspirazione civile: fare della scienza politica il fulcro di una cultura politica liberaldemocratica che sconfiggesse il pensiero del cattolicesimo sociale e il marxismo nelle sue varianti, gramscismo compreso.
Quelle due culture politiche sono affondate nelle loro contraddizioni e nella loro incapacità di rinnovamento, ma la scienza politica non è (ancora?) riuscita a colmare il vuoto nel quale galleggiano populisti, sovranisti e altri brutti tipi. Il compito che Sartori si era posto mantiene tutta la sua validità. Gli direi che il suo lascito esiste, è imponente, contiene risposte. I suoi libri, “Democrazia. Cosa è”, “Parties and party systems”, “Ingegneria costituzionale comparata”, sono letture essenziali e gratificanti che mantengono assoluta validità. Le considero fra le letture migliori, oggi e domani.