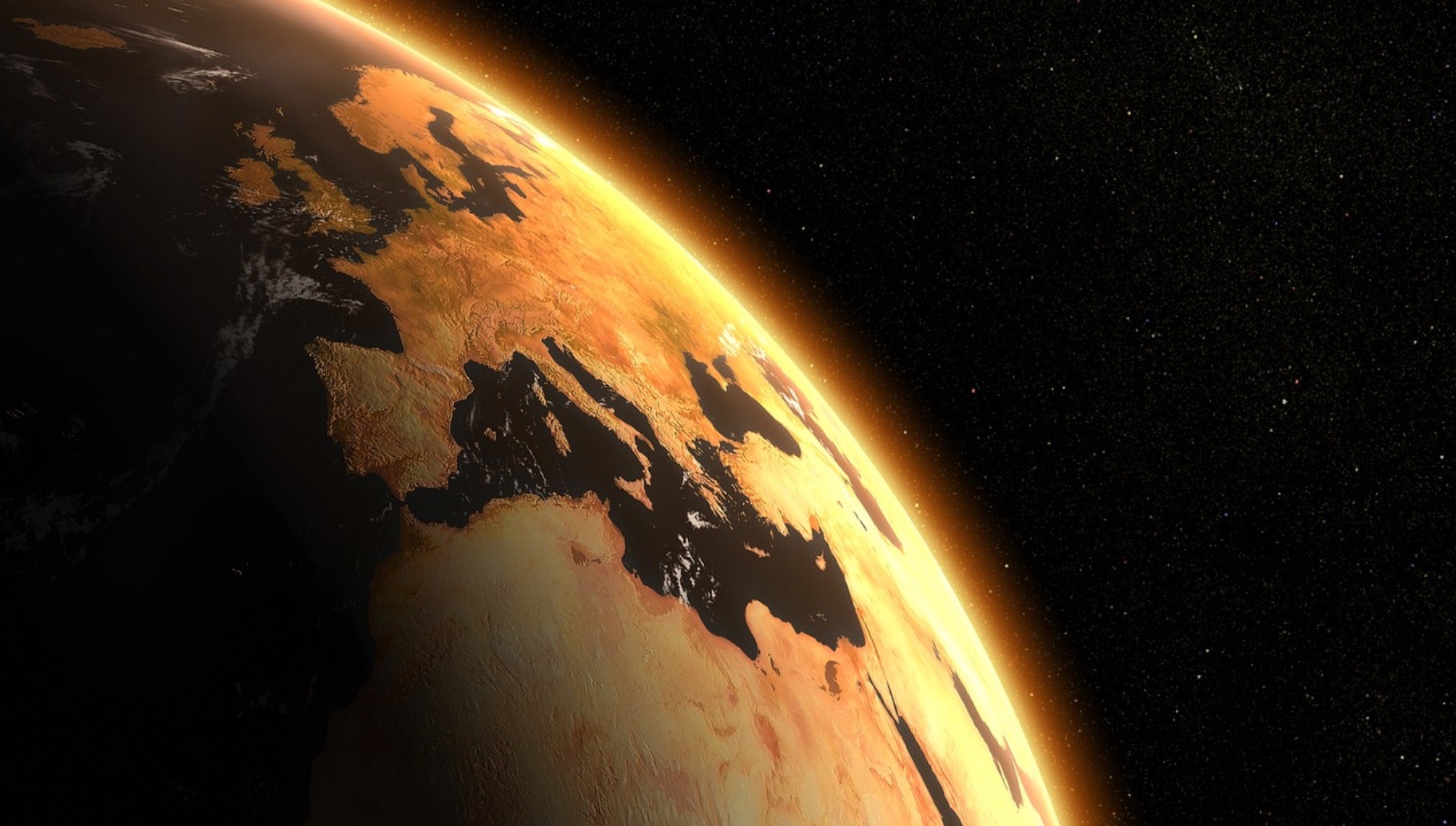Una giornata questa istituita nel 1972 durante la Conferenza mondiale sull’ambiente di Stoccolma, dove furono definiti i principi sui diritti dell’ambiente e le responsabilità dell’uomo per la sua salvaguardia. Dopo oltre cinquant’anni siamo ancora e sempre più a confrontarci con problemi ambientali che diventano sempre più urgenti
“La nostra terra. Il nostro futuro. Siamo #GenerationRestoration”. Questo il tema scelto dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite (Unep) per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2024: difesa del territorio, ripristino del suolo, riduzione della desertificazione e resilienza alla siccità. Tutti siamo coinvolti nella ricostruzione degli ecosistemi. Una giornata, quella del 5 giugno, istituita nel 1972 durante la Conferenza mondiale sull’ambiente di Stoccolma, dove furono definiti i principi sui diritti dell’ambiente e le responsabilità dell’uomo per la sua salvaguardia.
La Dichiarazione di Stoccolma, per la prima volta, mette nero su bianco che l’uomo ha diritto fondamentale “alla libertà, all’eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell’ambiente davanti alle generazioni future”. E ancora “le risorse naturali della Terra, ivi incluse l’aria, l’acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future. L’uomo ha la responsabilità di salvaguardare e amministrare saggiamente la vita selvaggia e il suo habitat”.
Lo stesso anno, sia detto per inciso, il Club di Roma pubblicava il rapporto “Limiti della crescita”. Un rapporto che, riprendendo lo scenario della Conferenza di Stoccolma e alla luce della crisi petrolifera dei primi anni Settanta, avvertiva governi e cittadini che il nostro pianeta aveva dei limiti fisici ben precisi. Se la crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento della risorse fossero continuate inalterate, i limiti dello sviluppo del pianeta sarebbero stati raggiunti in un momento imprecisato nei successivi cento anni. Occorreva, da subito, modificare lo sviluppo per giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche in futuro.
Dopo oltre cinquant’anni siamo ancora e sempre più a confrontarci con problemi ambientali che diventano sempre più urgenti da affrontare e risolvere: il cambiamento climatico, la desertificazione e la siccità, il degrado del suolo, la perdita della biodiversità, l’uso efficiente delle risorse idriche, la salvaguardia degli oceani e dei territori. Questa giornata, nelle intenzioni dell’Assemblea dell’Onu che l’ha voluta in quell’ormai lontano 15 dicembre del 1972, esorta “i governi e le organizzazioni delle Nazioni Unite a intraprendere in quel giorno, ogni anno, in tutto il mondo, attività riaffermando la loro preoccupazione per la conservazione e il miglioramento dell’ambiente, al fine di approfondire la consapevolezza ambientale e di perseguire la determinazione espressa dalla Conferenza”.
Quest’anno, come abbiamo detto, il messaggio veicolato per incoraggiare la consapevolezza e l’azione di tutti a favore dell’ambiente, si concentra sul “ripristino del territorio, sulla desertificazione e sulla resilienza alla siccità”. Il 2024 segna il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e si concluderà a dicembre con la Conferenza delle Parti nella capitale saudita, Riyadh. Prevede misure e azioni per lo sviluppo dei territori nelle zone aride volte a prevenire e ridurre il degrado di queste terre; riabilitare le aree parzialmente degradate; rigenerare le terre desertificate. La loro attuazione si concretizza tramite programmi nazionale e regionali come parti integranti delle politiche di sviluppo sostenibile. Essenziale una stretta collaborazione internazionale tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, con una particolare responsabilità dei governi interessati nel “creare un ambiente di supporto che aiuti le popolazioni locali ad arrestare il processo di degrado delle terre”.
Secondo dati forniti dalla stessa Convenzione, fino al 40% del territorio del pianeta è degradato, riguarda direttamente metà della popolazione mondiale e minaccia circa la metà del Pil globale (44 trilioni di dollari). Il numero e la durata dei periodi di siccità sono aumentati del 29% dal 2000. Se non si interviene subito, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale. Non a caso il ripristino del territorio è un pilastro fondamentale del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030). Il tentativo è quello di potenziare la ricostruzione degli ecosistemi degradati o distrutti “per combattere la crisi climatica e migliorare la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento idrico e la biodiversità”.
In quanto ad emergenza siccità il nostro Paese non gode certo di buona salute. Secondo uno studio di Legambiente, presentato proprio in occasione di questa giornata, “dal 2020 a metà maggio 2024 nella Penisola si sono registrati 81 danni da siccità prolungata”. Lombardia, Piemonte e Sicilia le regioni più colpite. Per l’associazione ambientalista servono “interventi rapidi, concreti e integrati non più rimandabili”. E manda un appello al Governo Meloni indicando tre azioni per fronteggiare questo problema: “una ridefinizione di una regia unica da parte delle Autorità di bacino distrettuale; una strategia nazionale integrata a livello di bacini idrografici; e incentivare buone pratiche che permettano di trattenere il più possibile l’acqua sul territorio”.
All’Europa e alla prossima legislatura europea, Legambiente chiede di approvare una Legge quadro sulla resilienza climatica “per coordinare norme stringenti sull’adattamento, con efficaci piani nazionali e adeguate risorse economiche, in tutti i Paesi membri”. Secondo stime della Commissione europea, infatti, senza un’azione preventiva dei rischi climatici, “i danni da alluvioni, ondate di calore, siccità, incendi boschivi, perdite di raccolti o malattie potrebbero ridurre il Pil europeo di circa il 7% entro la fine del secolo”. Inoltre, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Adattamento Climatico, approvato a fine 2023, in Italia si stima “una riduzione del valore della produzione agricola pari a 12,5 miliardi di euro nel 2050 in uno scenario climatico con emissioni climalteranti dimezzate al 2050 e pari a zero al 2080”.
Gli esperti dell’Unep hanno approntato, per questa giornata, una Guida per aiutare tutti a essere coinvolti nel ripristino degli ecosistemi: sette modi per rendere concreta questa ricorrenza. Il primo riguarda “l’agricoltura sostenibile”. Almeno 2 miliardi di individui, soprattutto nelle aree più povere, dipendono dall’agricoltura per il loro sostentamento. Le imprese agricole possono sviluppare colture resilienti al clima e ridurre l’uso dei fertilizzanti per evitare di danneggiare la salute dei suoli. La “salvaguardia del suolo” con il 60% di tutte le specie che vi vive e il 95% del cibo che mangiamo e la seconda azione fondamentale.
E poi, “proteggere gli impollinatori”, riducendo l’inquinamento atmosferico e l’uso di pesticidi e fertilizzanti, preservare i prati, le foreste e le zone umide. “Ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce” che forniscono cibo e acqua a miliardi di persone, proteggono dalla siccità e dalle inondazioni e forniscono un habitat a innumerevoli piante e animali. “Rinnovare le aree costiere e marine”. Gli oceani e i mari forniscono all’umanità ossigeno, cibo e acqua, mitigando i cambiamenti climatici, aiutando ad adattarsi alle condizioni meteorologiche estreme.
Più della metà della popolazione mondiale vive nelle città. Consumano il 75% delle risorse del Pianeta; producono più della metà dei rifiuti globali e generano almeno il 60% delle emissioni di gas serra. Occorre “riportare la natura in città”, foreste urbane per migliorare la qualità dell’aria e mitigare le ondate di calore. E, infine, “finanziare il ripristino” con investimenti sulla natura che devono più che raddoppiare, fino ad arrivare ai 542 miliardi di dollari entro il 2030 per “raggiungere gli obiettivi mondiali su clima, biodiversità e ripristino degli ecosistemi”.