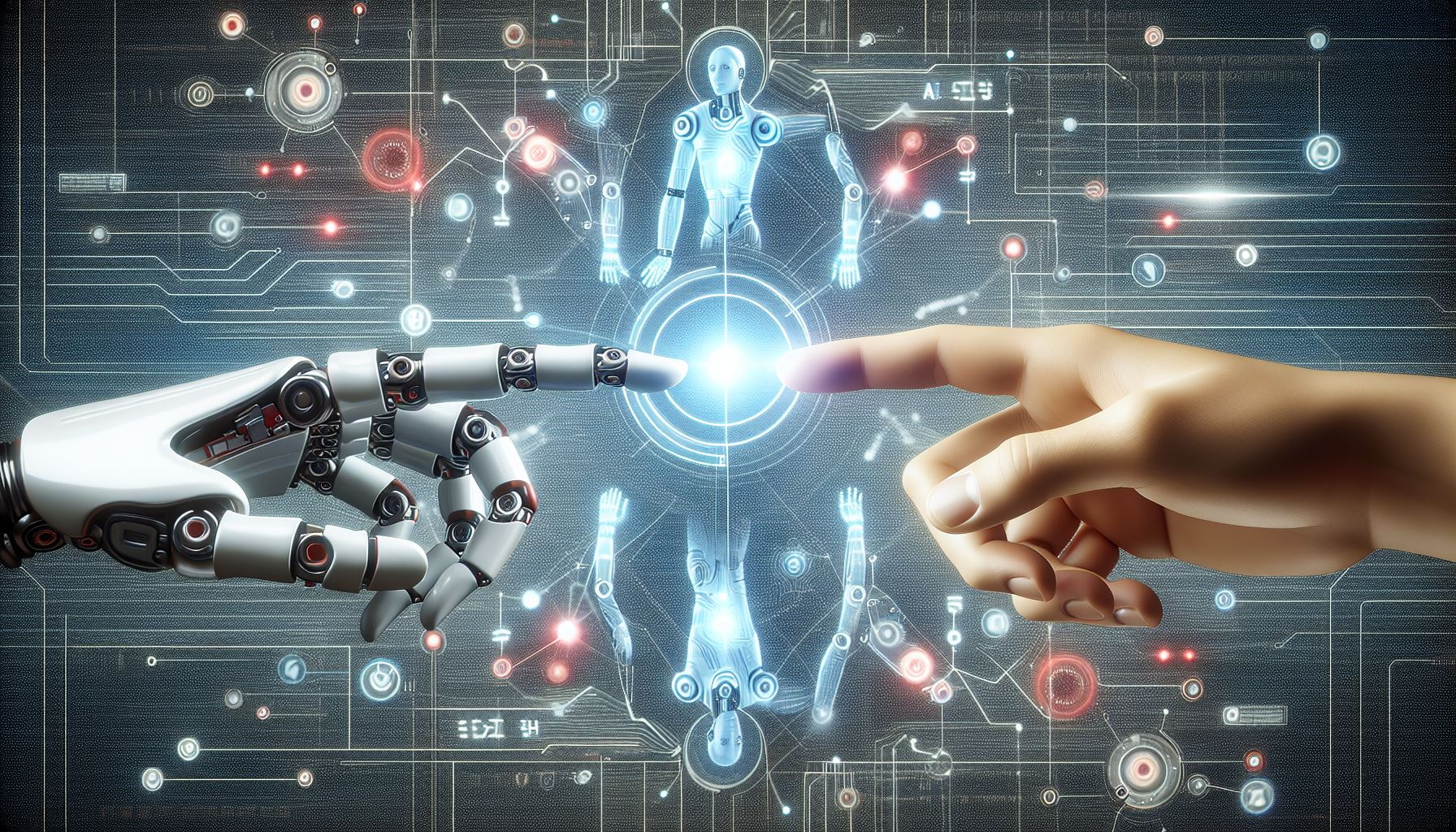Le economie dei Paesi Ocse stanno attraversando grandi sconvolgimenti e nessuno possiede attualmente una chiara visione delle azioni da intraprendere. Salvatore Zecchini analizza gli effetti dei progressi tecnologici (come l’Intelligenza Artificiale ma non solo) sul lavoro
Con l’avanzare dell’impiego delle nuove tecnologie nei processi aziendali, segnatamente la diffusione delle tecniche di intelligenza artificiale, aumentano tra i lavoratori le inquietudini per il rischio di vedersi rimpiazzati dall’automazione di attività finora privilegio dell’intervento umano. Una delle principali conseguenze è che la ripartizione funzionale del reddito prodotto tende a spostarsi dal fattore “lavoro” al “capitale” a parità di altre condizioni. Di questa tendenza si sono raccolti molti dati che mostrano in diversi Paesi l’arretramento della quota che va al “lavoro”. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma la persistenza negli anni ha dato alle organizzazioni sindacali lo spunto per chiedere l’intervento dei governi e per rivendicare maggiori incrementi salariali. La prossima stagione dei rinnovi contrattuali, che coinvolge circa un terzo dei lavoratori dipendenti, offrirà l’occasione per verificare se questa argomentazione ha un peso nei negoziati.
Qualora si realizzasse un’equipartizione dei guadagni di produttività realizzati dalle imprese in ogni settore economico, si dovrebbe assistere alla stabilità nel medio periodo della distribuzione del reddito tra capitale e lavoro, sempre che non intervengano modifiche radicali nella struttura dell’economia. Questo criterio di fatto non trova riscontro negli andamenti nell’ultimo trentennio. La distribuzione primaria del reddito si è spostata nel corso degli anni con tendenze prolungate in un senso e nell’altro, con differenze significative tra Paesi e settori.
Sull’andamento, tuttavia, grava l’incertezza della misurazione. Se le retribuzioni del lavoro dipendente possono essere rilevate, non altrettanto si può per i redditi dei lavoratori autonomi, in quanto sono la risultante di una combinazione di lavoro, capitale ed altro. Né è del tutto attendibile la consueta approssimazione di applicare la remunerazione media del lavoro dipendente per stimare la stessa componente per quello autonomo, perché di quest’ultimo non si conosce né la durata, né il tipo di prestazione. Pertanto, si fanno delle ipotesi e su questa base si stima l’incidenza del reddito da lavoro sulla formazione del reddito nazionale. Certezza si ha, invece, sulla quota di reddito acquisita dal lavoro dipendente, specialmente nel settore industriale in cui si rilevano con minore approssimazione durata e tipologie.
Per l’Italia l’approfondita ricostruzione effettuata da alcuni esperti (D’Elia e Gabriele, 2018) indica una tendenza ascendente dal 2000 al 2016 per la quota lavoro dipendente e una discendente per quello autonomo, entrambe in rapporto al valore aggiunto nazionale (al costo dei fattori). Considerando l’insieme delle due, si ricava una tendenza complessivamente discendente, che tuttavia contrasta con quella derivata dalla tradizionale stima che genericamente equipara le remunerazioni dei dipendenti a quelle degli autonomi. Un’altra ricostruzione effettuata dall’Università di Groningen e da quella della California a Davis insieme alla Federal Reserve americana, fornisce un quadro differente, con una caduta notevole della quota “lavoro” nel Pil a prezzi correnti dai primi anni 80 fino al 2000, per lasciare il posto negli anni duemila a una tendenza alla ripresa fino al 2018. In particolare, l’incidenza sul Pil sale dal minimo storico del 49,99% nel 2001 al 52,24% all’inizio del 2019, con un andamento tutt’altro che lineare, ovvero in ripresa fino al 2010 per arretrare negli anni successivi e una ripresa verso la fine del secondo decennio.
Non si osserva, quindi, una stabilità delle tendenze di medio periodo secondo le varie ricostruzioni, né un’evoluzione in parallelo tra i vari settori produttivi, né un movimento verso la equipartizione del valore aggiunto tra le due componenti. La partizione riflette in generale la dinamica media delle retribuzioni, ma dovrebbe riflettere, in particolare, gli incrementi di produttività, che sono il frutto di diversi fattori tra cui l’adozione di tecnologie avanzate di digitalizzazione nei processi produttivi. Queste permettono di accrescere la performance del lavoro sia quantitativamente che qualitativamente, riducendo il fabbisogno di lavoratori a parità di prodotto. Nell’ultimo decennio, dal 2014 al 2022 la produttività del lavoro, misurata dall’Istat, è aumentata dello 0,8% in media annua e una parte preponderante, lo 0,7%, è dovuta al miglioramento della combinazione dei fattori produttivi nelle imprese reso possibile anche dalla digitalizzazione.
Il lavoro dipendente non sembra aver beneficiato grandemente di questo progresso. Nella distribuzione del valore aggiunto prodotto, la sua quota ha subito una limitata erosione a seguito di variazioni di segno opposto lungo gli anni dal 2014 al 2023. Per l’insieme dei settori produttivi, la quota lavoro dipendente si amplia lentamente dal 39,2% al 41,8% del Pil (a prezzi di mercato) nel 2019, per scendere altrettanto lentamente fino al 39,5% nel 2023. La tendenza al ribasso è, invece, più stabile nel settore manifatturiero, in cui la quota si restringe di circa 6 punti percentuali, passando dal 58% del valore aggiunto (a prezzi correnti) al 52% nel 2023, con una sola inversione di andamento nel biennio 2019-2020.
A quali fattori imputare questa erosione? Le analisi e le verifiche econometriche offrono diverse spiegazioni, non sempre convergenti nei risultati. I tre principali fattori chiamati in causa consistono nel progresso tecnologico, l’internazionalizzazione dei processi produttivi e le istituzioni che governano il funzionamento del mercato del lavoro, incluso il ruolo dei sindacati. I tre fattori interagiscono in misura diversa a seconda delle imprese e dei settori, determinando una notevole eterogeneità della quota lavoro tra le imprese. Uno studio del 2021, condotto da Bloise, Brunetti e Cirillo sulla base dei dati delle grandi e delle medie imprese, attribuisce il maggior ruolo al ricorso all’outsourcing, ovvero lo spostamento di fasi della produzione in Paesi esteri che presentano condizioni più convenienti sotto diversi profili, specialmente i costi. La sindacalizzazione della forza lavoro contribuisce ad accrescere la quota “lavoro” in quelle imprese in cui è già più consistente, mentre le innovazioni di prodotto appaiono correlate alla diminuzione della quota in quelle in cui è più elevata la produttività e minore la parte destinata ai lavoratori. L’innovazione mediante processi ad intenso impiego di lavoro naturalmente è correlata positivamente con l’aumento della quota anche in imprese produttive. In breve, quanta più produzione le imprese ottengono per unità di lavoro e quanto più elevate sono le retribuzioni, tanto più bassa è la quota di valore aggiunto che va al lavoro. Si determina, quindi, un disaccoppiamento tra retribuzioni e produttività.
Da ultimo, un’analisi dell’Ocse appena completata getta nuova luce sul nesso tra produttività e remunerazione della forza lavoro. L’analisi si concentra sull’industria manifatturiera e sui servizi non finanziari né immobiliari, coprendo un lungo arco di tempo che va dal 1990 al 2019. Esclude dalla costruzione dei dati le imprese senza dipendenti, evitando in tal modo un fattore d’incertezza nella misurazione della quota, ma fa anche un raffronto con i dati ottenuti con il metodo tradizionale di imputazione. L’indagine è svolta per comparto all’interno dei settori e copre 26 Paesi dell’Ocse, mirando a comprendere tutte le componenti dei compensi ai lavoratori e non semplicemente la parte dei salari o stipendi contrattuali. Le imprese di ciascun comparto sono raggruppate ed ordinate in percentili secondo il livello di produttività, che è misurata con riferimento sia al fattore lavoro, sia alla combinazione dei fattori (multifattoriale).
Ne emerge una notevole difformità di andamento tra settori e tra Paesi. La quota di valore aggiunto che è andata al lavoro si ridimensiona verso il basso nell’industria manifatturiera, mentre aumenta nei servizi non finanziari. Divergenze anche tra Paesi: negli Usa la quota lavoro ha subito la maggiore caduta tra il 2000 e il 2010 (-7 punti percentuali) per stabilizzarsi attorno al 57% negli anni seguenti, mentre in Germania il declino di circa 3 punti è stato rapidamente recuperato e nel 2020 la quota si collocava sopra il livello del 1990, superando il 62%. In contrasto, in Francia, UK e Italia la quota sale dal 2000 verso i massimi del periodo con una dinamica difforme tra settori: in quello dei servizi l’ascesa è nettamente superiore al manifatturiero. In Italia, in specie, nel settore servizi (non-finanziari) la distribuzione di valore aggiunto al fattore lavoro eccede di circa due volte quella nell’industria. Si potrebbe sostenere che nei servizi una porzione maggiore di valore è assorbita dai compensi per il lavoro rispetto a quanto avviene nel settore industriale.
Quali cambiamenti hanno determinato questa diversità di ripartizione? L’analisi dell’Ocse mostra che è dovuta principalmente alla riallocazione di valore aggiunto tra imprese nell’ambito dello stesso comparto produttivo, con una crescente divaricazione tra le imprese ad alta produttività e con minore quota al lavoro e quelle a bassa produttività e maggiore quota. In altri termini, l’attività economica si è spostata verso le imprese più produttive. L’Italia non fa eccezione a questo andamento e mostra persino uno spostamento intra-comparto più intenso che in altri Paesi.
In generale, gli incrementi di produttività realizzati da alcune imprese nell’ultimo ventennio appaiono aver avuto un effetto depressivo sulla quota andata al lavoro in conseguenza del ridursi dell’intensità di ricorso al lavoro e quindi del montante retribuzioni da corrispondere. Questo sarebbe il risultato di diversi fattori, quali gli investimenti ad alta intensità di capitale, il rafforzarsi della posizione negoziale nei confronti del lavoro, e altro. Sembra, quindi, che lo spostamento della produzione all’interno dello stesso comparto produttivo verso le imprese stabilmente più produttive e con una componente di lavoratori minore abbia avuto un peso determinante sul livello e sulla dinamica della quota “lavoro”. Queste imprese si distinguono da quelle che compiono solo un salto temporaneo di produttività e che successivamente tornano a condividere con i lavoratori una comparativamente maggiore quota dei loro guadagni.
A quali cause far risalire il ridimensionamento del nesso positivo tra produttività e retribuzioni? Si richiamano, in particolare, la globalizzazione della produzione, i vantaggi competitivi derivanti dallo sviluppo di tecnologie di punta non accessibili ad altre imprese in campi quali Big Data e Intelligenza Artificiale, il declino della nascita di nuovi concorrenti, l’attenuazione della concorrenza sui mercati, il ruolo dei beni intangibili frutto della ricerca e innovazione e le barriere tecnologiche all’entrata nel mercato di Pmi innovatrici. Ma mancano chiare evidenze sul loro ruolo.
Quanto all’opportunità e ai modi in cui le politiche dei governi e l’atteggiamento delle parti sociali potrebbero contrastare queste dinamiche, il dibattito è aperto, le soluzioni non semplici, i loro effetti sullo sviluppo economico incerti e le controindicazioni non poche. Le economie dei Paesi Ocse stanno attraversando grandi sconvolgimenti e nessuno possiede attualmente una chiara visione delle azioni da intraprendere.