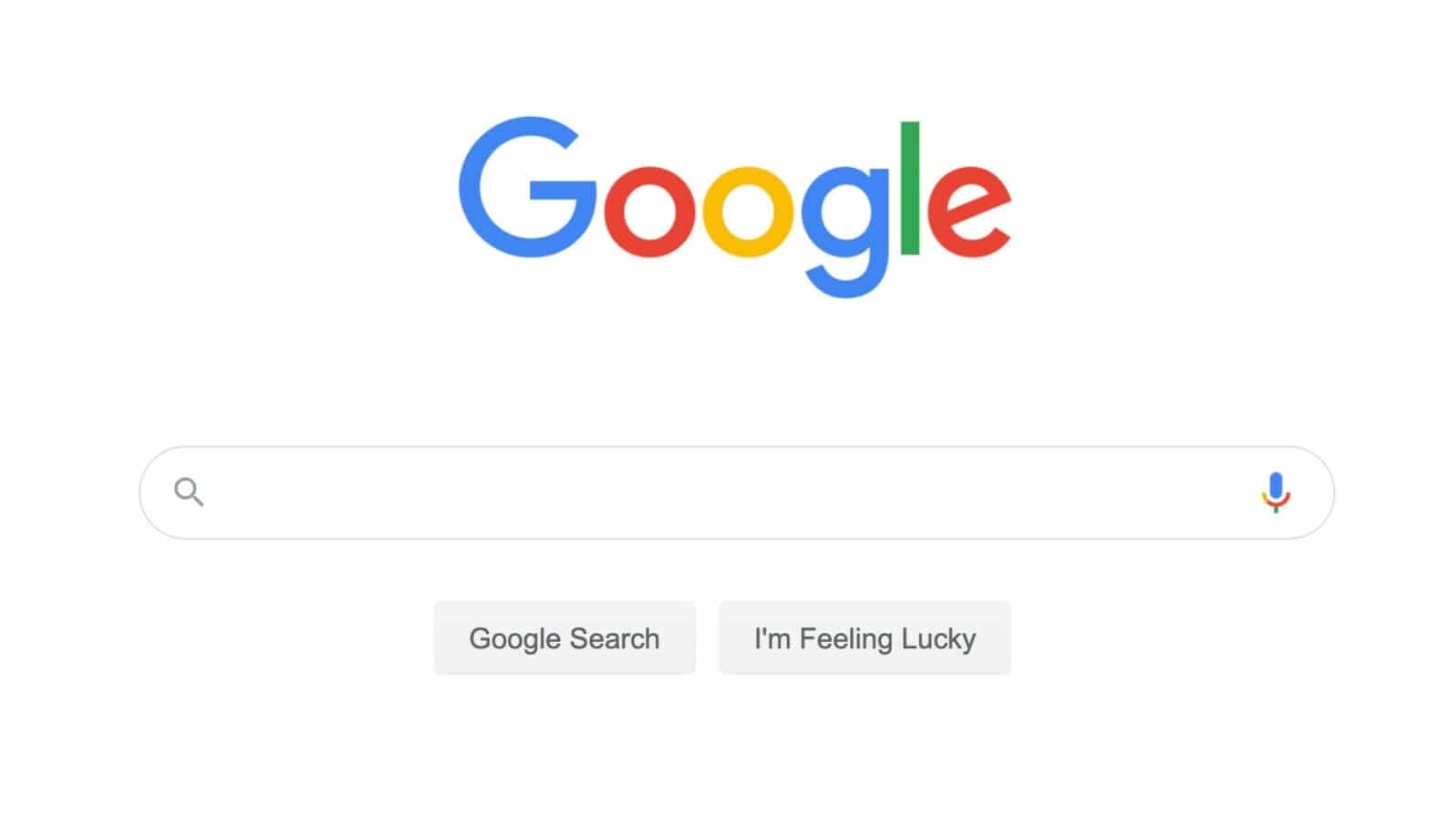L’eventuale breakup di Google sarebbe un intervento a gamba tesa che stravolgerebbe il modello di business di una delle aziende che hanno più innovato negli ultimi trenta anni a livello mondiale. Sarebbe peraltro paradossale che si arrivi a tanto senza che sia stato in alcun modo dimostrato dallo stesso giudice un danno per i consumatori. L’analisi di Stefano da Empoli, presidente Istituto per la Competitività (I-Com)
La decisione dello scorso 5 agosto del giudice statunitense Amit Mehta, che ha riconosciuto Google colpevole di aver mantenuto illegalmente un monopolio sulle ricerche online, in virtù di una quota di mercato di oltre il 90%, è stata da molti definita storica.
Vista anche l’assenza di una regolamentazione all’europea che da questa parte dell’Atlantico negli ultimi anni ha imposto innumerevoli lacci e lacciuoli alle Big tech e a quasi venticinque anni di distanza da un’altra sentenza antitrust di primo grado che sull’altra sponda dell’oceano propose lo spezzatino di Microsoft, rigettato poi in appello in cambio di rimedi decisamente meno strutturali, ancorché significativi.
E in effetti il caso in questione è stato paragonato spesso a quello che oppose a cavallo tra vecchio e nuovo secolo l’azienda fondata da Bill Gates al Dipartimento della Giustizia americano, centrato sulle presunte pratiche abusive della prima, che, grazie al monopolio detenuto nei sistemi operativi con Windows, esigeva che i produttori di pc pre-installassero il browser di Microsoft anziché quello di Netscape, il browser inizialmente più popolare.
Anche se proprio il confronto tra i due casi fa emergere almeno tre elementi che li differenziano significativamente, gettando più di qualche dubbio sui possibili torti di Google.
In primo luogo, i contorni del mercato del search appaiono oggi decisamente più sfumati rispetto a quelli dei sistemi operativi per pc di allora. Il giudice Mehta ha deciso per una definizione del mercato rilevante convenzionale e dunque ristretta, di fatto comprendente i motori di ricerca classici (come per l’appunto Google e Bing), anche se oggi le query online avvengono sempre di più in modalità alternativa, su siti di e-commerce, social media, assistenti vocali per non parlare dei tool di intelligenza artificiale generativa.
E comunque, anche rimanendo ai servizi di ricerca in senso stretto, nuovi player come Perplexity AI e la stessa SearchGPT, tool annunciato nelle scorse settimane da OpenAI, promettono di rendere il mercato più dinamico. Naturalmente, questi ultimi sviluppi non aiuterebbero Google a schivare eventuali sanzioni su potenziali abusi compiuti in passato ma potrebbero indorare la pillola degli eventuali rimedi pro futuro (sui quali torneremo più avanti).
Ma il caso Google si distanzia da quello Microsoft per altri due aspetti estremamente rilevanti: secondo la stragrande maggioranza degli esperti, Internet Explorer non era un prodotto migliore di Netscape, anzi ai più appariva il contrario, mentre il giudice Mehta riconosce che il search di Google sia in effetti il migliore in campo, almeno fino ad oggi. Solo che, secondo il lunghissimo dispositivo della sentenza, esso è al primo posto per qualità, non solo perché l’impresa di Mountain View ha investito miliardi di dollari e ha assunto migliaia di ingegneri per migliorarlo continuamente ma anche perché, grazie ai suoi comportamenti giudicati illegali, Google ha potuto raggiungere un numero di clienti superiori a quelli che avrebbe potuto conseguire attraverso normali dinamiche di mercato e dunque disporre di una maggiore quantità di dati che lo ha potuto migliorare meglio di quanto fosse nelle possibilità degli altri motori di ricerca.
Ma quali sono queste pratiche giudicate lesive della concorrenza? Diversamente da quanto fece al tempo Microsoft, le azioni intraprese da Google non sono consistite in minacce o ricatti delle aziende che installavano i propri prodotti affinché non rendessero disponibili motori di ricerca alternativi bensì in meccanismi di revenue sharing per chi decidesse di proporre ai propri clienti il search Google come scelta di default. Non si tratta di una differenza da poco. Per almeno due motivi.
Innanzitutto, aspetto fondamentale, con le sue pratiche Google beneficia altri player dell’ecosistema digitale, come produttori di device, società telefoniche o browser (peraltro concorrenti di Google Chrome), con i quali divide una parte della torta dei profitti estratti dalla pubblicità. A parte Apple, che ha incassato ben venti miliardi di dollari nel 2022, pari a circa il 15% del suo risultato operativo annuale, nell’elenco troviamo diversi altri attori come ad esempio Mozilla, per il quale l’accordo con Google ha fruttato negli ultimi anni secondo alcune stime circa il 50% dei ricavi annuali.
Inoltre, mentre di fatto al tempo del caso Microsoft installare un browser alternativo era piuttosto complicato o quantomeno determinava una bella scocciatura, oggi qualunque consumatore con pochi click può scaricare e usare un altro motore di ricerca, qualora lo preferisca a quello di Google. A quest’ultima obiezione, la decisione del tribunale statunitense ha risposto, sulla base di tesi tipiche dell’economia comportamentale, che in realtà i consumatori sono più pigri e disinformati rispetto alla classica rappresentazione dell’agente razionale. In effetti è difficile capire il motivo per il quale nel 2021 Google abbia dovuto elargire complessivamente ben 26 miliardi di dollari per piazzare il proprio motore come scelta di default se poi quest’ultima non avesse avuto un valore commerciale più che rilevante. Si possono senz’altro avanzare ipotesi alternative ma in effetti è probabilmente questo il punto di resistenza più fragile fin qui opposto dal colosso di Mountain View. Accusato inoltre dal giudice Mehta di sfruttare il monopolio di cui godrebbe nel search per aumentare i prezzi della pubblicità ad esso legata.
Ma sul fronte pubblicitario la partita più importante si giocherà dopo l’estate con l’apertura di un secondo processo a carico di Google proprio sull’infrastruttura tecnologica utilizzata per l’advertising, anche in questo caso per un presunto abuso della propria posizione dominante e dei conflitti di interesse che la caratterizzerebbero.
Le previsioni della vigilia davano Google più in difficoltà in questo secondo procedimento che nel primo, anche se il processo è ancora interamente da svolgere e dunque il risultato finale è tutto da vedere. Così come, d’altronde, è troppo presto per accertare la sconfitta di Google dopo questa prima sentenza. Per due ragioni. La prima è che ovviamente potrà esserci un appello e Google ha già fatto sapere che intende fare ricorso contro la decisione di lunedì scorso. La seconda è che, anche qualora fosse confermata la sconfitta, le conseguenze reali per l’azienda californiana dipenderebbero dai rimedi imposti dal giudice, rispetto ai quali potrebbe peraltro essere raggiunta una mediazione in corso d’opera.
Si va da rimedi comportamentali come la previsione di una scelta reale per i consumatori tra i diversi motori di ricerca, ai quali non sarebbe imposta alcuna soluzione di default (come del resto accade già nell’Unione europea, senza che al momento la posizione di Google si sia indebolita), oppure più semplicemente alla proibizione di accordi, almeno nelle forme attualmente consentite, ad altri strutturali ben più impattanti come la condivisione dei dati con i competitor per neutralizzare gli effetti di rete derivanti da un numero superiore di utenti o addirittura la separazione del search da altre attività di Google.
Queste due ultime opzioni hanno però evidenti controindicazioni. L’obbligo di condividere i dati presenta rischi elevati per la privacy degli utenti, oltre a dare di fatto un diritto di free riding ai diversi player, a prescindere dai loro effettivi meriti (e tenendo conto, peraltro, di contorni sempre meno definiti del mercato sottostante).
L’eventuale breakup di Google sarebbe un intervento a gamba tesa che stravolgerebbe il modello di business di una delle aziende che hanno più innovato negli ultimi trenta anni a livello mondiale, come testimoniano le decine di miliardi di dollari spese annualmente in ricerca e sviluppo e le centinaia di nuovi prodotti o funzionalità creati ogni anno. Sarebbe peraltro paradossale che si arrivi a tanto senza che sia stato in alcun modo dimostrato dallo stesso giudice un danno per i consumatori, come faceva notare un editoriale del Wall Street Journal, certo non un organo di stampa amico di Google, per usare un eufemismo. Il titolo era non a caso “Google is a Very Strange Monopolist”. Tanto strano da offrire una vastissima pluralità di prodotti innovativi e a costo zero per diversi miliardi di utenti a livello mondiale. Non certo il tipico comportamento di un monopolista. In attesa forse di dover riscrivere i manuali di microeconomia ed economia industriale, ennesima prova, stavolta involontaria, di innovazione indotta dal gigante di Mountain View.