Sussidi e bonus sono un ottimo specchietto per le allodole, perché l’unico modo sensato di fare debito buono è legarlo a un investimento. La presentazione del saggio di Veronica De Romanis alla Luiss con Paola Severino, Pietro Reichlin, Paolo Boccardelli e Francesco Giorgino
Un buon pasto non è mai gratis. O quasi. Qualcuno, a monte o a valle della tavola, paga sempre. L’Italia del dopo-Covid, ma anche prima, ha conosciuto una lunga stagione di bonus, sussidi, sgravi, aiuti di ogni sorta. Soldi pubblici infilati nelle tasche dei cittadini, nelle casse delle imprese, oltre che nelle buste paga della Pubblica amministrazione. Tutto è cominciato con i famosi 80 euro del governo Renzi, poi è stata una discesa in un maelstrom, fino al mostro del Superbonus che ha distrutto i conti pubblici, passando per la parentesi, nemmeno troppo breve, del reddito di cittadinanza.
Domanda: tutto questo è servito? E, se sì, in che misura ha impattato sul Pil? E non è che era alla fine elargire aiuti, lavorare di sgravi, distribuire mance, riscrivere parte della riscossione fiscale, ha fatto il bene dell’economia e il male delle finanze pubbliche, stressate da un debito di ormai 3 mila miliardi? Domande più che lecite se si pensa che tali interventi sono stati finanziati a deficit, nell’illusione che il debito pubblico non fosse anche il debito degli italiani.
L’economista Veronica De Romanis ha dedicato al tema quasi 170 pagine, che danno vita al saggio Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti), edito da Mondadori e presentato presso la Sala delle Colonne della Luiss insieme a Paolo Boccardelli, Rettore Luiss Guido Carli, Paola Severino presidente Luiss School of Law, Pietro Reichlin professore di Economia, Luiss Guido Carli. Tutti moderati da Francesco Giorgino direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale, Luiss School of Government.
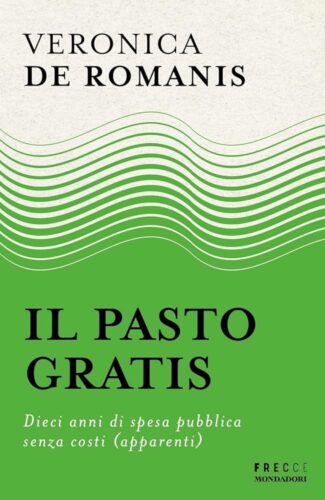
“Le misure come i bonus, i sussidi, sono solo apparentemente a favore dei cittadini. I quali poi magano le medesime misure, attraverso, per esempio, le tasse. E chi non può pagare le tasse si indebita. Se poi non si vogliono aumentare le tasse, ecco che aumenta il debito pubblico. Insomma, da qualunque parte la si voglia vedere, alla fine tutto si paga”, ha chiarito in apertura di dibattito Severino. “Chi paga? I giovani, soprattutto. Allora è lecito chiedersi se possiamo associare questo debito a un investimento. Se io contraggo un mutuo, compro casa dunque è un investimento. Ma se invece la redditività viene meno, allora non sto parlando di investimento. La favola del debito che non costa infastidisce, sarebbe molto meglio dare ai cittadini la sensazione di un ritorno della spesa pubblica, allora forse sarebbe tutto più facile e sensato”.
Boccardelli ha poi affrontato il tema della spesa pubblica di qualità. “Il tema centrale all’interno dell’azione del governo è realizzare servizi e beni pubblici. Dare aggettivi alla spesa pubblica è facile, ma non è facile calcolarne gli effetti. Noi possiamo anche investire miliardi nelle infrastrutture digitali, ma se non ci sono i servizi allacciati a queste, allora si più un danno che altro. Il punto qui è capire la necessità di una buona spesa pubblica, che vada anche oltre il Pil. Pensiamo agli indicatori del benessere, dell’accesso alle strutture, alla sanità. Il Pil non è l’unico punto di arrivo degli investimenti. Questo per dire che valutare la spesa oggi è un tema tutt’altro che banale. Per esempio, il Superbonus ha sì impattato sui conti, ma ha d’altro canto aumentato la patrimonializzazione delle imprese edili. Cambiando dunque il metro di misura, anche la valutazione della spesa cambia”. Poi una precisazione. “Spesso sentiamo parlare di debito buono o cattivo. La verità è che quello che conta è crescere, l’importante è che il debito nuovo spinga al miglioramento e non serva a ripagare il debito vecchio”.
Diverso il punto di vista di Reichlin. “La storia della spesa pubblica di questi anni insegna che c’è stato bisogno da parte dei governi di dimostrare di saper fare qualcosa, dagli 80 euro al reddito di cittadinanza, fino al bonus cultura. Ma quasi nessuna di queste misure ha avuto solide coperture. Però non voglio dire con questo che il debito è sempre cattivo. Il debito serve in un ciclo economico, certamente deve servire alla crescita. Non possiamo dimenticare che dal 2011 ad oggi abbiamo avuto due crisi importanti, la crisi finanziaria e la pandemia. Dunque, domandiamoci se in quei frangenti sono state fatte le politiche giuste. Se penso al 110%, allora dico che è tutto sbagliato a cominciare dalla sua architettura. Non c’è dubbio che oggi il governo Meloni si trovi sulle spalle un gigantesco fardello”.
Le conclusioni sono state affidate alla stessa autrice del volume. “Se uno cominciasse a leggersi le manovre, capirebbe che ci sono centinaia di provvedimenti che rimandano ad altri provvedimenti. Una giungla, un vero problema di informazione: oggi i cittadini non capiscono quanto gli costa una misura. Abbiamo assistito alla balla dei famosi tesoretti in questi anni. Bene, il tesoretto altro non è che debito pubblico e il debito pubblico si paga. Questo è il grande inganno”.
“Il messaggio sotteso, quello che il volume vuole denunciare, è la mancanza di trasparenza perpetrata in questi anni. Una misura presentata come priva di costi, ma che in realtà ne ha, questa pratica l’abbiamo vista quasi sempre, soprattutto negli ultimi anni, ignorando le regole più elementari, ovvero spiegare chi ne beneficiava e quanto costasse allo Stato, cioè ai contribuenti. Se si lanciano dei soldi dall’elicottero, l’economia reale ne potrà anche beneficiare, ma alla fine il costo è quasi sempre maggiore del beneficio. Lo abbiamo visto con il Superbonus, una misura assolutamente regressiva, con un Pil che è salito solo momentaneamente a fronte di un impatto molto più grande e permanente sui conti, a cominciare dal deficit”.








