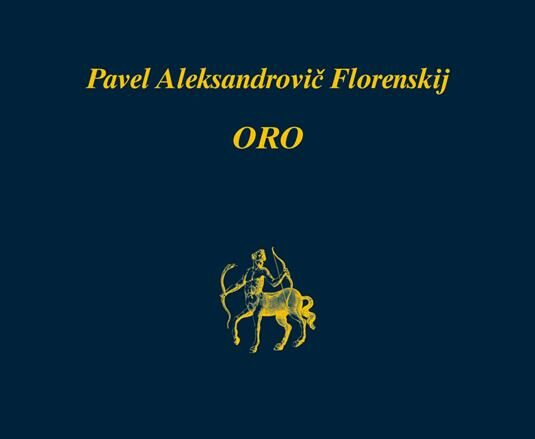Grazie a Nino Aragno editore esce il toccante poema “Oro” (1937, con la traduzione di Lucio Coco) di Pavel Aleksandrovič Florenskij, sacerdote ortodosso, matematico, filosofo, poeta, fucilato l’8 dicembre del 1937, in quanto ritenuto un intellettuale pericoloso. Una poesia filosofico-scientifica agganciata alla natura, tra Sergej Paradžanov, Camillo Sbarbaro e Vincenzo Cardarelli, costantemente attenta all’innovazione linguistica
«Nelle prigioni e nei lager quasi tutti danno un’enorme importanza ai sogni, li spiegano e ne discutono, vi sono perfino specialisti, interpreti di sogni. Io finora non sono stato contagiato da questa epidemia, ma i miei sono sogni talmente vivi, che non posso fare a meno di ricordarmene. Spesso in sogno vedo voi, i miei fratelli e sorelle, ma da piccoli, e le loro immagini si confondono con quelle dei nostri figli, anch’essi piccoli».
«La mia conclusione (del resto, sono giunto ad essa già da tempo) è questa: nell’uomo c’è una carica di furore, d’ira, di istinti distruttivi, di odio e di rabbia, e questa carica tende a riversarsi sulle persone circostanti, contrariamente non solo ai dettami morali, ma anche a vantaggio personale dell’individuo. L’uomo si lascia prendere dal furore per pura brutalità».
Questi sono due brani da Non dimenticatemi, lettere dal gulag di Pavel A. Florenskij (Oscar Mondadori, 2006, a cura di Natalino Valentini e Lubomír Žák, dalle pp. 356 e 366) che si possono completare, per la lingua italiana, in un ideale dittico con il toccante e profondo poema (sempre di Pavel Aleksandrovič Florenskij), Oro, finemente tradotto dal russo, annotato e prefato da Lucio Coco, per i tipi di Aragno (2025). Opera scritta durante l’assurda prigionia in un gulag nelle isole Solovki, dal 1934 al 1937, anno della fucilazione dell’autore, in quanto ritenuto pericoloso sovversivo ideologico.
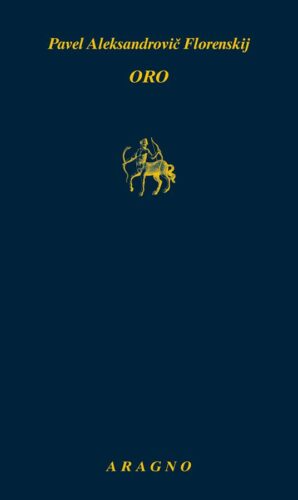 Pavel Aleksandrovič Florenskij, presbitero russo, con alle spalle studi scientifici e teologici, è stato anche matematico, filosofo, iconologo e studioso di scienze naturali. La sua densa opera è stata anticipata, per la prima volta in Occidente, cinquant’anni fa, da La colonna e il fondamento della Verità (Rusconi editore, 1974, traduzione di Elémire Zolla e Pietro Modesto). Durante gli anni Cinquanta il regime sovietico comunica alla famiglia che il filosofo è deceduto il 15 dicembre 1943, collocando la morte nella nebbia del tempo di guerra, come ad allontanare ogni responsabilità governativa. Ma dopo la caduta dell’Unione Sovietica, aperti alcuni fascicoli del Kgb, emerge la pratica che parla della vera fine del filosofo e scienziato: fucilato nei pressi di Leningrado l’8 dicembre 1937.
Pavel Aleksandrovič Florenskij, presbitero russo, con alle spalle studi scientifici e teologici, è stato anche matematico, filosofo, iconologo e studioso di scienze naturali. La sua densa opera è stata anticipata, per la prima volta in Occidente, cinquant’anni fa, da La colonna e il fondamento della Verità (Rusconi editore, 1974, traduzione di Elémire Zolla e Pietro Modesto). Durante gli anni Cinquanta il regime sovietico comunica alla famiglia che il filosofo è deceduto il 15 dicembre 1943, collocando la morte nella nebbia del tempo di guerra, come ad allontanare ogni responsabilità governativa. Ma dopo la caduta dell’Unione Sovietica, aperti alcuni fascicoli del Kgb, emerge la pratica che parla della vera fine del filosofo e scienziato: fucilato nei pressi di Leningrado l’8 dicembre 1937.
Con la pubblicazione di Oro, il lettore aggiunge un tassello, un quadro, una icona, se vogliamo, in più, per capire la weltanschauung di Florenskij attraverso lo strumento, questa volta (dopo gli studi iconologici e prettamente filosofici), della poesia, qui declinata nella forma del poemetto. Un’opera nata «per far fronte alla mancanza di libri che il regime sovietico aveva sequestrato alla famiglia [nella casa di Mosca] ma è anche, come si è detto, un testo in cui è forte il connotato pedagogico» (Lucio Coco).
Un testo che, sul piano della metrica, segue «[…]il tetrametro giambico in quanto è il metro più dinamico e rapido. Per evitare il femmineo, il sognante, l’indeterminato, l’autore si è vietato le rime femminili [«femminili sono quelle parole che presentano una sillaba dopo quella tonica» L. Coco]. Così sono state inserite maggiori difficoltà nella scrittura […]. Il poema è stato scritto per mio figlio Mik e si adatta alla sua comprensione, anche se, forse, adesso egli non può capire tutte le numerose allusioni di questi versi. […] esso sarà per lui in seguito un ricordo del padre» (dalla Premessa scritta in terza persona dall’autore stesso).
 Florenskij, dopo un anno di prigionia nelle isole Solovki, capisce che non tornerà più a Mosca, nella sua bella e luminosa casa, che aveva preso arrivando con la sua famiglia da Tbilisi, anni prima, ora svuotata senza misericordia, dei molti e diversi libri, dalla polizia segreta; un caldo e accogliente appartamento che i suoi famigliari dovranno lasciare. Tristi notizie che gli arrivano tramite la rara e controllata posta dei suoi cari. Dunque, Oro sarà il testamento per il figlio più piccolo, Michail (1921-1961), in famiglia Mik.
Florenskij, dopo un anno di prigionia nelle isole Solovki, capisce che non tornerà più a Mosca, nella sua bella e luminosa casa, che aveva preso arrivando con la sua famiglia da Tbilisi, anni prima, ora svuotata senza misericordia, dei molti e diversi libri, dalla polizia segreta; un caldo e accogliente appartamento che i suoi famigliari dovranno lasciare. Tristi notizie che gli arrivano tramite la rara e controllata posta dei suoi cari. Dunque, Oro sarà il testamento per il figlio più piccolo, Michail (1921-1961), in famiglia Mik.
Il tema del poema prende spunto dalla popolazione degli Oroceni, piccolo gruppo etnico di origine mongola, nel nord della Siberia, di cui Florenskij viene a conoscenza, incontrando due uomini, quando durante la sua detenzione fu inviato per alcuni mesi (febbraio-settembre 1934) presso la stazione scientifica Bam per studiare la struttura del ghiaccio perenne.
Il racconto, un sogno carico di speranza, immagina l’incontro di un confinato georgiano che gira per la taiga studiando i ghiacci (rappresenta l’autore medesimo), diretto poi verso una stazione di osservazione nell’estremo nord della Siberia (egli viene dalla Georgia, come appunto Florenskij), con una coppia di umili, anziani oroceni. Questi hanno un unico figlio, preadolescente, giunto in tarda età, preconizzato da uno sciamano (allusioni alla Bibbia), ora preadolescente (rappresenta suo figlio Mik), di nome “Oro” (lemma che significa “renna”: animale sacro per gli oroceni).
Lo scienziato-viaggiatore notata la straordinaria intelligenza e la fine acutezza d’osservazione di Oro (non sfugge al lettore attento l’analogia con il preadolescente Gesù che argomenta con i dotti al Tempio) nei riguardi dei fenomeni della natura, chiede al padre se lo può prendere con sé come allievo e portarlo alla stazione di osservazione, al nord. Il padre non lo lascia andare, i genitori non vogliono separarsi da Oro (Gesù torna a Nazareth con la famiglia). Il forestiero parte.
Ma poco tempo dopo Oro scopre un raro giacimento di un nuovo minerale, al che il padre decide di portarlo nella stazione di osservazione. Oro si fa apprezzare nei suoi studi, scopre addirittura resti di un mammut, e il padre decide che può lasciarlo lì. Così il ragazzo intraprende una brillante carriera di studi e scoperte, prevedendo (dono profetico) anche il contrasto tra la direzione dell’osservatorio e il suo amico georgiano: non lo rivedrà più. Lo hanno fatto sparire.
Il poema termina con Oro, ormai divenuto noto scienziato, che riesce anche a dedicarsi all’istruzione dei poveri oroceni della taiga, nei quali crede risieda una disposizione particolare per lo studio della scienza.
L’opera alterna riflessioni teologiche sul senso della vita, passaggi narrativi, a osservazioni liriche della natura. Nel dono-dedica per Mik (oltre la dedica esplicita posta in epigrafe), all’interno dei primi versi, l’autore-padre, appena giunto nell’internamento alle isole Solovki, cerca un regalo da inviare al piccolo ma trova solo doni spirituali: «Purtroppo in un anno terrificante di/fame/Quale regalo si potrà trovare? Ho cerato intorno cosa dare a Mik /E ho trovato il dono: la grazia. Io vorrei che la quiete d Dio/Ti proteggesse, piccolo mio/».
Nell’incontro tra l’ospite e il vecchio affiora nitidamente, non va sottovalutato, un sotto-tema sempre attuale, soprattutto oggi, quello dell’accogliere il volto dell’altro direbbe Emmanuel Lévinas, ossia l’offrire con gioia l’ospitalità allo straniero: «Vecchio: […] “Non conosco le vostre città, /Né i vostri costumi e le vostre passioni. / Resta con noi. Non abbiamo/Mai Ospiti. Dal cielo ci è stato dato/Uno straniero da paesi lontani e diversi/ Vedi come nostro figlio è contento/ Come gli brillano gli occhi!/[…] Una volta lo sciamano ha predetto: /“Coglierà il segreto dei ghiaccia perenni”».
Nel ricordare la sua terra di origine (la Georgia), la sua amata Batumi, Florenskij incolla, in rapida successione, immagini da documentarista, che paiono anticipare l’Armenia inquadrata trenta anni dopo da Sergej Paradžanov: «[…] Al bosso color avorio lì/La terra costiera dà vita. /Sul mare, il cormorano, dal petto/d’argento/. Fende la nebbia del mattino./E l’ultimo raggio brucia i margini/Dei cumoli di nuvole al tramonto/Con una luce smeraldina. Dei miei eterni/Pensieri oggetto è la natia Batum./Lì il mare mugghia e nelle onde,/Come loro contrappunto si sente Bach,/Quando la sardonica e l’agata/Risuonano attratte dalle onde».
Ancora, l’osservare minuzioso della natura, il soffermarsi sul cambio della luce, sulla variegata flora, accarezzare con lo sguardo gli insetti, ci fanno pensare anche alla poesia italiana del Novecento: da Giovanni Pascoli (e Coco lo omaggia in traduzione con lemmi tipicamente pascoliani: vedi le occorrenze di «tinnulo») passando per Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale e Vincenzo Cardarelli, sino a Diego Valeri: «La calura dell’assolato luglio/Risuona delle cicale. La vista famigliare dell’altopiano roccioso/È irrorata da un magma d’oro. /Una calda cascata di pietre, /Al di sotto degli zoccoli di gregge di capre/Precipita per un colaticcio di lava/[…] Dai campi arrivava profumo di meloni /E con essi l’argentea artemisia/E la Santoreggia e la rosa di Gerico/».
Perché al centro di Oro c’è il tema della crescita e della curiosità verso il mondo della natura di un preadolescente? Certo, perché papà Pavel, che amava tutta la sua famiglia, aveva a cuore soprattutto, Mik, il più piccolo, il più indifeso, colui che più soffriva la mancanza del padre. Ma anche perché in Mik si incarna il destino dell’uomo nuovo, la vita che si rinnova, e, storicamente, la speranza di una nuova generazione che avrebbe potuto sperare in un mondo più giusto, diverso, in grado di sostituire quel mondo dilaniato da «istinti distruttivi, di odio e di rabbia», come ormai il filosofo e poeta, disilluso, vedeva la vita avvelenata dal gulag. Il ragazzo Oro è il lumicino di speranza della adolescenza, poiché «[…] le impressioni della infanzia e della giovinezza costituiscono l’embrione forte e consistente di tutto ciò che verrà in seguito e bisogna averne una cura del tutto particolare (Non dimenticatemi, op. cit., p. 380, trad. di Giovanni Guaita e Leonid Charitonov). Ecco la forza pedagogica di cui parla Coco.
La “storia” raccontata da Florenskij, tra poemetto e ballata, tra poesia e salmo laico, grazie alle note dello stesso Florenskij (sui luoghi e sulle etnie e a quelle necessarie del curatore) consente al lettore un reale viaggio documentario dalla innegabile sotterranea forza antropologica. Dal piano oggettivo, referenziale (la taiga, le stagioni, gli oroceni, i miti) tutto improvvisamente si trasfigura nella riflessione sul ruolo esistenziale del nostro essere gettati nel mondo, sulla ricerca scientifica, sul valore della libertà, sugli affetti sempre vulnerabili. Oro è una perfetta sceneggiatura tra filosofia e poesia, tra dato oggettivo-galileiano e pensiero-sistema, che avremmo visto realizzato in film dalle visionarie iconiche inquadrature di un Sergej Paradžanov.