Con “Le città del mondo” (Gramma-Feltrinelli) Eraldo Affinati gira un “documentario di carta” dimostrando come la letteratura può essere “l’arte più completa” (Manoel de Oliveira). La recensione di Eusebio Ciccotti
Vladimir Majakovskij, nel 1914, aveva ben chiaro la novità estetica del cinema prima ancora della teorizzazione del montaggio come «specifico filmico» ad opera del connazionale Sergej Mihilović Ejzenštejn, quando scriveva: «Il cinema è la logica conclusione di tutte le arti». Ossia, il poeta, drammaturgo, attore, nonché autore di scenari, spiegava la peculiarità di quella nuova arte chiamata «settima arte» (Béla Balázs) o «decima musa» (Karol Irzikowski): la fusione di tutte le arti in una unica arte. E se una nuova arte mette insieme le altre arti, va da sé che questa ultima sia più “completa” rispetto a tutte le altre (letteratura, teatro, danza, pittura, architettura, musica – quest’ultima eseguita in sala).
Ma ecco che, alcuni decenni dopo, Manoel de Oliveira, una vita passata a realizzare film, dal documentario alla finzione, in una intervista spiazza lo spettatore: «La letteratura è l’arte più completa. Anche rispetto al cinema. Ti porta dove vuole, e ti fa vedere qualunque cosa, reale o irreale che sia».
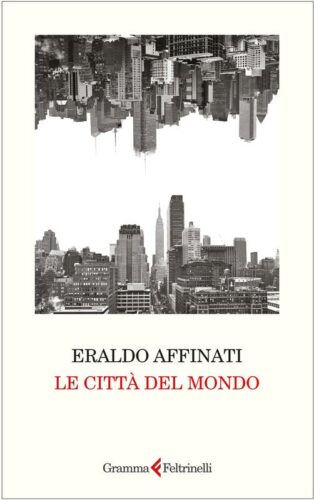
Leggendo Le città del mondo (Gramma-Feltrinelli) di Eraldo Affinati il rapporto tra letteratura/cinema mi è tornato in mente. Il “viaggio” del narratore tra «città conosciute» (visitate, osservate, assorbite), «città sognate» e «città inventate» è solo letterario o anche cinematografico?
Diversi autori, del resto, sin dalla nascita del racconto (orale o scritto), hanno descritto più o meno visivamente città vere e inventate, su questo pianeta e su altri. Risparmio titoli e autori. Città che sono, tout court, il mondo della letteratura. Potrei, però, almeno proporre due estremi (ma ogni lettore ha i suoi): da Troia a Metropolis (Thea von Harbou/Fritz Lang), oppure da Itaca alla città-stanza Luigi XVI nell’orbita Giove, di 2001. Odissea nello spazio (Arthur C. Clarke/Stanley Kubrick).
Con Affinati partiamo da New York: «Questa è la madre di tutte le città moderne, dico a me stesso, oppure la madre scapestrata di quelle antiche, in stile babilonese […]». E mi vengono in mente spezzoni superstiti di New York Street Scenes (1908), con cittadini in abiti della festa a passeggio per Manhattan; o il «Bravo Ragazzo» e «La piccola Cara», durante una passeggiata domenicale a Coney Island (Intolerance, 1916, David Wark Griffith). Ma anche la New York «babilonese» e, aggiungerei, “barocca”, ricostruita da Sergio Leone (C’era una volta in America, 1984).
Inattesa panoramica a schiaffo ed eccoci fiondati in Ucraina, grazie alla memoria di Mario Rigoni Stern. «Char’hov vi era un grande ospedale italiano dove molti nostri compagni sonno morti […]», e riattivo le scene della periferia e del porto di Mariupol (poi distrutta dalla recente aggressione russa), dalle ciminiere fumanti, zeppe di case popolari-alveari, anni Settanta, quelle dall’unico balconcino per godersi una sigaretta, in cui viveva la diciassettenne Malenkaya Vera (Piccola Vera, Vasili Pichul, 1988), insieme ai genitori operai, stressati dal duro e mal pagato lavoro da comunismo reale.
Ora sei in India, quando al tramonto, «[…] nei ghat di Benares, sulle rive del Gange, le luci del sole si mischiano ai fuochi scaturiti dai cadaveri bruciati. La vita non smette di brulicare in cima alle torri nere come tizzoni»; inquadrature letterarie chiamate a completare quelle prime panoramiche traballanti di un film Pathè (1924), sulle rive del grande fiume sacro.
E quando Affinati entra con la sua camera-stylo, “sottratta” ad Astruc, nella chiesa di San Giovanni il Guerriero, a Mosca, sentiamo il «Profumo d’incenso più dolce del nostro». Vediamo «Icone dovunque, ai lati, davanti e dietro. Il giovane diacono, alla testa dei fedeli, guidava la preghiera, il coro pronto ad accompagnarlo»: come non associare tali icone al finale di Andrej Rublëv (1966-69, Andrej Tarkovskij)?
A Marrakesh, mentre il docente Eraldo è con i suoi studenti della scuola Penny Wirton, parte una pennellata quasi felliniana sulla «[…] celebre piazza Jemaa el Fna dove dall’alba al tramonto si affollano centinaia di turisti e venditori, incantatori di serpenti e saltimbanchi, acrobati e suonatori di tamburello», non così differente, dopo settant’anni, dalla gioiosa (e rischiosa) atmosfera dell’incipit di L’uomo che sapeva troppo (1956, Alfred Hitchcock). La stessa caotica animazione, i medesimi colori, l’inalterato fascino maghrebino: eppure gli studenti marocchini. «italianizzati», appaiono delusi dall’aspetto turistico di Marrakesh e scelgono «la pizza piuttosto che il kebab».
Tra «le città sognate» emerge Bucarest, «[…] non ci sono mai andato ma quante volte l’ho sognata! […] Eravamo tutti minorenni non accompagnati, fra noi c’era anche Alina, dalle lunghe trecce bionde egli occhi di giada, che fu per qualche tempo la mia fidanzata ufficiale, anche se adesso non so più dove sia finita. Le parlavo, le spiegavo, lei faceva sempre di sì con la testa, ma non so se mi ascoltasse davvero. Andavamo a rubacchiare negli appartamenti del nostro quartiere e perfino nelle chiese ortodosse di Lipscani: coltelli da cucina e candelieri». Ragazzi di vita pasoliniani che ben vedremmo nel cinema social-esistenzialista di un Cristian Mungiu.
Tra «le città inventate» ci rimane incollata sulla retina la scuola di Borghetto frequentata da ragazzi «tra i nove e i tredici anni «[…] tutti la stessa classe pur avendo un programma differenziato. Ogni mattina il maestro, elegantissimo con la bombetta, il cravattino e le scarpe di vernice, li guida verso il cancello d’entrata dell’istituto. Impugna il frustino, tiene la testa alta e non si volta mai indietro. Gode di un consenso universale», fusione delle figure adulte, direttore del collegio e docente che si “perde” gli studenti nella passeggiata parigina, di Zéro de coduite (1933, Jean Vigo).
Il passo sintattico di Affinati ha l’andamento di un brano di Goran Bregovic, marcato dall’alternarsi di strumenti di assolo (trombone, sax, clarinetto) e orchestrati: a frasi brevi, impeccabili come staffilate, seguono frasi volutamente inanellate, dal sapore proustiano, simili ai piano-sequenza di un Miklós Jancsó. «Un gatto non costa niente e i bambini se lo tengono. Le pareti trasudano umidità. La guerra è finita da poco. Alla finestra hanno messo una coperta. Il baldacchino del letto dev’essere appartenuto ad una residenza di lusso. Questa è la capitale, magnifica nella sua povertà insolente, dove non c’è acqua potabile, le ragazze si lavano i piedi in una catinella, d’inverno nevica, i ragazzini si drogano con una specie di colla, le anziane danzano, i vecchietti fanno provvista di legna, il pomeriggio andiamo tutti al mercatino, i ponti sono distrutti quindi attraversiamo il fiume in barca, queli più intraprendenti fra noi vendono mazzi di violette oppure pescano nei rigagnoli».
L’amore di Affinati per il viaggio, per il camminare, per il dirigersi verso la montagna o la campagna, lungo un fiume alla Jean Renoir, o abbracciando la città e il mare in una sola interminabile carrellata alla François Truffaut, ma anche il calpestare le periferie pasoliniane, a piedi o su un Gilera anni Settanta, inquadrando in continuazione il paesaggio, è stato il suo respirare il mondo sin da adolescente. Quella che da giovane adulto diventerà poi la sua regia-scrittura.
Il libro madre di tutte le opere di Affinati e, a mio avviso, il drammatico e meraviglioso Campo del sangue (1996), un avvicinamento a piedi e con mezzi pubblici, attraverso la carne e il sangue di un lembo di Europa, fino ad Auschwitz: un camminare attraverso il Novecento. Parlando con decine e decine di autori tra le righe di ogni passo.
Osservare la vita delle cose alla Sergio Corazzini o alla Wysława Szymborska; gli animali (per es. i gatti di Gerusalemme) come suggerirebbero Jack London e Mario Rigoni Stern; i volti e i gesti impercettibili della vita degli altri schizzati alla John Fante ricordandosi di Sergej Paradžanov; respirare le periferie delle metropoli alla Akira Kurosawa o alla Martin Scorsese: tutto questo è lo schermo vivente dentro cui il nostro narratore, non si sa come, è già lì, casualmente, in attesa del lettore. Come un personaggio di Krysztof Kieślowski o di Ramón Gómez de la Serna.
Affinati filma sulla carta tutto il mondo incrociato dal suo indomito viaggiare. E per te, lettore, non appena giungi su quelle righe stampate, tutto si ri-anima sul tuo telone mentale, come accade a ogni fotogramma di Le città del mondo. Poiché, come sostiene de Oliveira, la letteratura, ti porta ovunque e ti fa vedere qualunque cosa. È, tra le arti, la più completa.








