Basta dividere, contrapporre Stati e comunità sempre più chiuse, arroccate: occorre unire, allargare. La storia di Beirut è la riprova che l’Oriente arabo potrebbe incamminarsi, con la sua bussola cosmopolita, verso un post-Novecento senza muri, senza ideologie totalitarie, rivitalizzando una democrazia che stenta, anche altrove. Riccardo Cristiano racconta il senso del suo nuovo saggio, “Beirut, il futuro del mosaico arabo”, edito da Castelvecchi
In un momento drammatico come l’attuale, segnato da tragedie che coinvolgono milioni di persone, in special modo in quello che chiamiamo “mondo arabo”, che senso può avere scrivere un libro su una città, nel caso di specie Beirut, centrato in particolar modo su alcuni tratti della sua storia ottocentesca? Il titolo, “Beirut, il futuro del mosaico arabo”, indica una traccia: basta dividere, contrapporre Stati e comunità sempre più chiuse, arroccate, occorre unire, allargare. La storia dei nazionalismi è andata male, panarabismo e panislamismo non ha più afferenza alla realtà. Le macerie di Libano, Siria e Iraq dicono che il mosaico va tirato fuori dalla polvere di case crollate, valorizzandone le diversità. Un incontro di territori, nei quali convivono diverse comunità. Un’ipotesi confederale? Forse, sta a loro deciderlo, ma comunque rispettando gli Stati bisogna avvicinare, con uno sguardo mediterraneo, quello di Beirut. Dunque un discorso di ingegneria istituzionale? No.
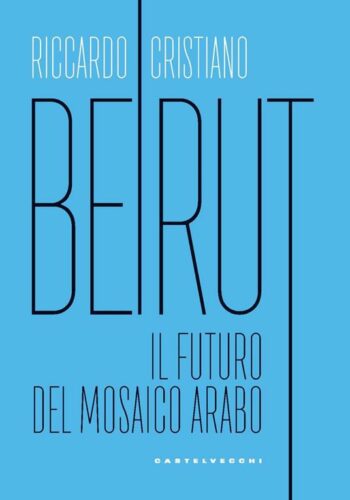 Una traccia per arrivare alla risposta alla domanda incalzante, “perché un libro su Beirut?” la offrono due definizioni di questa città forniteci da uno dei suoi figli più illustri, Samir Kassir, nato a Beirut da padre palestinese e madre siriana, tradotto anche in Italia grazie al suo capolavoro, “L’infelicità araba”. Nella sua storia di Beirut Kassir scrive: “Osiamo questa definizione, la meno definitiva possibile, e diciamo che Beirut, – riposa qui il suo principale interesse per lo storico – è stata una metropoli araba mediterranea occidentalizzata”.
Una traccia per arrivare alla risposta alla domanda incalzante, “perché un libro su Beirut?” la offrono due definizioni di questa città forniteci da uno dei suoi figli più illustri, Samir Kassir, nato a Beirut da padre palestinese e madre siriana, tradotto anche in Italia grazie al suo capolavoro, “L’infelicità araba”. Nella sua storia di Beirut Kassir scrive: “Osiamo questa definizione, la meno definitiva possibile, e diciamo che Beirut, – riposa qui il suo principale interesse per lo storico – è stata una metropoli araba mediterranea occidentalizzata”.
È una traccia molto interessante: una metropoli araba ma sul mare, portuale, tratto specifico dal quale deriva probabilmente la sua contemporanea natura di metropoli occidentalizzata. Nell’Ottocento lo scambio culturale di Beirut, e dell’affine Alessandria d’Egitto, con l’Europa era talmente diretto e profondo che questo “network” non riguardava solo il pensiero che oggi diremmo “mainstream”, ma c’era anche un network di pensiero radicale, ad esempio anarchico o socialista, di cui troviamo tracce sorprendenti in tante riviste beirutine di fine Ottocento e inizio Novecento. L’arrivo della modernità anticipò il Novecento in Europa con il grande movimento che ha preso il nome di fin de siècle: l’espressione del crollo di un sistema di valori e di un modello di vita, e, allo stesso tempo, come l’alba di una nuova epoca. Beirut, metropoli araba, ne è stata parte, o quanto meno è stata direttamente collegata a questa esperienza: nell’anno della sua morte mise in scena una piece teatrale di grande successo sulla storia di un importante anarchico, Francisco Ferrer, dalle idee abbastanza anticlericali, e infatti leader ecclesiastici la accusarono di blasfemia, ma autori e interpreti furono tutti assolti.
Più avanti, nella stessa opera, Samir Kassir ci fornisce un’altra indicazione per comprendere e collocare nella nostra mente Beirut: “Città araba ma strana, strana ma araba”. È così. Per spiegare per quale ragione convenga con lui devo tornare a una delle prime visite a Beirut. C’ero stato negli anni conclusivi della guerra civile, della quale ricorre proprio in questi giorni il cinquantesimo anniversario dell’inizio, 13 aprile 1975. Una guerra interminabile, che ho seguito solo nelle sue ultime battute, ma che ha lasciato tracce evidenti di gruppi di dissidenti di ogni provenienza che avevano trovato riparo a Beirut, tutti. Poi, qualche tempo dopo sono tornato e abituato ai sistemi di altri Paesi arabi mi sono subito recato al ministero dell’informazione per registrarmi e accreditarmi. “Ti vai ad accreditare? Ma sei scemo? Qui siamo a Beirut, forse ti sei confuso”. La franchezza sorpresa nella voce del mio amico e collega mi ha introdotto al capitolo molto delicato per loro della “libertà di stampa”. Non si tratta di una gentile concessione, le pressioni ci sono e ci sono state, sempre, come anche le morti violente di tanti colleghi, uccisi per motivi politici. Le censure sono state tentate, certamente, l’autocensura anche, ma la libertà di stampa è un bene prezioso a cui Beirut non ha rinunciato, neanche nei tempi durissimi della sovranità limitata, sotto vigilanza siriana. Questo discorso andrebbe affrontato più approfonditamente e così lascio riaffiorare un ricordo: era da poco finito quel protettorato, ma sulla carta, e per andare più avanti si voleva presentare un manifesto di dissenzienti libanesi; grandi nomi. I servizi segreti riuscirono non a proibirlo, ma a far fare, all’ultimo momento, marcia indietro al direttore del grande albergo che aveva affittato ai promotori una loro sala convegni. «La sala è occupata», disse costernato agli organizzatori quando raggiunsero l’hotel. In meno di mezz’ora si chiese e si ottenne dalla Federazione della Stampa l’uso dei suoi locali, che fu concesso gratuitamente, e la presentazione ebbe luogo lì. Non penso che altrove sarebbe andata così: “Città araba ma strana, strana ma araba”.
Si può allora capire cosa intenda dire dicendo che Beirut ha una sua storia, che è anche la storia, oltre a questo, della cintura della miseria che ancora la avvolge. Sono quei quartieri dei miseri dove negli anni del successo economico del Libano si andarono ad assiepare tantissimi sciiti, i diseredati. Se di solito si dice che la rovina del Libano, ciò che innescò la guerra civile, fu l’arrivo dei guerriglieri palestinesi che portarono quella questione, la questione palestinese, dentro la questione libanese, si dice un fatto oggettivo: ma è oggettivo anche dire che la questione sciita preesisteva, era una questione sociale gravissima, e la pose un leader purtroppo eliminato prima del 75 in Libia, Musa Sadr. Con lui forse la storia sarebbe stata diversa: la sua lotta non violenta nel nome della questione sociale sciita, che un Paese affluente e di successo come il Libano non poteva tollerare, coinvolse le migliori energie cristiane: il vescovo melchita Gregoire Haddad animò con lui quel movimento per la giustizia sociale, coinvolgendo il nome più illustre del mondo ortodosso, Ghassan Tuèni: “Città strana ma araba, araba ma strana”.
La storia di Beirut ha due volti: quello dell’Ottocento, secolo in cui si affermò, divenendo nel breve volgere di pochi decenni una metropoli portuale e non più una dimenticata fortificazione sul mare senza neanche un attracco. I fuggiaschi dalle guerre confessionali che si combattevano lì attorno si rifugiarono tutti a Beirut e nonostante i loro dissapori evidenti ottanta loro notabili si unirono in una petizione al sultano per fare di Beirut una capitale di provincia, un grande porto, centro di commerci euro-mediterranei. È stato l’atto di nascita di una metropolita cosmopolita. La storia del Novecento è stata invece una storia di guerra degli identitarsimi a Beirut, distrutta durante la guerra civile per la sua natura promiscua. Ricostruita con la sua promiscuità, Beirut ha seguitato ad essere distrutta in questo interminabile Novecento: basti ricordare l’assassinio dell’uomo che l’ha ricostruita, l’esplosione del suo porto, il 4 agosto 2020, e le guerre… Non è ora che finisca questo interminabile e terribile Novecento?
Questa considerazione riguarda tutti e la conferma Beirut, con la sua storia di nemica combattuta dal Novecento. Per tutto quel mondo il Novecento è tempo che passi. Ma Beirut ci dice che per procedere occorre tornare indietro, al cosmopolitismo dell’Ottocento. Ecco allora che proprio Beirut potrebbe offrire a Libano, Siria e Iraq, Paesi che non ha più senso considerare in urto, essendo limitrofi, distrutti e bisognosi d’unire gli sforzi per uscire dal disastro, un’idea che ha prodotto tempo fa, che tutti hanno dimenticato e che invece potrebbe servire anche oltre i loro confini.
Il dissidio tra individuo e società, dimensione socio-comunitaria e dimensione individuale, è stato curato o si è aggravato? Per curare le sue ferite tra comunità diffidenti l’una dell’altra dopo la terribile guerra civile il Libano ha pensato una ricetta in gran parte fallita: uscire dalle difficoltà creando un partenariato islamo-cristiano, titolari entrambi del 50% dei seggi parlamentari. Il voto ha luogo per quote confessionali. Il risultato non è stato soddisfacente: i partiti confessionali, protagonisti della guerra civile, sono diventati una casta, nonostante la scelta della parità fosse un’intuizione geniale. Non contano i numeri, conta l’idea di essere ugualmente partner, cristiani e musulmani. Ok. Ma in Parlamento, nelle stanze del potere, partner lo sono diventati i membri della casta, non la popolazione.
Nelle carte degli accordi di pace c’è però una previsione che parla del domani, a tutta quell’area. Questo sistema confessionale potrebbe divenire una delle due colonne che sorreggono l’edificio istituzionale. Passando a un sistema bicamerale si potrebbe avere nell’altra Camera un sistema di voto come quello che abbiamo noi: ci sarebbero partiti politici di destra, di centro, di sinistra, come si vuole. E tutti voterebbero secondo la propria inclinazione le stesse liste di candidati. Così si darebbero garanzie alle comunità, alla dimensione socio-comunitaria di ciascuno, e diritti all’ individuo, costruendo legami diretti tra progressisti o conservatori, tra persone cioè che provengono da diverse comunità religiose. Così si scongiurerebbe il pericolo che le comunità divengano gabbie e che l’individuo si trasformo in un atomo, in un “io sovrano”, ma orfano.
Questo sistema dunque avvierebbe un’enorme novità, che riconoscerebbe l’individuo e i suoi diritti, le comunità e il loro bisogno di garanzie. Annullare la prima o la seconda colonna ha creato sistemi che non reggono, asfissianti, come tutto il Novecento dei diversi o opposti totalitarismi. La storia di Beirut è la riprova che l’Oriente arabo potrebbe incamminarsi, con la sua bussola cosmopolita, verso un post-Novecento senza muri, senza ideologie totalitarie, rivitalizzando una democrazia che stenta, anche altrove.








