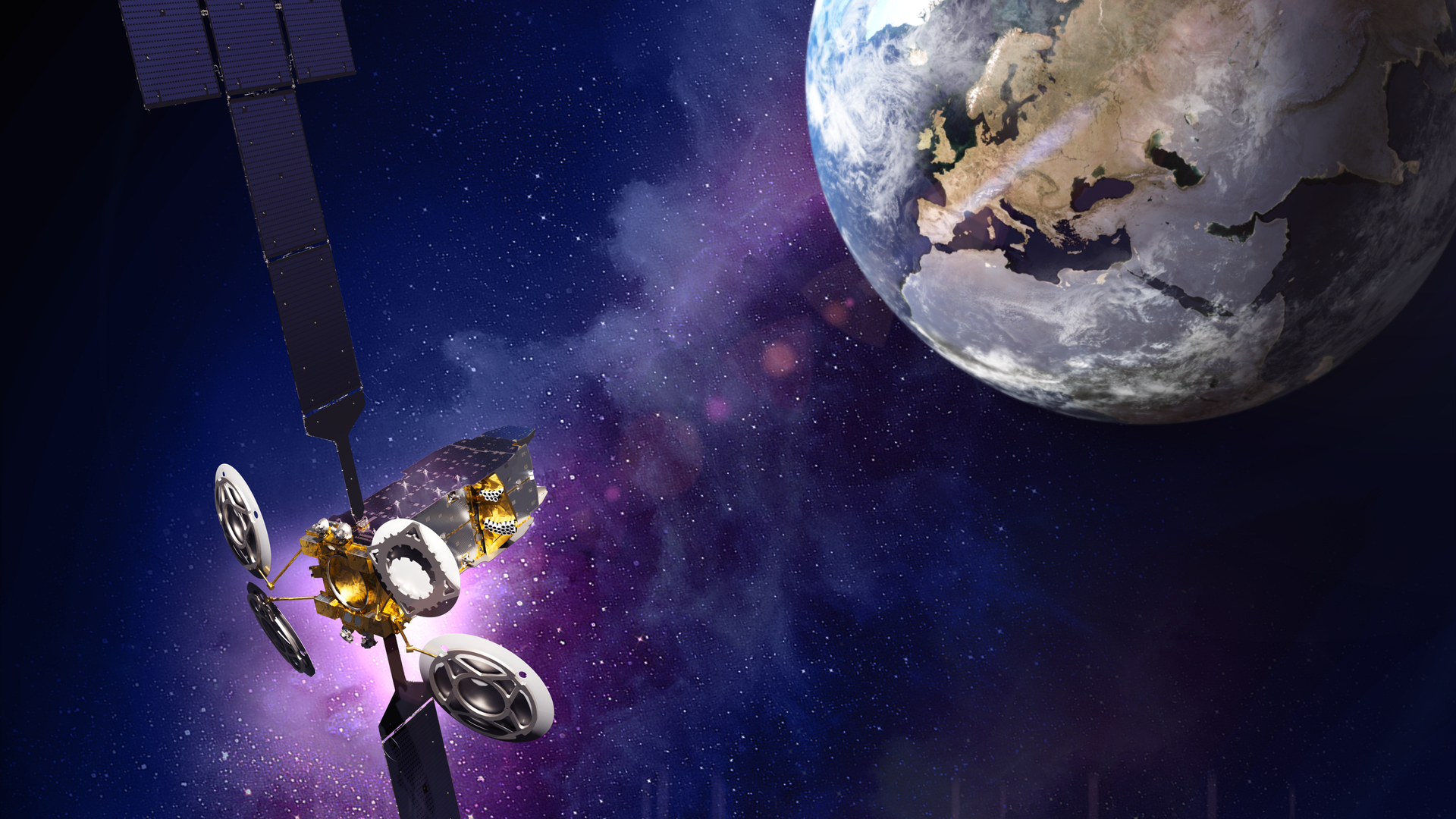Giuliano Berretta è stato molto più di un dirigente d’azienda. Ha plasmato Eutelsat, trasformandola in un player globale del settore satellitare. Dotato di visione tecnica e spirito imprenditoriale, ha anticipato la trasformazione digitale e l’uso strategico dello spazio, in modi oggi associati a figure come Elon Musk. La sua storia, oggi quasi rimossa dal dibattito nazionale, invita a ripensare il ruolo dell’Italia nella nuova economia spaziale e il prezzo dell’aver perso una leadership che avevamo contribuito a fondare. La riflessione del professor Marco Lisi, inviato speciale per lo Spazio del Maeci e membro del board dell’Agenzia spaziale italiana
Il 26 maggio è scomparso Giuliano Berretta, personaggio dello spazio italiano ed europeo sconosciuto ai più e anche alquanto ignorato dalle cronache.
Berretta ha guidato con lungimiranza e audacia Eutelsat, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni satellitari al mondo, contribuendo a rivoluzionare l’accesso globale alle comunicazioni. È stato inoltre un autentico visionario nel campo dell’innovazione tecnologica, tanto che lo potremmo definire, seppur con un profilo meno mediatico e roboante, “l’Elon Musk italiano”.
Vale la pena accennare alle sue umili e alquanto travagliate origini familiari. Nato a Decameré, nell’Eritrea allora italiana, orfano di padre, è costretto ad immigrare in Italia con la madre nell’immediato dopo guerra.
Dopo aver conseguito il dottorato in Ingegneria elettronica all’Università di Padova nel 1964, Berretta ha iniziato la sua attività professionale nella mitica Selenia e successivamente in Telettra, specializzandosi nello sviluppo di stazioni televisive.
Nel 1971 comincia a lavorare nell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso lo European Space Research and Technology Centre (Estec) nei Paesi Bassi, per poi trasferirsi nel 1978 a Parigi come responsabile delle missioni di telecomunicazione dell’Esa.
Il vero punto di svolta nella carriera di Berretta arriva nel 1983, quando entra in Eutelsat, l’organizzazione intergovernativa europea per le comunicazioni satellitari.
Eutelsat era nata da pochi anni, nel 1976, come un’organizzazione intergovernativa per lo sviluppo e la gestione di satelliti di telecomunicazioni per servizi fissi (telediffusione e telefonia internazionale) in Europa.
In Eutelsat l’Italia era inizialmente rappresentata da Asst (Azienda di stato per i servizi telefonici), l’ente pubblico economico incaricato della telefonia internazionale e parte della Direzione Generale delle Telecomunicazioni, che poi confluirà in Sip (Società italiana per l’esercizio delle telecomunicazioni), l’allora monopolista pubblico del servizio telefonico. SIP era parte dell’Iri-Stet, holding di Stato per le telecomunicazioni. Telespazio, all’epoca partecipata da Finmeccanica (oggi Leonardo) e Stet, svolgeva un ruolo operativo e tecnico di primaria importanza, ma non era il firmatario ufficiale.
Con intuizione visionaria, Berretta prevede l’enorme potenziale commerciale dei satelliti di comunicazione in anni in cui, se Internet emetteva i suoi primi vagiti, le televisioni private aggredivano il mercato ed aspiravano a raggiungere il maggior numero di utenti.
Berretta scala rapidamente i ranghi: nominato direttore commerciale nel 1990, nel 1998 viene eletto direttore generale e poi amministratore delegato fino al 2011.
Sull’onda di una serie di successi commerciali e tecnici, Eutelsat vivrà un’eccezionale evoluzione, trasformandosi in società privata nel 2001 e poi, quotata in borsa nel 2005, arriverà nel suo massimo storico ad un valore di mercato di 7miliardi, associato ad un Ebitda del 78%. In altre parole, un lucrosissimo business, antesignano della New Space Economy.
Un business così appetitoso da attirare grandi investitori privati europei. E l’Italia, che essendo uno Stato fondatore aveva diritto ad una sua quota azionaria?
Nel 1998 (governo Amato) ci fu una legge per il riassetto delle telecomunicazioni, specialmente le satellitari, e si decise di cedere la partecipazione italiana.
Dimostrando una volta di più la sua mancanza di strategia a livello nazionale, l’Italia, contrariamente alla Francia (che ha mantenuto una partecipazione significativa tramite Bpifrance, circa 14% nel 2023) ed alla Germania, perderà progressivamente nel tempo il controllo delle sue quote, un asset di enorme valore economico ed ancor più strategico.
Nel frattempo Berretta, profeta inascoltato in patria, aggrediva il mercato sviluppando la flotta di satelliti geostazionari HotBird, posizionata a 13° Est, che diventa un punto di riferimento per la trasmissione di canali TV in Europa, tra cui quelli di Rai, Mediaset, Sky e Tivùsat. La piattaforma HotBird arriverà a gestire oltre 3.700 canali TV, espandendo la presenza di Eutelsat in Europa orientale, Africa, Medio Oriente e Nord America.
Ma il più grande merito di Berretta è stato quello di aver promosso l’espansione delle trasmissioni digitali, anticipando di almeno un decennio il passaggio dalla televisione analogica al digitale. Fu tra i primi a comprendere che il satellite non era solo uno strumento per trasmettere canali televisivi, ma una piattaforma per connettività internet, dati aziendali e servizi emergenti come la telemedicina e la didattica a distanza. In questo, la sua visione è veramente paragonabile con quella di Elon Musk, che con Starlink ha portato il concetto di internet via satellite al grande pubblico e su scala globale.
L’ironia della sorte è che, a distanza di venti anni, ci ritroviamo a discutere di costellazioni europee, IRIS2 o OneWeb, entrambe pesantemente legate ad Eutelsat. L’Italia stenta a prendere una decisione fra Starlink ed una soluzione europea, lamentando una qualche invadenza di quella Eutelsat, che proprio un geniale italiano ha portato al successo e della quale qualche altro meno avveduto italiano dismise ogni nostra partecipazione.
Berretta ci lascia una lezione positiva, da non dimenticare: con capacità tecnica, spirito imprenditoriale, visione proattiva ed invincibile determinazione, anche lo spazio italiano potrà vincere le aspre sfide della New Space Economy.