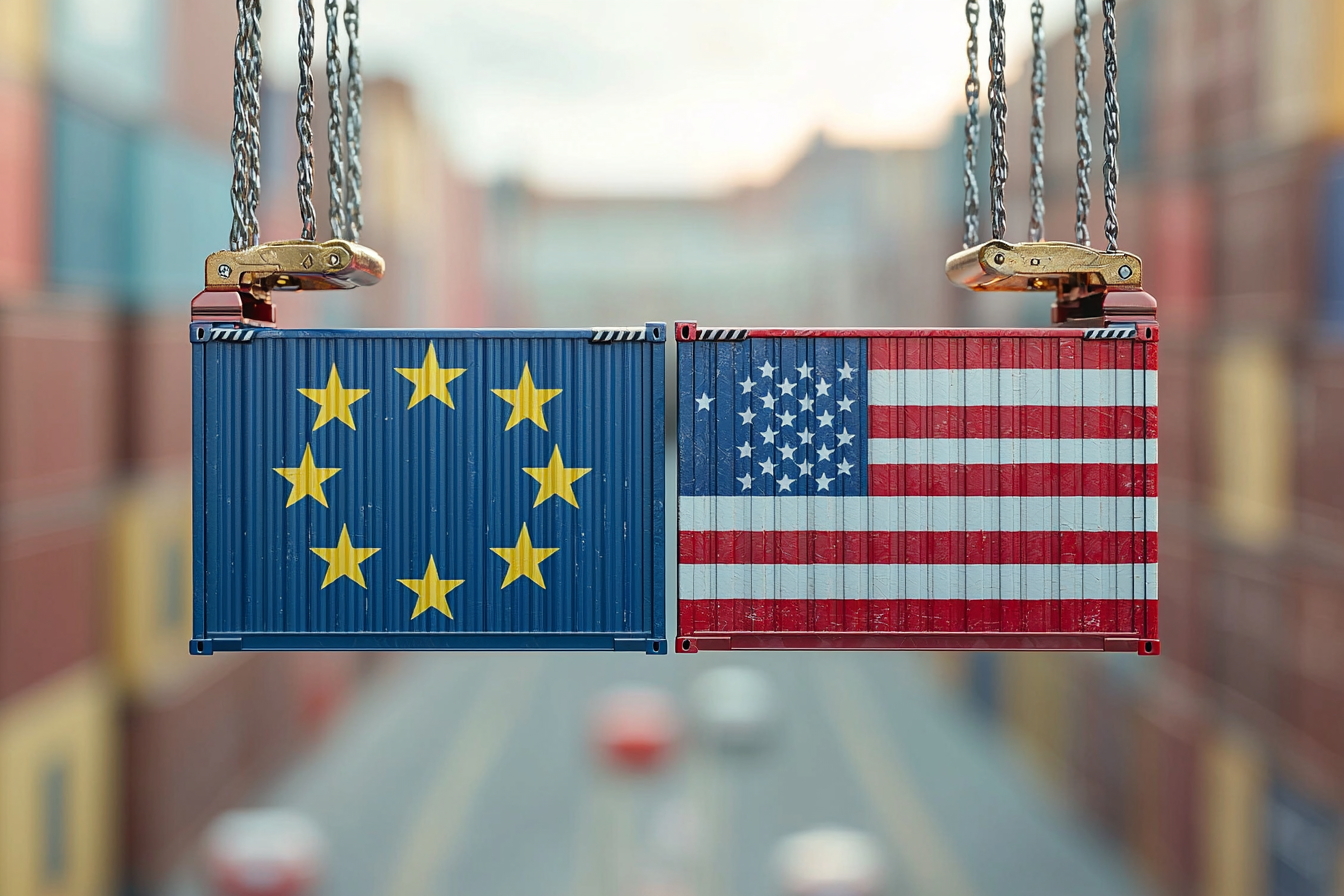All’indomani dell’accordo commerciale sui dazi raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea, emergono dubbi e interrogativi. Secondo Domenico Lombardi, professore alla Luiss, “l’Ue ha perso un’occasione storica. Dopo il cosiddetto liberation day del 2 aprile c’era la possibilità di negoziare una tregua al 10%. L’unico Paese a riuscirci è stato il Regno Unito. Bruxelles non solo non ha colto l’opportunità, ma non ha nemmeno provato a inseguirla”
Un’occasione perduta, al di qua dell’Atlantico. All’indomani dell’accordo commerciale sui dazi raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea, emergono interrogativi – oltre che sull’impatto reale che le tariffe avranno sulle economie degli Stati nazionali – anche sulla capacità di Bruxelles di muoversi con rapidità ed efficacia in uno scenario di crescente rigidità americana. Formiche.net ne ha parlato con Domenico Lombardi, professore alla Luiss ed esperto di dinamiche economiche internazionali, che ha analizzato le implicazioni economiche e politiche dell’intesa.
Professore, l’accordo è stato presentato come un compromesso tutto sommato accettabile anche da parte dell’Ue. Qual è la sua lettura?
In realtà l’Ue ha perso un’occasione storica. Dopo il cosiddetto liberation day del 2 aprile c’era la possibilità di negoziare una tregua al 10%. L’unico Paese a riuscirci è stato il Regno Unito. Bruxelles non solo non ha colto l’opportunità, ma non ha nemmeno provato a inseguirla. Nel frattempo Washington ha irrigidito la propria posizione come peraltro era ampiamente prevedibile.
Qual è il nodo più critico del negoziato?
Non è solo l’aliquota in sé, ma il suo ambito di applicazione. L’Ue ha mancato il treno del 10% e ha perso anche la battaglia sulle esenzioni. Il 15% che abbiamo ottenuto è lo stesso livello di Giappone e Corea del Sud, economie molto più piccole. Questo dice molto, ancora una volta, sulla debolezza negoziale europea.
Perché l’Europa è rimasta indietro?
La Commissione non è stata veloce. Non ha saputo approfittare di una finestra strategica, perché è mancata visione politica. Fra l’altro va tenuto presente che le grandi economie europee sono esposte agli Stati Uniti in misura diversa: l’Italia è la più vulnerabile poiché più elevato è il sue export in termini relativi, poi vengono la Germania e, infine, la Francia. Di conseguenza, anche l’impatto dei dazi è variegato.
La scelta dei settori da proteggere o sacrificare è mancata?
Sì. Queste sono decisioni eminentemente politiche, e la Commissione non ha avuto la forza – o forse il mandato – di prenderle. Alcuni governi internamente deboli, come quello francese, hanno persino in qualche misura sfruttato la questione dazi per riscuotere un dividendo politico, protraendo l’incertezza e distogliendo l’attenzione dalle questioni interne.
Chi pagherà i dazi? Le imprese o i consumatori?
In parte le aziende esportatrici, in parte gli importatori americani e in parte i consumatori finali. L’Italia esporta beni ad alto valore e relativamente meno sensibili al prezzo: il vino di qualità, la moda, la farmaceutica e la meccanica di precisione. Questo aiuta ad ammortizzare l’impatto. Inoltre, la riallocazione dell’import americano a favore di giurisdizioni con tariffe più basse potrebbe comunque favorire, in parte, l’Ue.
Colpisce l’esenzione concessa al settore digitale. Come se lo spiega?
Francamente, non è chiaro. Nel digitale Bruxelles aveva qualcosa da giocare: la semplificazione di una regolamentazione oggi ritenuta, in Europa, eccessivamente stringente. Sarebbe stato un win-win: offrire uno spiraglio alle big tech americane e, al contempo, alleggerire il peso burocratico sulle piccole e medie imprese europee e italiane in particolare (vista la morfologia del nostro tessuto imprenditoriale) che impatta sulla loro profittabilità e produttività. Un’altra occasione persa.