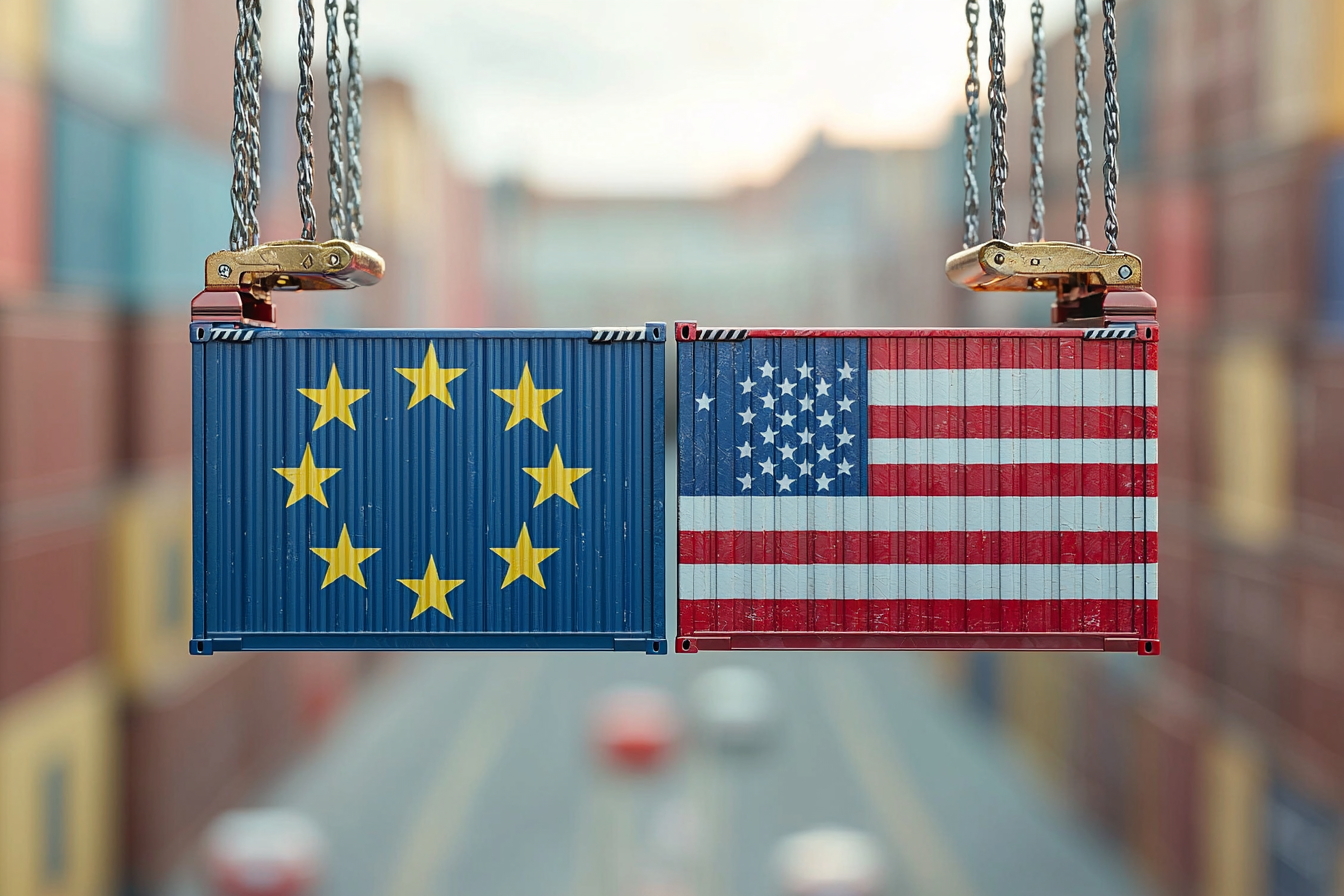Nel complesso lo shock dei dazi di Trump è notevole, ma le conseguenze per l’economia italiana potrebbero mitigarsi se la Commissione, il governo e la Bce offrissero alle imprese un sostegno indiretto, facilitando l’assorbimento all’interno e la diversificazione dei mercati di sbocco. L’analisi di Salvatore Zecchini
La brusca quadruplicazione dei dazi americani sulle merci europee pone una vera sfida alle imprese italiane e alle autorità economiche sui modi e mezzi per assorbirne l’impatto al minor costo per la crescita, l’inflazione, gli investimenti, l’occupazione e la bilancia corrente con l’estero. Una buona parte, ma non del tutto, dell’incertezza sulla grandezza del rialzo si è ormai dissipata, anche se rimangono molti interrogativi sulle esenzioni e sul regime che si applicherà a categorie merceologiche molto rilevanti per il Paese, come i farmaceutici, l’automotive, l’acciaio, l’alluminio e non ultimi i vini e alcolici. Indeterminate pure le modalità con cui si potrebbero rispettare gli impegni europei a investire nell’economia americana $ 600 miliardi e ad acquistare $ 750 miliardi di prodotti energetici dagli Usa.
Per le imprese il rischio più immediato consiste nella contrazione delle vendite in un mercato che contribuisce per il 10% all’export merceologico del Paese e rappresenta per importanza il terzo sbocco commerciale con un valore nel 2024 di oltre 76 miliardi. A questo effetto si somma il deprezzamento del dollaro che dall’inizio dell’anno ha portato al rincaro dell’euro del 13,9%. Pertanto i produttori europei attualmente devono confrontarsi con una potenziale pressione sui loro prezzi di circa il 29% sul mercato americano. L’impatto è reso ancor più negativo dal contemporaneo impegno dell’Ue a investire più capitali oltreoceano, di fatto sottraendoli a un potenziale impiego all’interno per il potenziamento produttivo, nonché dalla deviazione di gran parte degli acquisti d’energia, in particolare di gas naturale, verso fornitori americani, anche se meno convenienti.
La valutazione dell’impatto economico varia a seconda del metodo impiegato, dei settori, della dimensione delle imprese e dei tempi. Per la Confindustria, dazi al 30% più che dimezzerebbero le vendite negli Usa nel medio-lungo periodo con un effetto negativo sulla crescita tendenziale del Pil dello 0,8% e sull’occupazione. Ovviamente queste stime non tengono conto che le imprese probabilmente reagiranno per attenuare l’impatto. Un’altra organizzazione di imprese, Unimpresa, stima che le imprese sono in grado di assorbire gran parte dello shock dei dazi al 15% con interventi di diversificazione dei mercati di sbocco e con misure di efficientamento all’interno.
Già in passato le imprese italiane hanno mostrato grande capacità di adattamento agli shock esterni e di reazione costruttiva alle avversità del ciclo economico per fortificarsi, ma non tutte riescono a superare le fasi di perdita di competitività che implica una minore domanda, senza attraversare difficili processi di ristrutturazione. Le imprese esportatrici sarebbero, tuttavia, le più capaci, in quanto da ripetute analisi risultano essere più competitive, più adattabili, con maggior produttività e più innovative rispetto al resto del sistema. La gamma di prodotti esportati risulta anche più ampia di quella dei maggiori partner nell’Ue. In contrasto, benché nel decennio in corso un numero crescente di Pmi si siano rivolte ai mercati esteri, si è registrata una maggiore concentrazione delle esportazioni in numero limitato di imprese dalle dimensioni medie e grandi. Particolarmente le medie imprese sono riuscite a conquistare posizioni dominanti in nicchie produttive del mercato mondiale, in cui contano innovazione, qualità del prodotto e lavorazioni su misura.
Per l’export italiano non conta solo la competitività di prezzo ma un insieme di caratteristiche proprie del Made in Italy. Gli scenari che si aprono quindi dopo il rincaro delle barriere tariffarie vanno analizzate su più dimensioni e non semplicemente in termini di rapporto costo-prezzo. In primo luogo, va considerato chi sarà gravato maggiormente del nuovo onere tariffario. In via di principio è a carico dell’importatore americano, ma avrebbe come reazione lo spostamento verso fornitori più convenienti, sempre che il prodotto importato abbia sostituti comparabili. Lo spostamento non avverrebbe rapidamente perché la modifica dei fornitori comporta ricerche, valutazioni e tempi non rapidi.
Molto rilevante nella reazione dell’importatore è l’elasticità della domanda alla variazione del costo d’importazione. In presenza di un’elevata elasticità (ovvero superiore all’unità) l’effetto negativo sulle quantità domandate è più consistente e meno ritardato. Pertanto, è necessario considerare quanto il prodotto italiano sia rimpiazzabile? La stima deve basarsi sulle categorie di prodotti di provenienza dall’Italia, distinguendo anche tra prodotti intermedi e strumentali, che fanno da input in altri processi produttivi, e prodotti destinati ai consumatori. La struttura merceologica dell’export italiano verso gli Usa vede nelle prime due posizioni in termini di valore macchinari e farmaceutica, seguiti a distanza da veicoli e apparecchi elettrici e elettronica. Sono categorie in cui l’elasticità di prezzo della domanda americana nel medio periodo appare più elevata che per i prodotti del lusso, moda, arredamento e casa, ossia il Made in Italy, in cui fanno premio la creatività e la distinzione dalla concorrenza.
Per una stima d’impatto meno generica è opportuno compiere analisi approfondite e dettagliate sia sul versante americano che su quello italiano. Su entrambi, i risultati indicano che il trasferimento (pass-through) dei maggiori oneri dovuti ai dazi sui prezzi finali all’export e quindi sul prezzo di vendita dell’importatore americano nel medio periodo non è completo, in quanto una parte viene assorbita dall’impresa esportatrice. Il trasferimento varia a seconda del prodotto e del tempo richiesto.
Per le imprese americane, uno studio di Yilmazkuday dello scorso anno (Florida International University), dopo aver tenuto conto delle interazioni tra i diversi fattori, giunge alla conclusione che il trasferimento dai prezzi all’importazione a quelli alla produzione dopo cinque anni ammonterebbe al 72%, mentre sui prezzi finali sarebbe al 25% circa. Uno shock al prezzo alla produzione, peraltro, si trasferirebbe per poco più della metà dell’importo (57%) su quello al consumo. Il profilo temporale del passaggio si differenzia per prodotto e nell’arco del quinquennio. La ripercussione sui prezzi alla produzione è rapida, sostanziale e stabile nel tempo, anche se parziale. Quella sui prezzi al consumo sarebbe inferiore, ma crescente negli anni fino al terzo anno. La dimensione relativamente minore dell’impatto appare in linea con la formazione del prezzo al consumo, che sconta una notevole componente dovuta ai costi della distribuzione.
Per le imprese italiane il quadro è pur sempre di un trasferimento parziale dall’esportatore all’importatore americano. Uno studio di un economista della Banca d’Italia (F. Parlapiano) del 2024 getta luce sull’entità del trasferimento dal prezzo alla produzione a quello finale di vendita, che nel caso specifico dei dazi sarebbe applicabile all’importatore americano. Esaminando i dati rilevati a livello di imprese, giunge alla conclusione che uno shock di 5 punti percentuali per i prezzi alla produzione si riflette in incrementi di prezzi di vendita di circa 3 punti, ossia la traslazione avviene al 63-66%. Le imprese più grandi sono più pronte delle meno grandi al trasferimento del rincaro sui prezzi per preservare i loro margini di valore aggiunto, ma anche per loro una parte del rincaro è assorbita.
Da queste indagini si deduce che i margini delle imprese esportatrici, particolarmente le Pmi, saranno sotto pressione per diversi trimestri e che dovranno condividere con gli importatori americani l’onere dei dazi se intendono mantenere i volumi di vendite su quel mercato. Ma le reazioni delle imprese allo shock non riguardano soltanto i prezzi, in quanto potrebbero comprimere i costi, innovare i loro prodotti e renderli meno sostituibili, potenziare il marketing ed investire direttamente per produrre in America. I grandi progressi nella competitività, realizzabili con il ricorso all’IA generativa, offrono ad esempio opportunità mai viste in passato e implicherebbero riorganizzazioni interne.
Ma un sostegno importante dovrebbe provenire dalle autorità europee e da quelle italiane. Alla Commissione incombe la responsabilità di raggiungere il consenso sulle parti in sospeso dell’accordo tariffario nel senso più favorevole all’Ue rispetto a quanto finora concordato. A questo fine andrebbe abbandonato quell’atteggiamento di accomodamento alle richieste americane, che sembra andato oltre il necessario particolarmente quando non si è data credibilità al piano di ritorsioni già predisposto. Dovrà anche fare in modo che il migliore trattamento tariffario accordato da Trump al Regno Unito non conduca a un certo spiazzamento degli esportatori dell’Ue da parte dei concorrenti britannici con cui competono con prodotti aventi caratteristiche analoghe, come nelle tecnologie, nel lusso e nella moda. Concretamente dovrà alleviare il peso delle regolamentazioni e facilitare l’accesso ai capitali per investimenti all’interno, offrendo maggiori convenienze ed economie esterne rispetto agli americani.
Analoghe responsabilità ricadono sul governo italiano, mentre sarebbe una cattiva reazione se offrisse, a fronte di esportazioni negli Usa, elargizioni finanziarie, o incentivi non rimborsabili, come compartecipazioni alla capitalizzazione delle imprese, oppure compensazioni, perché equivarrebbero a finanziare le imprese americane a spese del contribuente italiano. Sarebbe, invece, appropriato alleggerire la tassazione sulle imprese, offrire servizi pubblici adeguati, incentivare la formazione delle forze di lavoro alle nuove tecnologie, sburocratizzare e semplificare i gravami sulle imprese, assisterle nella penetrazione in mercati esteri alternativi a quello americano, e servizi di accompagnamento nella penetrazione nel mercato mondiale. L’impiego di garanzie su crediti alle Pmi esportatrici è una condizione necessaria.
Dal canto suo, la Bce con la sua condotta monetaria potrebbe favorire l’assorbimento dello shock tariffario. Accrescendo la disponibilità di credito, promuovendo maggiore concorrenza nel sistema del credito e con una politica di tassi d’interesse relativamente bassi in un contesto d’inflazione sotto controllo, potrebbe frenare l’ascesa dell’Euro sul dollaro e limitare le conseguenti perdite di competitività per il sistema. Nella stessa ottica dovrebbe evitare di applicare le più stringenti regole bancarie previste dal terzo accordo di Basilea in contrasto con la recente decisione americana di ritirarsi dall’accordo.
Nel complesso lo shock dei dazi di Trump è notevole, ma le conseguenze per l’economia italiana potrebbero mitigarsi se la Commissione, il governo e la Bce offrissero alle imprese un sostegno indiretto, facilitando l’assorbimento all’interno e la diversificazione dei mercati di sbocco.