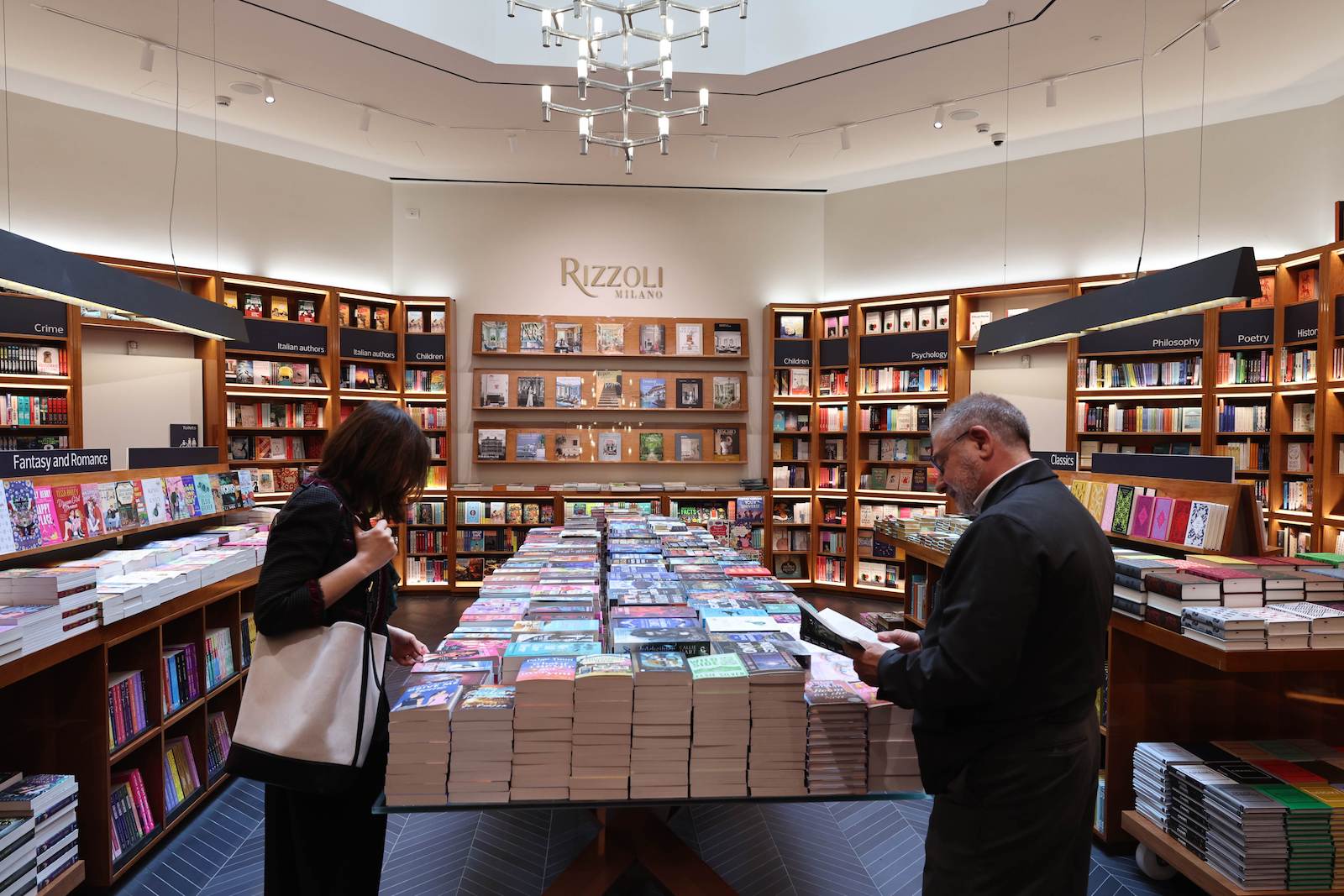La cultura è una parte fondamentale della nostra esistenza. Ma lo è altrettanto saperla incardinare all’interno di un tenore di vita che arricchisca le persone, e le renda, se non più felici, quantomeno più consapevoli. La riflessione di Stefano Monti
Con cadenza annuale l’Istat pubblica, tra i vari approfondimenti, anche dati legati alla fruizione culturale da parte dei cittadini, uniti ad altri indicatori relativi alla spesa culturale pubblica e privata.
Il dibattito che segue la pubblicazione di tali dati, in genere, si basa sempre su un presupposto fondamentale, e vale a dire che più si consuma cultura, meglio è.
Un’impostazione senza dubbio condivisibile, ma che in qualche modo falsa qualsivoglia tipologia di riflessione legata al consumo e alla fruizione culturale.
Un esempio concreto può aiutare.
Come indicato dalla puntuale analisi condotta da Abenate e Garofalo per lavoce.info, è possibile identificare un forte divario territoriale in termini di spesa culturale: mentre nel nord e nel centro si registra una spesa media mensile simile (circa 123 euro per il nord e 118 nel centro), nel mezzogiorno le famiglie spendono all’incirca la metà (circa 59€), con un’incidenza della spesa in cultura pari al 2,6% sul totale delle spese familiari contro il 4% del centro e il 4,1% del nord.
Leggendo questi dati viene naturale immaginare che si rendano necessarie delle politiche di incentivi alla spesa culturale per il sud del Paese, ma la struttura della rilevazione, in realtà, non consente di poter affermare con certezza questa ipotesi.
Parte di quel divario, ad esempio, può essere imputabile ad una differente distribuzione dei prezzi, o ad una preferenza di determinate fruizioni piuttosto che altre.
Per capire meglio questa argomentazione, si prendano i dati, forniti dagli stessi autori, relativi allo spettacolo, così come diramati dal rapporto Siae.
Scindendo tra cinema, teatro, concerti e mostre, il primo segmento ha sicuramente un predominio totale sul numero di spettacoli: 2.743.414 spettacoli contro i circa 150 mila del teatro, gli 87mila delle mostre e i 65mila dei concerti. Se il numero di spettatori conferma in ogni caso il ruolo di leadership del cinema (seguito da concerti, teatro e mostre), la spesa in cinema rappresenta invece la 3° categoria.
Se si guarda alla spesa, dunque, i concerti registrano la cifra di € 989.339.839, contro i circa 578 milioni per il teatro, i 540 milioni per il cinema e i 158milioni per le mostre.
Apprendere il ruolo fondamentale che i concerti giocano nella spesa in cultura genera una serie di riflessioni legate al lato dell’offerta: è ad esempio noto che nel nord e nel centro del Paese si concentrano maggiori artisti internazionali, come il caso di Bad Bunny, a Milano, che ha già registrato sold-out per i prossimi concerti di luglio 2026, il cui prezzo del biglietto varia tra i 100 e i 150 euro; allo stesso modo, non è da trascurare il ruolo dei programmi estivi di città di medie dimensioni del sud-Italia, che spesso ospitano performance di musicisti a prezzo calmierato o a titolo completamente gratuito.
Certamente ci sono altri elementi che incidono su questo divario, e verosimilmente una differente attitudine ai consumi culturali rientra tra questi elementi, ma il punto centrale della riflessione è che, pur auspicando un ruolo centrale della cultura nella nostra democrazia, nella nostra società e nella vita di tutti i cittadini, né l’attuale struttura delle rilevazioni, né riflessioni concrete legate alle altre modalità di trascorrere il proprio tempo libero non consentono di stabilire “quanta” cultura sarebbe giusto fruire.
Leggere più di 10 libri l’anno, in una visione meramente statistica, potrebbe risultare un dato positivo, ma potrebbe invece riflettere una difficoltà a socializzare.
Trascorrere tutti i propri week-end in luoghi in cui si erogano contenuti culturali può ad esempio incidere sulla quota di tempo libero trascorso all’area aperta, o in attività di trekking e qualsiasi altra azione che preveda un rapporto diretto con il nostro patrimonio naturale e paesaggistico.
Non a caso, quando si commenta il consumo culturale aggregato, si tende ad utilizzare dei riferimenti non costruttivi: dalla mala-movida agli smartphone, mentre è raro che ci si interroghi sulla quota di tempo libero trascorsa con la famiglia, magari raccontando vecchie storie, o semplicemente giocando ad un gioco di società acquistato decenni fa.
Adottare una visione che debba necessariamente promuovere un sempre maggiore consumo di cultura implica una importante trasformazione dei comportamenti sociali, in parte già avvenuta, e alla quale bisogna guardare con lucidità. Promuovere una società in cui l’elemento del tempo libero diviene quasi indivisibile dalla dinamica del consumo, significa in ogni caso promuovere uno stile di vita in cui il tempo libero viene completamente impegnato.
La cultura è una parte fondamentale della nostra esistenza. Ma lo è altrettanto saperla incardinare all’interno di un tenore di vita che arricchisca le persone, e le renda, se non più felici, quantomeno più consapevoli.