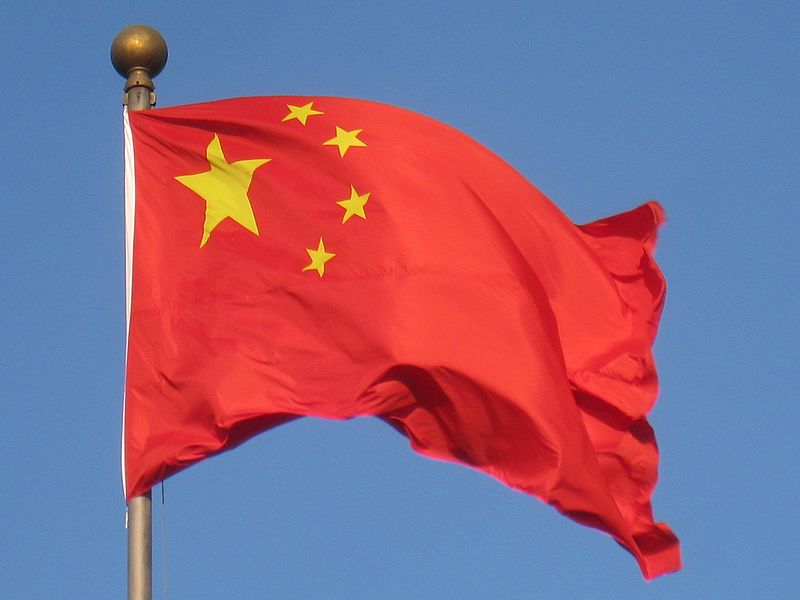Un recente rapporto di Unimpresa mette in evidenza che il 50% delle imprese quotate alla borsa di Milano sono controllate da capitale non italiano. L’informazione, peraltro non sorprendente, non ha un significato necessariamente negativo. Innanzitutto significa che investitori stranieri qualificati hanno fiducia nel sistema Italia. Significa poi che il patrimonio di know how delle nostre imprese suscita appetiti interessanti.
Non bisogna, del resto farsi illusioni. Le imprese del capitalismo familiare italiano non sono attrezzate dal punto di vista manageriale per raggiungere le dimensioni necessarie per essere, come va di moda dire oggi, dei global players. La cultura manageriale non si costruisce in pochi anni. Basti pensare che la prima impresa gestita da un imprenditore stipendiato e non proprietario, la Bosch, nacque nel 1770. Le grandi ferrovie transoceaniche americane furono possibili proprio grazie alla capacità manageriale disponibile come ha magistralmente messo in evidenza Alfred Chandler con il suo classico “Strategia e Struttura” (traduzione italiana di Strategy and Structure, Anchor Books, New York, 1966, Milano, FrancoAngeli 1982).
In questa fase di reshuffling dei mercati e delle filiere produttive, l’integrazione delle imprese italiane in strutture di maggiori dimensioni, dotate di capacità finanziare adeguate a far fronte alle necessità di investimento nello sviluppo di nuovi processi e prodotti, è indispensabile. Bisognerebbe comunque chiederci se questa fase vada subita o governata.
Nella scelta del global player in cui integrarsi la variabile culturale non andrebbe sottovalutata. Essere integrati in un global player che mantiene una forte caratterizzazione nazionale (come sono di solito le grandi imprese europee) significa che i tecnici ed i manager di cultura italiana avranno vita difficile in futuro e si vedranno fagocitati dal management dell’impresa in cui sono stati assorbiti. Essere integrati, di converso, in global players multiculturali (come sono spesso le grandi aziende americane) apre al management e ai tecnici italiani sviluppi di carriera globali.
Tutto particolare è il caso della Cina. La capacità finanziaria con cui la Cina opera sui mercati occidentali per acquisire imprese nei paesi capitalisti non è il frutto di abilità manageriali, assolutamente assenti in Cina. Si tratta di ingenti risorse finanziarie accumulate in patria con metodi di tipo feudale che vengono riversate nel mondo occidentale, non secondo una logica di mercato, ma secondo linee di strategia politica.
Qui voglio riferire una mia esperienza personale. Alcuni anni or sono mi sono trovato coinvolto in un programma dell’European Centers Study Program della Ue in Cina. Due sono i fatti che meritano di essere riferiti.
Durante un corso che tenni all’Università di Xiamen (provincia del Fujan) ad una classe di docenti universitari cinesi di economia, diritto, e scienze politiche, tutti fluenti in Inglese, fui meravigliato dallo scoprire che nessuno dei partecipanti aveva idea di cosa fosse il double entry bookkeeping. Nella discussione che seguì cercai di far capire che la contabilità a partita doppia trova la sua base nel fatto che l’impresa è qualcosa di diverso dall’ambiente in cui opera. Nel corso di questo tentativo tentai di far notare ai dotti studenti che formavano la classe che gli stabilimenti Lenovo avevano sicuramente dovuto comperare il terreno su cui sono insediati. La reazione dei dotti studenti cinesi fu: “Il terreno è messo a disposizione dal city council”.
Tentai allora di far notare che quanto meno il personale della Lenovo era sicuramente pagato dalla Lenovo. Anche qui la reazione fu la stessa: il personale era sicuramente pagato dai vari city councils in cui si trovano gli stabilimenti. Mi fu chiaro che non dovevo meravigliarmi se il concetto di partita doppia non era conosciuto da esperti di economia, diritto e scienze politiche. Nella cultura cinese l’impresa non è un player autonomo.
Poco tempo dopo questa mia esperienza didattica sono stato contattato dalla responsabile della sezione “economia italiana” dell’accademia delle Scienze di Pechino che mi chiese di organizzarle degli incontri con l’imprenditoria fiorentina e pratese. Cosa che feci. Durante questi incontri, molto franchi, la signora Luo Hong Bo(cha ha studiato in Italia all’Università delle Calabrie ad Arcavacata e parla un italiano impeccabile) disse chiaramente che l’economia cinese gira tutta attorno a 120 imprese di Stato e che le cosiddette imprese private sono tutte nell’orbita di queste imprese. Mi resi presto conto, tra l’altro, che la sezione “economia italiana” dell’accademia delle Scienze Cinese opera come una sorta di agente operativo e non solo di ricercatore scientifico.
A questi due ricordi personali aggiungo una considerazione di tipo teorico. Si tratta del fatto che il diritto di proprietà in Cina è in effetti solo un diritto d’uso facilmente annullabile. Lo scandalo suscitato dall’iniziativa americana di inquisire la figlia del patron della Huawey non dovrebbe essere uno scandalo. Gli occidentali dovrebbero cominciare a rendersi conto dell’importanza della variabile culturale nei rapporti economico-commerciali con la Cina, variabile che dovrebbe indurre a misure di particolare cautela, soprattutto quando fossero in gioco asset cruciali e strategici.