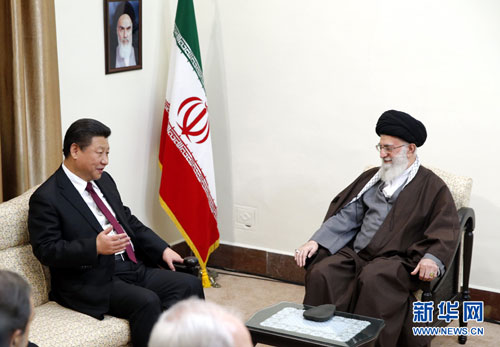Cina e Iran stanno attraversando una fase interna molto complicata. Un punto in comune, secondo Scita (Bourse&Bazar Found.) è come Tehran e Pechino si chiudono davanti alle istanze delle collettività che toccano i simboli delle leadership
Jîna Amini, iranianizzato Mahsa, è morta in una caserma della polizia morale di Teheran dove era stata condotta per “provvedimenti punitivi” visto che non indossava correttamente il velo islamico. La sua vicenda ha scatenato un’ondata di rabbia in tutto l’Iran: persone di diverse estrazione sociale, demografia, etnia hanno dato fuoco a una serie di proteste che durano da tre mesi. Il velo, al cui uso è stata data via via maggiore importanza nella Repubblica islamica come forma di moralizzazione della società, e dunque come metodo per aumentare il controllo teocratico sulle masse, è il simbolo delle proteste iraniane.
Ma le manifestazioni di insofferenza e odio nei confronti della leadership religiosa che compone il regime (l’élite teocratica e il suo strumento armato politico-sociale, i Pasdaran) riguardano qualcosa di molto più ampio. Le politiche scelte, molte per ragioni ideologiche connesse alla necessità di conservare il potere, non sono condivise dagli iraniani. Molto semplicemente perché non portano prosperità. Non permettono sviluppo, chiudono il Paese mentre è forte il desiderio — soprattutto tra i più giovani — di apertura. All’élite teocratica viene contestato di aver scelto la propria protezione e salvaguardia, ossia i propri interessi, e aver tralasciato quello del popolo.
Quando giovedì 24 novembre si sono diffuse le notizie dell’incendio in cui hanno perso la vita dieci persone a Urumqui, nello Xinjiang, quello che si è innescato tra i cinesi è stato qualcosa di simile. La responsabilità per le vittime è stata addossata alle scelte delle autorità locali di chiudere alcune parti del grattacielo in cui è avvenuta la tragedia per ottemperare alle disposizioni di controllo dell’epidemia, ma anche per soddisfare le indicazioni della leadership centrale. In Cina, sono queste misure il simbolo contro cui si protesta, che come il velo islamico in Iran sono diventate parte identitaria delle scelte della leadership.
Le manifestazioni di insofferenza davanti alle scelte del Partito/Stato erano un elemento che viaggiava appena sotto la superficie, a volte affiorate e costantemente controllate dalla censura. La vicenda di Urumqui, come quella di Mahsa, ha svelato drammaticamente una realtà nota: i cinesi non accettano più i lockdown, perché vedono altrove azioni e scelte diverse. Percepiscono che contro il virus la scelta debba essere proattiva e non costantemente difensiva, comprendono che la chiusura è una mossa di protezione della leadership, vedono ridursi costantemente le loro possibilità perché sanno che le chiusure significano sofferenze (economiche, sociali, psicologiche). Nonostante il bombardamento della propaganda, in Cina c’è ormai un livello di consapevolezza sui fallimenti delle autorità nella gestione della pandemia.
“Il punto su cui si basa questo parallelismo non è tanto una rottura tout court del contratto sociale tra società e leadership, piuttosto l’evidenza delle difficoltà che questi sistemi autoritari al potere, sia in Iran che in Cina, hanno nel comprendere parte delle istanze che muovono una parte della società civile in quei Paesi”, spiega Jacopo Scita, policy fellow alla Bourse Bazar Foundation, esperto delle connessioni Iran-Cina.
Per Scita queste difficoltà sono strutturali, non tanto dipendenti dalla leadership al potere, ma legate al fatto che “certi regimi per la loro natura hanno una serie di simbologie e di indirizzi politici che diventano fondamentali nella definizione della peculiarità, della straordinarietà del regime stesso, e nel momento in cui ci sono delle istanze sociali che in qualche modo vanno a opporsi e contrastare questa simbologia fondante, si crea il punto di crisi”.
Le società iraniane e cinesi sono molto complesse, con meccanismi compresenti e dinamiche di cooptazione articolate, dove è difficile parlare di società civile come corpo unico, fa notare l’analista. E dunque queste differenze interne distintive danno anche il limite all’accomunamenti di certe situazioni. Iran e Cina sono impegnate in dossier differenti e sfide diverse, sia interne che esterne. Evitando sovrapposizioni semplicistiche, i punti di interpolazione sono però evidenti nella difficoltà che le amministrazioni incontrano nel tornare indietro da scelte di policy che rappresentano la propria narrazione strategica.
“Andare a scardinare, a lottare contro aspetti che queste leadership considerano identificativi e definenti, innesca una reazione automaticamente violenta, anche se le richieste della popolazione rappresentano questioni teoricamente risolvibili. Questo perché sia le autorità in Iran che in Cina si sentono profondamente messe in discussione, considerando quelle richieste come la messa in discussione dell’autorità stessa”.