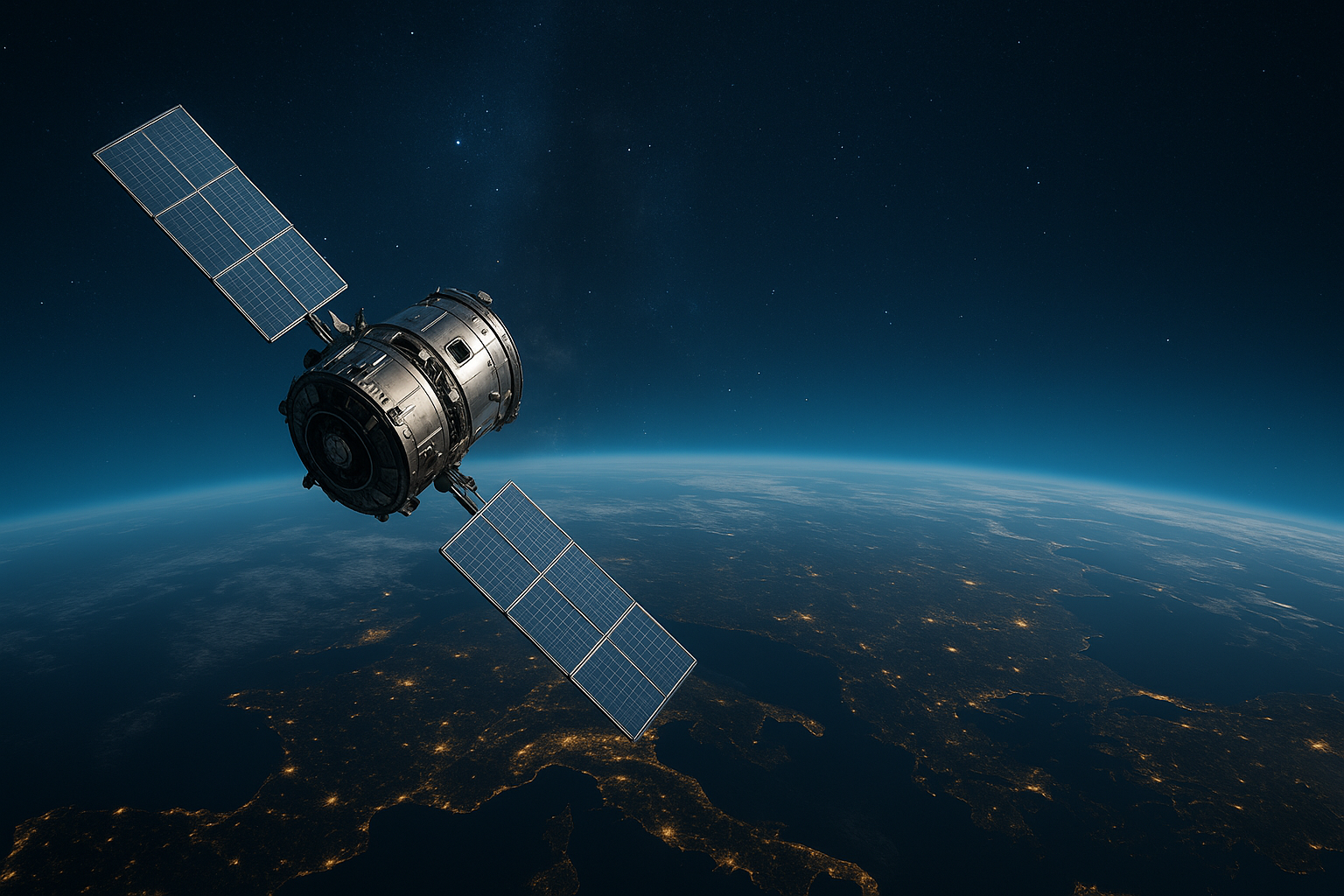Dalla coniazione del termine NewSpace nei primi anni 2000 all’accelerazione industriale degli anni 2010, dove siamo oggi e come ci siamo arrivati. Il parere di Veronica La Regina, direttore del Research Center for Space Futures di Riyadh
A dispetto della sua percezione come “movimento giovane”, il NewSpace non ha un singolo atto di nascita incontestabile. Il termine viene generalmente ricondotto ai primi anni 2000, per distinguere nuovi attori e modelli di business ad alta dipendenza da capitale privato, processi “lean” e convergenza tra tecnologie digitali e spaziali, rispetto all’“Old Space” più legato a procurement pubblico e cicli lunghi. Si tratta di imprese piccole e snelle che si contrappongono ai giganti Large Systems Integrator (LSI) di cui se ne contavano meno di 20 a livello mondiale.
Più che un evento puntuale, il NewSpace appare quindi come una dinamica spontanea emersa dall’intersezione di sviluppi tecnologici, decisioni di policy e shock macroeconomici che hanno ridisegnato incentivi e profili di rischio anche perché l’operato dei LSI era nel frattempo diventato inefficiente ed oneroso per le economie nazionali anche degli Stati più solidi.
Nel dialogo tra pubblico e privato, la questione di fondo è diventata: “quali segmenti del settore spaziale possono essere trasferiti all’investimento privato per introdurre rischio nell’economia e generare nuove opportunità imprenditoriali?”
È da questo interrogativo che prende forma la prima ondata di imprenditori e investitori statunitensi intenzionati a erodere i privilegi dell’economia pianificata che aveva caratterizzato per decenni il settore spaziale, dove l’accesso allo spazio era riservato a pochi attori selezionati attraverso decisioni centralizzate di agenzie spaziali e ministeri della difesa.
I primi segni si colgono nel premio Ansari XPRIZE, nel set up del Google Lunar X Prize e dalle prime partnership pubblico privato per la commercializzazione dell’ISS e delle sue stesse operazioni a partire dalla logistica, cargo ed umana, e da servizi in orbita.
È così che, nel corso del primo decennio degli anni 2000 e per almeno un altro decennio successivo, nasce un numero crescente di startup, inizialmente negli Stati Uniti e poi in Europa e nel resto del mondo. Questo processo sancisce un nuovo paradigma: se hai un’idea legata allo spazio e la trasformi in un progetto imprenditoriale, esiste finalmente la possibilità che gli investitori privati ti ascoltino. Da qui prende forma una nuova dimensione industriale che rivoluziona competenze, ruoli professionali e identità umane dell’intero settore spaziale.
Startup è la nuova password
Ci siamo, quindi, ritrovati in uno scenario dove le esigenze formative del settore spaziale sono cambiate con una rapidità tale da lasciare molti impreparati. La commercializzazione ha richiesto una combinazione rara, quale visione strategica, senso critico, intuito imprenditoriale e solida competenza tecnico scientifica. Aver delegato per decenni la gestione delle risorse a figure stataliste o a manager d’azienda più che d’impresa ha rischiato di compromettere i benefici stessi della NewSpace Economy. Un’economia che, nelle sue intenzioni, dovrebbe permettere a chiunque di “comprare spazio” con il proprio salario: dal lancio di un CubeSat all’acquisto di dati di Osservazione della Terra, senza più passare attraverso procedure interminabili presso agenzie pubbliche e ministeri, né pagare prezzi politici insostenibili.
L’abbattimento delle barriere d’ingresso nel settore spaziale è merito quasi indiscusso del NewSpace. Questo progresso, però, ha avuto un prezzo elevato, pagato da un’intera generazione spesso celebrata come un concentrato di energia e intelligenza. In realtà ha eroso risorse in termini di mesi senza stipendio dei lavoratori (fondatori e non) di startup accompagnate da notti insonni, viaggi in autostop e dormite sui divani degli amici pur di incontrare investitori, partecipare a eventi e conquistare visibilità e opportunità di crescita.
L’Occidente racconta questa storia come un’epopea di coraggio, contrapponendola alle condizioni di lavoro disumane di Cina, India e altri Paesi. Eppure, il bilancio non è così roseo: anche nelle economie più avanzate si è accettata la rinuncia a diritti laburistici consolidati pur di reagire al dirigismo industriale tipico delle grandi imprese dell’“Old Space”. In cambio, il modello startup ha offerto libertà d’azione, autonomia di pensiero e la possibilità di costruire una propria identità professionale. Un patto implicito che una generazione di ventenni ha accettato e che oggi, arrivata ai quarant’anni, ne porta ancora i segni.
Oggi chi vince?
All’inizio del 2026, dopo quasi un quarto di secolo di progressiva trasformazione, è naturale chiedersi che cosa sia davvero cambiato nel settore spaziale. Le recenti dinamiche geopolitiche indicano un ritorno di forme di protezionismo, sia nazionale, sia regionale o sia ancora basate su alleanze politico-militari, che può ostacolare la maturazione di un mercato spaziale realmente globale. In un mercato “maturo”, infatti, il “più forte” non è necessariamente chi spende di più, ma chi conquista quote significative offrendo servizi competitivi e sostenibili, con prezzi determinati da domanda, concorrenza e rischio, e non da tariffe politiche.
Eppure, le idee più visionarie per raggiungere l’orbita bassa anche con la presenza umana e persino la Luna hanno fatto affidamento su ingenti capitali privati. Sul fronte del capitale privato, la fase pre-guerra in Ucraina ha raggiunto un picco nel 2021, dove diverse analisi riportano un massimo storico intorno a 15,4 miliardi di dollari di investimenti globali in startup spaziali. Dal 2022 in poi si osserva un ridimensionamento coerente con il re-pricing dell’intero mercato venture/tech (tassi più alti, valutazioni più compresse, maggiore selettività degli investitori). La cifra del 2021 non si è più ripetuta dopo la crisi russo ucraina, quella di Gaza e da ultimo anche le tensioni in America Latina. Nel 2024 gli investimenti privati globali si sono fermati a circa 9 miliardi di dollari, segnando un rallentamento evidente.
In parallelo, la geopolitica non “spiega” da sola la contrazione dei volumi, ma sta cambiando la composizione della domanda e dei modelli industriali: cresce il peso di programmi e supply chain legati a difesa, sicurezza e autonomia strategica. In questo contesto, una parte del NewSpace tende a tornare “Old-Space” attraverso maggiore consolidamento (M&A) e logiche industriali più verticali, con l’obiettivo di internalizzare capacità critiche e competere su procurement e contratti governativi.
Altre realtà NewSpace sono state assorbite da logiche finanziarie aggressive, confluite in nuovi conglomerati industriali che ripropongono forme di dirigismo simili a quelle dell’era pre NewSpace. Un segnale evidente è il numero crescente di ex dirigenti di Agenzie (e. g. NASA) formatisi in contesti altamente burocratici oggi alla guida di realtà che dovrebbero rappresentare l’avanguardia dell’innovazione e dell’integrazione industriale.
In questo scenario, si moltiplicano le voci che invocano un ritorno massiccio dell’investimento pubblico per sostenere il settore privato e rilanciare la capacità di innovazione. Da un lato, risuona il canto delle sirene che invita l’“Ulisse spaziale” a costruire modelli di fornitura nazionalisti ma con ambizioni di mercato globale. Dall’altro, il protezionismo finanziato con fondi pubblici si scontra con un dato di fatto, ossia i grandi fondi di investimento stanno acquisendo un peso politico crescente, diventando gli unici attori in grado di garantire resilienza tecnologica e sicurezza di approvvigionamento in un contesto in cui persino le economie più solide del G8 affrontano livelli di deficit significativi.
Alla luce di ciò, la domanda finale diventa inevitabile, ossia l’Europa, con la Ministeriale Esa CM25 che ha approvato 22,3 miliardi di euro per il periodo 2026–2028, sta creando sufficiente scala e mercato per far crescere campioni industriali europei, oppure sta anche alimentando (indirettamente) le giurisdizioni dove risiedono quote crescenti dei capitali che finanziano l’ecosistema?
Nel corso del 2024 e del 2025 si sono registrati round di investimento particolarmente significativi per diverse startup europee del settore spaziale, caratterizzati da una presenza rilevante di capitali non europei. Ad esempio, D-Orbit (Italia) ha chiuso un round di oltre cento milioni di dollari, guidato dal conglomerato giapponese Marubeni. ICEYE (Finlandia) ha raccolto circa 158 milioni di dollari, con la partecipazione del fondo statunitense BlackRock. Dark (Francia) ha ottenuto sei milioni di dollari, con la presenza del fondo statunitense Long Journey. Magdrive (Regno Unito) ha raccolto 10,5 milioni di dollari, con investitori principali quali Founders Fund e Alumni Ventures, entrambi statunitensi. EnduroSat (Bulgaria) ha chiuso un round da 104 milioni di dollari, sostenuto da investitori statunitensi come GV/Google Ventures, Lux Capital, Riot Ventures e Shrug Capital. Reflex Aerospace (Germania) ha raccolto 50 milioni di dollari, con Human Element (Usa) come investitore principale.
Nel complesso, questi round confermano una forte capacità delle startup spaziali europee di attrarre capitali extra UE. Tuttavia, questa tendenza, pur riflettendo la crescente competitività dell’ecosistema europeo, mette anche in luce una dipendenza strutturale da investitori globali, in particolare statunitensi e asiatici.
Dai round più rilevanti del 2024–2025 emerge infatti una dinamica ricorrente: il capitale internazionale tende a seguire la domanda sovrana e le applicazioni dual use, sostenendo la crescita delle imprese europee ma, al tempo stesso, spostando leve di governance e ritorni economici verso i Paesi in cui risiedono gli investitori.
In prospettiva, questo equilibrio può diventare fragile. Se in futuro gli attori pubblici europei non aumentassero gli investimenti nei programmi spaziali, gli investitori non europei potrebbero decidere di ridurre o ritirare il proprio supporto, lasciando le conseguenze operative e strategiche interamente sulle spalle dell’Europa.
Conclusioni o punti di ripartenza?
Ogni buon articolo dovrebbe offrire conclusioni; qui, più utilmente, conviene lasciare al lettore alcune “pulci” capaci di generare una ripartenza verso un dibattito più denso: in quale misura il valore aggiunto della nuova economia spaziale torna davvero a beneficio di chi la finanzia, spesso senza rendersene conto, ossia i contribuenti?
Nel caso europeo, i contribuenti continueranno a sostenere un investimento pubblico nell’ordine dei 23 miliardi di euro per il prossimo ciclo quadriennale di ESA, in continuità con una traiettoria pluridecennale (non a caso nel 2025 l’ESA ha celebrato numerosi anniversari e traguardi istituzionali). La giustificazione politica è nota, ossia rafforzare autonomia strategica, competitività industriale, sicurezza e capacità tecnologica. Tuttavia, la domanda centrale resta aperta: come si attrae capitale non europeo garantendo che il valore creato da competenze, filiere, IP, occupazione qualificata, base industriale rimanga, poi, in Europa in modo strutturale?
Il rischio è che l’Europa finisca per creare condizioni eccellenti per investitori extra-europei. Si tratterebbe di un “accesso” relativamente economico a un settore sostenuto da spesa pubblica, con rendimenti potenzialmente interessanti e una quota rilevante dei costi indiretti (tempi, complessità regolatoria, esternalità ambientali e di sicurezza) scaricata sul sistema pubblico europeo. In questa prospettiva, non sorprende che Stati con crescente disponibilità di capitale e know-how, ad esempio alcune economie del Golfo, possano preferire investire in imprese europee già mature, riducendo il rischio tipico della fase pionieristica e, al contempo, accelerando l’apprendimento necessario a far nascere in seguito attori nazionali propri.
Chi paga davvero, e chi incassa davvero? La domanda rimane.