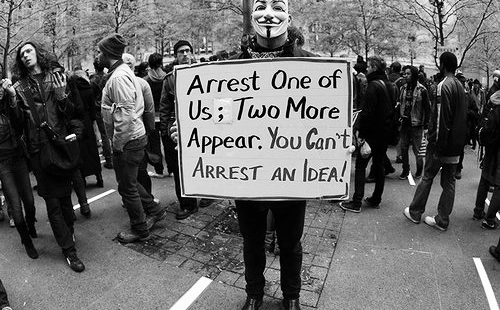Basta prendere una sedia per unirsi a loro. La roulette della sorte si ferma sulla casella “valute alternative”. In pratica dovrebbero inventarsi un modo per fare a meno dei soldi. Un compito non trascurabile cui si dedicano 20-30 persone di estrazione e competenze assai variegate. La notizia di giornata, però, è che il movimento ha messo da parte circa 700mila…
Archivi
Noi e gli altri (di cui abbiamo bisogno)
Vista con occhi di un investitore straniero, l’Italia appare come uno strano e complicatissimo marchingegno. Abbiamo un sistema legale troppo complesso, un welfare di buona qualità ma a costo poco efficiente e livelli di tassazione molto alti che non incentivano certo la creazione di ricchezza. Eppure l’Italia riesce a compiere una serie di miracoli industriali, riuscendo ad essere molto competitiva…
Istruzioni per una svolta sostenibile
Nella lotta al cambiamento climatico il ruolo delle città, in cui ormai vive oltre la metà della popolazione mondiale, è sempre più rilevante: il 75% dei consumi di energia e l’80% delle emissioni di gas serra derivano dalle aree urbane. La questione di come modellare le infrastrutture delle città diventa ancora più importante perché da anni soffrono di un…
Pianificazione di qualità
Parlare di sviluppo economico, ambientale e sociale significa, oggi più che mai, prendere in considerazione le città come elemento di analisi e di intervento. La qualifica di città intelligente spetta pertanto a quegli agglomerati urbani che attivano politiche in grado di farle diventare “efficienti e sostenibili” sotto diversi aspetti: energia e ambiente, mobilità, tecnologie della comunicazione, politiche sociali. Ciò che…
Arrestato il "corvo" del Vaticano: è il maggiordomo del Papa?
È in stato di arresto l’uomo operante in Vaticano, individuato dalla Gendarmeria come in possesso di documenti riservati. “È Paolo Gabriele, aiutante di camera della famiglia pontificia”, riferiscono indiscrezioni dalla Santa Sede. Il presunto “Corvo” è ora a disposizione del promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi. Lo ha reso noto il vice direttore della Sala Stampa, padre Ciro Bendettini. Era…
Esempi virtuosi (da imitare)
Innovazione diffusa, sinergia tra amministrazione locale, imprese e mondo della ricerca, miglioramento costante della qualità della vita e dei servizi: le smart cities stanno gradualmente cambiando il paradigma nelle politiche urbane di numerosi Paesi europei, favorendo l’emergere di nuove modalità di interazione tra cittadini e servizi pubblici e più in generale un approccio totalmente nuovo verso l’utilizzo delle tecnologie del…
Valli: Cosa c'è dietro la sfiducia di Ettore Gotti Tedeschi
Ettore Gotti Tedeschi è sempre stato in prima linea in quanto a gestioni di trasparenza. Per questo la vicenda della sfiducia del Consiglio di sovrintendenza dell’Istituto per le Opere di Religioni è inspiegabile. Queste sono le considerazioni del vaticanista Aldo Maria Valli. “Il professore Gotti Tedeschi era impegnato nell’opera di trasparenza allo Ior non solo per adeguare l’istituto alle…
...o almeno ingegnose
Le città sono ormai il luogo delle opportunità e dei problemi della contemporaneità. L’aspetto forse più caratterizzante delle città italiane è il loro cuore antico, il centro storico e il patrimonio culturale diffuso: più che un limite verso la loro modernizzazione, questa specificità è invece una straordinaria occasione per una forte caratterizzazione identitaria. Una forte identità è un fattore…
Evoluzioni intelligenti
C’è un’isola in cui gli abitanti sono dotati di display che contabilizzano produzione, consumi, costi legati all’energia; produzione distribuita di energia rinnovabile, edifici a bassi consumi energetici e smart grid come reti di connessione. Investimenti ingenti da parte di un “consorzio” di decine di imprese, università, governo compreso, che testano e sviluppano tecnologie. Investimenti tra il 2009 e il 2013:…