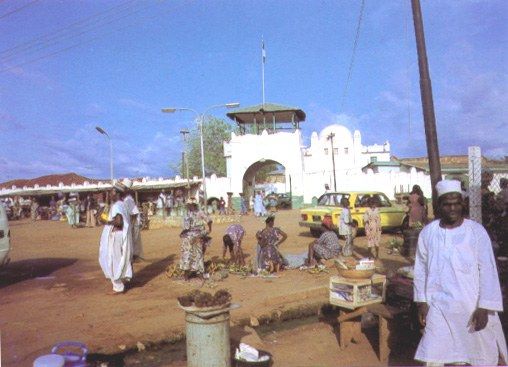Se ne parla molto in Africa, e con accenti fortemente divergenti. Se ne parla abbastanza in Gran Bretagna, dove pesa il passato coloniale che – attraverso il “Commonwealth” – è anche presente e futuro. Se ne è parlato in America in occasione della recente visita alla Casa Bianca del presidente nigeriano Muhammad Buhari, che ha incassato il concreto sostegno di “The Donald” all’aspra lotta che non ha fine contro i sanguinari terroristi di “Boko Haram”. In Europa, no… Non se parla per niente. Il Biafra – nome tristemente paradigmatico, associato a morte, fame, carestie, ingiustizie – è dimenticato e omesso. Come se non esistesse più. Come se la terribile guerra civile combattuta dal maggio 1967 al gennaio 1970 fosse stata consegnata senza aggiornamenti ai libri di storia: tracannata, digerita e archiviata in poco più di mezzo secolo. Un milione e 200 mila morti su undici milioni di abitanti (allora); la catastrofe biblica dei bambini biafrani (quelle drammatiche immagini noi, cinquanta-sessantenni, ce le abbiamo ancora negli occhi, un pugno nello stomaco, un grido disperato cui non abbiamo risposto se non con la compassione); la vasta e ricca regione africana – il sud-est cristiano della Nigeria, “la terra che galleggia sul petrolio” – distrutta e depredata.
Ma non sarà a lungo possibile continuare a copiare le “tre scimmiette”, che non vedono-non sentono-non parlano. Nel Biafra dei fieri “Igbo” (o “Ibo”) la voglia di secessione dalla Nigeria non è mai scomparsa. Apparentemente sopita dal pugno di ferro di Abuja (Lagos, megalopoli caotica, non è capitale); sotterranea per paura e per disperazione; vago anelito di speranza, non suffragata dalla realtà, non confortata da alleanze e solidarietà. Ma, col tempo, l’esasperazione nei confronti del governo centrale controllato dall’etnia maggioritaria degli “Hausa-Fulani” – che privilegia il nord musulmano, in partenza molto più povero – e deruba e reprime, dopo averlo smembrato in undici province, il sud-est ricco e colto, tenendolo accuratamente lontano dalla “stanza dei bottoni”, questa ribellione politico-economica e morale è riesplosa fragorosamente. E non da oggi. Per lo più nel silenzio internazionale. Anche perché lo Stato nigeriano, mai diventato una nazione a causa della sua frammentazione etnica “risolta” a tavolino dagli ex-padroni inglesi e campione delle disuguaglianze, è comunque il gigante economico d’Africa: una crescita annua del 7 per cento, “oro nero” e risorse naturali (iniquamente distribuite) come se piovesse. E, dunque, non conviene alzare la voce a favore di chi ne minaccia l’integrità territoriale. Laggiù investire conviene comunque.
Malgrado tutto questo, almeno dal 2015 la pressione dei separatisti ha ripreso a farsi sentire, a livelli assai preoccupanti per la tranquillità dell’autoritario Buhari, generale in pensione, un passato da dittatore (poi convertito per forza al parlamentarismo), alfiere di una lotta alla corruzione condotta a senso unico. I suoi trascorsi militari sono riemersi con brutale chiarezza. Centocinquanta morti, tutti ribelli fedeli al “mezzo sole giallo”, che campeggiava nella bandiera del “fu Biafra”, indipendente per meno di quattro anni. Una repressione sistematica e spietata. Il leader del movimento secessionista “Ipob”, il carismatico Nnamdi Kanu, sfuggito in settembre a un agguato mortale, uccisi venti suoi miliziani, “missing” da allora, secondo la vulgata, fu prigioniero delle patrie galere, sottoposto in contumacia a processi-farsa. “Terrorista e bugiardo, come tutti i suoi”, lo liquida Buhari nei discorsi ufficiali, pronunciati non per spegnere, ma per alimentare l’odio. Come se non bastasse l’odio, e la scia di sangue, seminati dai fanatici jihadisti di “Boko Haram”: assassini, rapitori e stupratori di giovani donne, una violenza cieca che il governo nigeriano è riuscito a restringere territorialmente, ma non a far scemare di intensità e di pericolosità. La Nigeria, presa in una morsa, rischia forte.