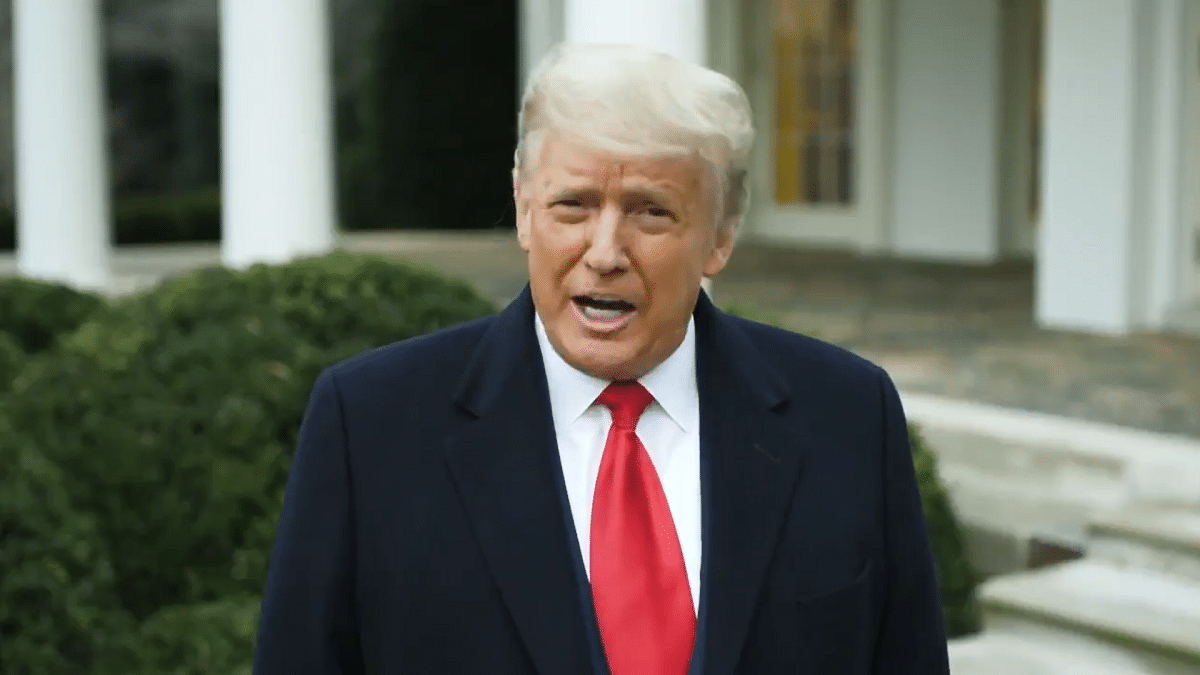Annunciata la riduzione degli operativi statunitensi dai teatri di guerra di Afghanistan, Iraq e Siria. Trump raggiunge un obiettivo politico annunciato fin dall’inizio del mandato e lascia il segno sulla futura amministrazione, che avrà difficoltà a rendere potabile un’inversione di policy
Il Pentagono ha annunciato la riduzione del personale a 2500 operativi tanto in Afghanistan che in Iraq, secondo il piano costruito da Donald Trump, che aveva promesso ai suoi elettori di lasciare la Casa Bianca col minimo dei soldati impegnati in quelle che lui ha più volte definito le “endless war”. Ossia le guerre senza fine che coinvolgono gli Stati Uniti da molti anni — e il teatro afghano è quello dove sono impegnati da più tempo, 20 anni quest’anno, per un intervento scattato come risposta ai collegamenti tra al Qaeda e i Talebani dietro alla tragedia del 9/11.
La data è simbolica per altro: il 15 gennaio 1973 l’allora presidente Nixon annunciò la sospensione immediata e definitiva di tutte le operazioni militari statunitensi in Vietnam. “Le forze militari statunitensi in Afghanistan sono al livello minimo da 19 anni”, e lo stesso “in Iraq e Siria”, scrive la Casa Bianca in una nota in cui il presidente Trump ha promesso di impegnarsi “sempre” per “fermare le guerre infinite”, per poi definire “un grande onore ricostruire il nostro esercito e sostenere i nostri coraggiosi uomini e donne in uniforme”.
La questione del ritiro dei militari è dibattuta. Da una parte c’è una larga fetta dell’opinione pubblica, liberal, conservatori, trumpiani, progressisti, moderati, che vogliono vedere (ognuno con proprie sfumature e declinazioni) gli Stati Uniti meno esposti su certi fronti; reputati troppo onerosi, in termini di costi economici e umani, e con poco tornaconto; criticati per il peso delle vittime civili che hanno prodotto; visti come il simbolo del concetto semplificabile in “l’America sceriffo del mondo” che molti elettori reputano anacronistico. Trump ha usato questi sentimenti diffusi per costruire il suo America First, che nel ritiro da questi conflitti trova un’espressione simbolica.
Dall’altro c’è la Comunità dell’intelligence e della Difesa che sostengono che il ritiro può esporre gli Usa a diverse tipologie di rischi. In Afghanistan il rischio riguarda la situazione con i Talebani, con cui è in corso un delicatissimo processo di pace che coinvolge sia Washington che Kabul (e con i ribelli che stanno tornando all’attacco su molti fronti e lo fanno anche come modo aggressivo per ottenere un vantaggio negoziale). In Iraq persiste il problema dell’Is, che con l’operazione Inherent Resolve a guida Usa è stato ridotto dalla dimensione territoriale a un’entità clandestina (che però può risorgere). In Siria si gioca una partita tattica del tutto simile, complicata dalla sovrapposizione di interesse strategici di attori amici ma competitivi, come la Turchia, e rivali come Russi e Iran (player centrale anche in Iraq).
Questo ultimo aspetto, gli equilibri tra tattica (con la lotta al terrorismo considerata una priorità di sicurezza nazionale) e strategia che si snodano anche in Somalia (altro ambito interessato dal ritiro del contingente Usa), è una delle dimensioni considerate più preoccupanti, dato che tra le forze in campo che potrebbero approfittate del generale disimpegno americano dall’area Mena c’è anche la Cina.
Il ritiro da certi teatri operativi rispecchia completamente le promesse e le visioni politiche di Trump, e contemporaneamente rientra in quelle decisioni con cui l’attuale amministrazione vuole lasciare il segno impresso sul futuro statunitense. Complicando la strada al successore. Ora per Joe Biden, che tra cinque giorni inaugurerà la sua presidenza, sarà molto complicato (soprattutto sul piano del consenso) prendere la decisione di aumentare nuovamente le truppe — ammesso volesse.