Secondo l’economista Fred Bergsten, per anni consulente della Casa Bianca, bisogna spingere Pechino a comportarsi da attore responsabile. Una nuova guerra fredda non è possibile, l’obiettivo è il “decoupling funzionale”: da una parte le questioni come Taiwan e gli uiguri, sulle quali non si cede terreno, dall’altra l’aspetto puramente economico
Fred Bergsten è senior fellow del Peterson Institute for International Economics, che ha diretto dalla sua fondazione nel 1981 fino al 2012. È stato vice-segretario al Tesoro, ha lavorato con Kissinger ed è stato consulente di molti presidenti americani. L’anno scorso ha pubblicato The United States vs China, un libro sul duello per la leadership economica, in cui si chiede: il conflitto tra la potenza egemone e quella rampante è inevitabile? La sua risposta è una conditional competitive cooperation, ovvero una cooperazione fatta di competizione e regole chiare, che la Cina spesso non ha rispettato (ma anche l’Occidente, come nel caso del Wto, non è esente da critiche).
Dall’uscita del libro, la Russia ha invaso l’Ucraina, Xi Jinping ha ottenuto il terzo mandato, Joe Biden ha portato a casa l’Inflation Reduction Act e un risultato migliore del previsto alle elezioni di metà mandato. Eppure i temi che lei solleva nel libro restano attuali: tra Usa e Cina c’è un clima da guerra fredda. Pechino è pronta a comportarsi da “attore responsabile” sul piano internazionale? Tra la gestione del Covid e l’”amicizia senza limiti” con Putin, sembrerebbe di no.
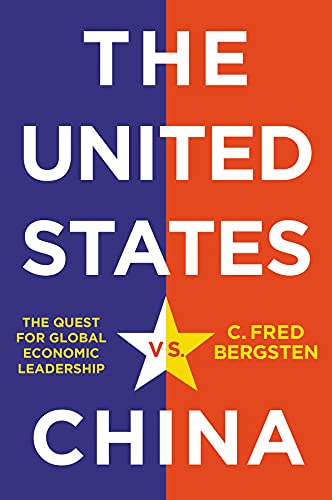 La Cina si è comportata da responsible stakeholder nel contesto della crisi finanziaria del 2008-09, agendo in coordinazione con le altre potenze del G20. In altre occasioni, soprattutto a livello commerciale, ha violato le regole. Il mio punto è che dobbiamo trovare un modo per convincerla a cooperare con il sistema liberale internazionale, da cui ha tratto enormi benefici finora. La Cina è troppo grande, dinamica e interconnessa per essere “contenuta” come l’Unione Sovietica del dopoguerra. Dunque serve non un decoupling totale ma un decoupling funzionale. Dobbiamo riconoscere che resteranno differenze significative sui temi di sicurezza e umanitari: Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, Hong Kong, gli uiguri. Su cui non solo non siamo d’accordo, ma ci metteremo di traverso. Eppure dobbiamo lavorare insieme su dossier come le nuove regole del commercio globale, il cambiamento climatico e le pandemie.
La Cina si è comportata da responsible stakeholder nel contesto della crisi finanziaria del 2008-09, agendo in coordinazione con le altre potenze del G20. In altre occasioni, soprattutto a livello commerciale, ha violato le regole. Il mio punto è che dobbiamo trovare un modo per convincerla a cooperare con il sistema liberale internazionale, da cui ha tratto enormi benefici finora. La Cina è troppo grande, dinamica e interconnessa per essere “contenuta” come l’Unione Sovietica del dopoguerra. Dunque serve non un decoupling totale ma un decoupling funzionale. Dobbiamo riconoscere che resteranno differenze significative sui temi di sicurezza e umanitari: Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, Hong Kong, gli uiguri. Su cui non solo non siamo d’accordo, ma ci metteremo di traverso. Eppure dobbiamo lavorare insieme su dossier come le nuove regole del commercio globale, il cambiamento climatico e le pandemie.
Con la nuova Strategia di sicurezza nazionale, Biden ha inasprito l’approccio alla Cina soprattutto nel settore tecnologico, con divieti alle esportazioni su microchip e tecnologie critiche come quantum computer, intelligenza artificiale, biotecnologie, in generale tutto ciò che può essere usato (anche) per scopi nefasti.
La Strategia conferma che bisogna distinguere i campi, tra ciò che è meramente economico e ciò che ha un risvolto di sicurezza. È giusto imporre limiti o anche embarghi su tecnologie che presentano una minaccia per l’Occidente. Non sarà facile tracciare una linea, mi pare che in questo momento si stia andando verso restrizioni troppo ampie. Credo che con il contributo europeo si potrà trovare un punto di equilibrio.
In questi giorni gli Stati Uniti hanno convinto Olanda e Giappone a unirsi alle restrizioni sull’export di semiconduttori. Come legge le mosse transatlantiche riguardo alla Cina?
L’unico modo che abbiamo per mantenere il nostro vantaggio tecnologico sulla Cina è migliorare le nostre performance nel campo dell’innovazione. Forse riusciremo a rallentare la corsa cinese, ma non a fermarla. L’unica strada sostenibile per restare competitivi è spendere di più in ricerca e sviluppo e sostenere le industrie avanzate. Gli Usa, sebbene in ritardo, lo hanno fatto con il Chips Act. Che però insieme all’Inflation Reduction Act crea qualche tensione con gli europei. Dobbiamo, e in questo includo l’Italia, creare programmi simili e coordinati, che non discriminano tra aziende che operano da questa o quella sponda dell’Atlantico, e spingerci fino al mettere in comune le nostre risorse. Evitare qualunque confronto tra noi mentre affrontiamo la sfida principale, che è la Cina. L’esempio è quello del sostegno all’Ucraina e il modo in cui l’amministrazione Biden è riuscita a coinvolgere gli alleati europei.
Cosa succederà a Taiwan? I legami commerciali con gli Usa sono sempre più forti, come testimonia la fabbrica Tsmc in Arizona da 40 miliardi di dollari, inaugurata da Biden, Morris Chang e Tim Cook. È un modo di creare una specie di deterrenza nucleare con Pechino? Il primo che interviene sull’isola rischia di far esplodere l’economia globale, con l’80% delle grandi navi container che passano per quel famigerato stretto.
Biden mantiene quella che viene chiamata ambiguità strategica su Taiwan, che oscilla tra l’impegno a difenderla militarmente e riconoscere la sua non piena indipendenza da Pechino. I toni si sono inaspriti ultimamente, per far capire ai cinesi che un tentativo di prendere l’isola con la forza troverebbe una risposta netta degli Usa. Questa deterrenza ha funzionato per 50 anni. La domanda ora è se Xi Jinping si senta più forte e sicuro di sé, tanto da pensare di farla franca in caso di invasione. Ma sarebbe un rischio terribile per il popolo cinese, la sua economia e l’economia globale. Il leader gioca con questa tensione, ma non sta funzionando, e se ne rendono conto sia in Cina che a Taiwan, dove l’interesse all’unificazione con la Cina continentale sta scemando. Continuerà a rosicchiare terreno (politico), fortificare atolli e agire in modo prepotente nel Mar Cinese Meridionale, ma non credo andrà oltre.
Torniamo in Europa. Abbiamo osservato Xi uscire dal Paese per la prima volta dopo mille giorni di Covid nelle settimane della Shanghai cooperation conference e del G20 indonesiano, durante il quale ha tenuto vari incontri bilaterali, incluso quello con Giorgia Meloni. È tornata la strategia divide et impera? Diversi approcci per diversi paesi europei, così da indebolire la risolutezza dell’Unione sia internamente sia nell’alleanza con gli Stati Uniti? L’atteggiamento europeo è cambiato molto negli ultimi tre anni: stop al Cai, l’accordo sugli investimenti; l’Italia che lascia nel cassetto il memorandum sulla Via della Seta firmato nel 2019; il governo tedesco che prepara una nuova strategia con Pechino, meno interdipendente.
Il divide et impera è sicuramente uno degli strumenti preferiti a Pechino. Si sentono in grado di affrontare alla pari gli Stati Uniti, come durante la guerra commerciale scatenata da Trump. Ma quando la Cina deve affrontare una coalizione multilaterale schierata contro, come sui temi del commercio, sul Wto o in modo più ampio alle Nazioni Unite con il caso ucraino, non ha alcuna intenzione di restare isolata. Per questo Europa e Stati Uniti dovrebbero darsi una mossa e adottare un approccio comune, che spinga la Cina a uniformarsi al sistema internazionale basato sulle regole. Serve una visione più sfumata, e gli europei in questo possono contribuire a stemperare la tensione con gli Usa, per responsabilizzare Pechino che ha tutto l’interesse a mantenere un’ economia globale aperta e stabile. Noi americani dovremo ammorbidire certe posizioni, voi europei dovrete irrigidirle, ma come lei ha detto, questo è un processo già intrapreso. Mi lasci aggiungere un ultimo elemento.
Prego.
Credo che la guerra in Ucraina sia la prova di un punto fondamentale: la Cina ha mostrato sostegno politico e retorico alla Russia per la sua invasione, ma ha fatto poco o nulla in termini di tangibile sostegno economico. I cinesi e le loro controparti commerciali hanno cooperato con i divieti all’export verso la Russia di tecnologie avanzate. Sanno che se le loro aziende violano queste sanzioni, saranno a loro volta colpite e il ruolo cinese nell’economia globale ne uscirebbe a pezzi. È un buon esempio di decoupling funzionale, un approccio pragmatico che potrà essere adottato anche nel nostro rapporto con la Cina.








