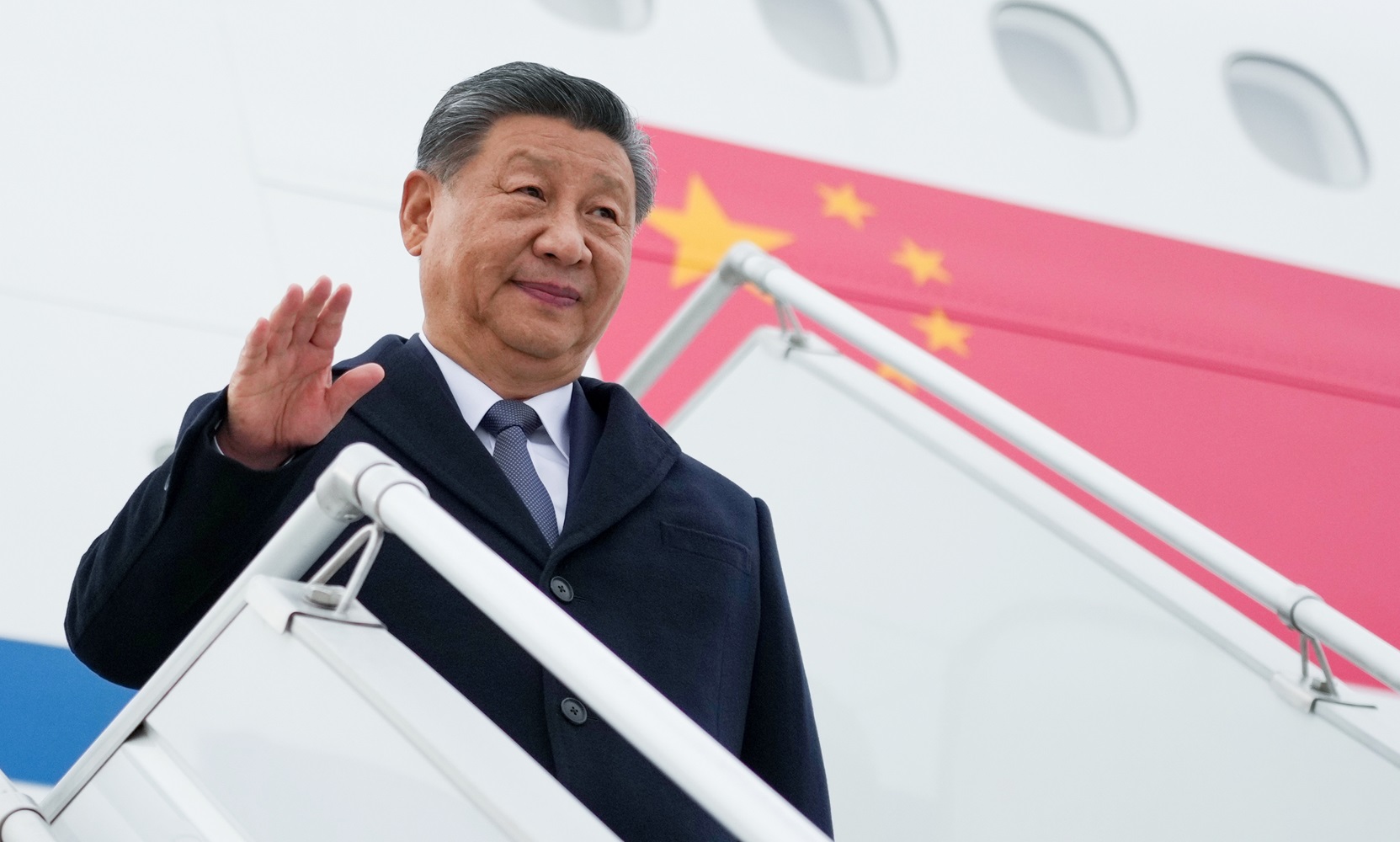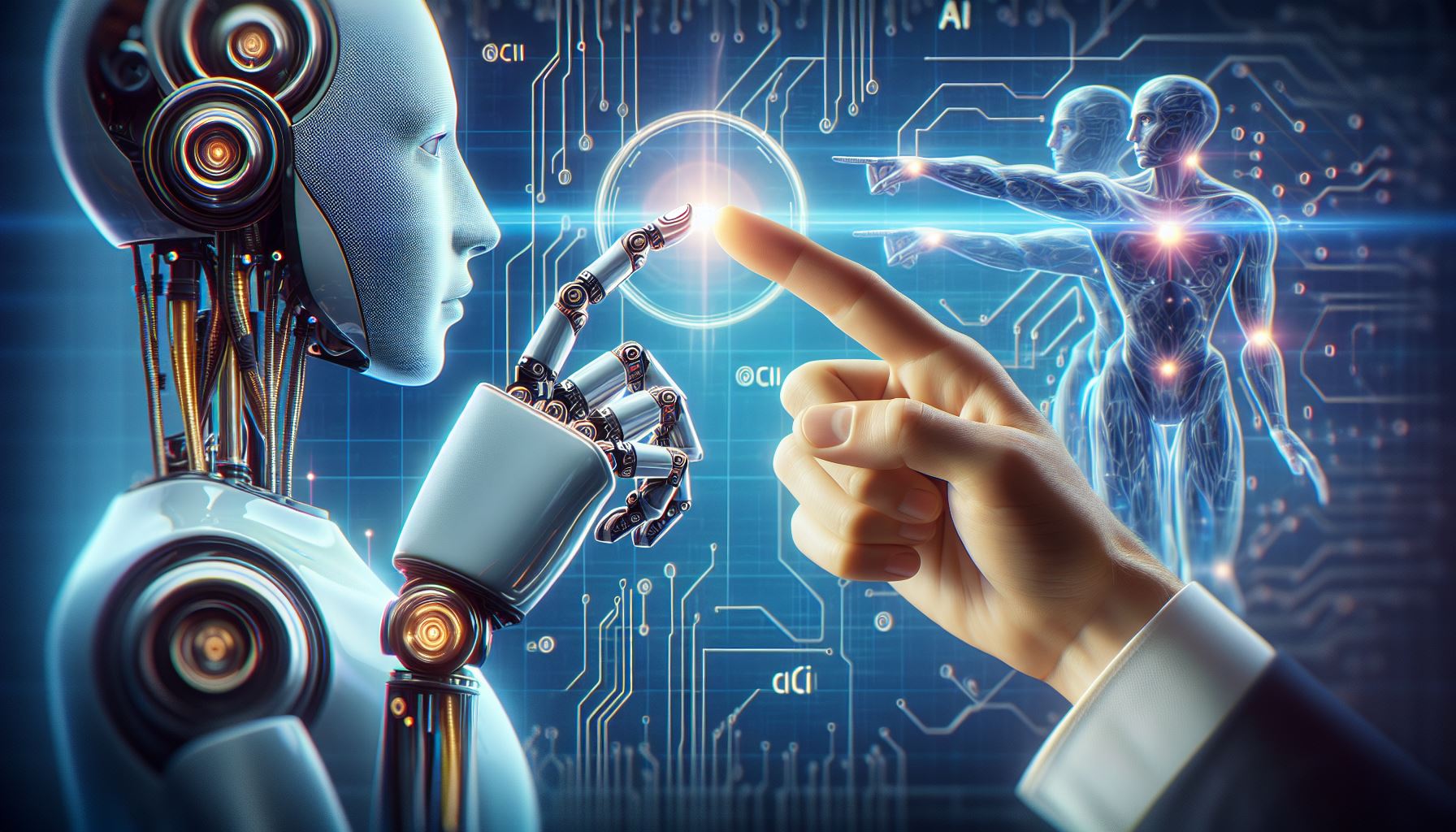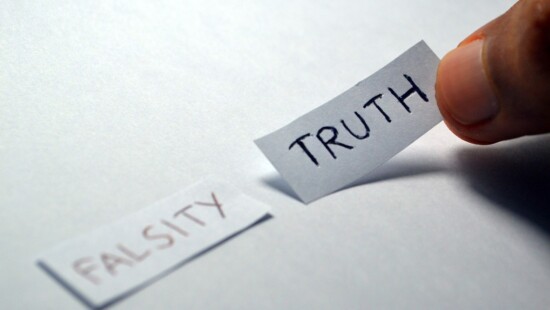Mentre il tempo e il crescente assedio dell’occidente giocano a sfavore, la situazione internazionale della Russia si fa sempre più precaria ed il Cremlino non riesce più a recuperare la perdita della credibilità negoziale che aveva in parte ritrovato dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca. L’analisi di Gianfranco D’Anna
Archivi
Tre anni di politica estera del governo Meloni. Risultati e obiettivi
Dalla nuova relazione con la Cina depurata della zavorra Via della Seta, al protagonismo in Ue e Nato; dalla special relationship con la Casa Bianca e l’Indopacifico, fino al Piano Mattei e alla centralità nella riunificazione balcanica, passando da aree mai battute prima come Asia centrale e America Latina. Che cosa ha fatto il governo Meloni sul piano internazionale
L'Ue deve proteggersi dalle misure cinesi sulle terre rare. I consigli di Gehrke (Ecfr)
Di fronte alla stretta cinese sulle terre rare, l’Ue deve reagire con fermezza. “È il momento di usare lo strumento anticoercizione o la coercizione economica diventerà la nuova normalità”, avverte Tobias Gehrke, senior policy fellow dell’Ecfr
Perché non si può parlare oggi di nuova Margherita. La riflessione di Merlo
Con la Margherita c’era un vero, credibile e trasparente progetto di centro sinistra. Perché c’erano un Centro riformista, autonomo, democratico e plurale alleato con una sinistra altrettanto democratica, riformista e di governo. Oggi il quadro politico è radicalmente cambiato. La riflessione di Giorgio Merlo
Dopo il cessate il fuoco, qual è il punto della situazione a Gaza? La versione di Mayer
Dopo due settimane il cessate il fuoco a Gaza tiene, ma il futuro resta incerto. La Turchia di Erdogan gioca un ruolo chiave ma ambiguo, sostenendo Hamas e cercando influenza nella Striscia. Egitto, Israele e Arabia Saudita vogliono contenerla. Gli Usa guidano la mediazione, mentre cresce l’attesa per il nuovo Centro di Coordinamento su Gaza
Il peso cinese sull’economia europea. La versione di Pettis e Fardella
Il problema europeo degli investimenti va analizzato all’interno di un contesto globale dominato dalla strategia economica di Cina e Stati Uniti. Se le quote manifatturiere di Pechino e Washington crescono, inevitabilmente quelle europee devono ridursi. L’analisi di Micheal Pettis, senior fellow presso il Carnegie endowment for international peace, ed Enrico Fardella, Associate Professor del Department of Social and Human Sciences all’Università di Napoli ‘L’Orientale’ e Adjunct Professor alla School of Advanced International Studies (SAIS) Europe della Johns Hopkins University
Usa e Ue unite, solo così per Meloni si ferma la guerra in Ucraina
Il tema delle armi a lungo raggio è stato al centro del vertice londinese in cui la Gran Bretagna si è impegnata a consegnare all’Ucraina altri missili entro l’inverno e la Francia a mandare altri caccia Mirage. Secondo Bloomberg Roma potrebbe inviare, tramite il dodicesimo pacchetto di aiuti militari, i sistemi di difesa aerea SAMP /T
Chi è Ksenija Sobchak, l’influencer pro-Putin che si aggira per l’Europa
Presentatrice ed influencer, la “Paris Hilton russa” è vista con molto sospetto dall’opposizione. Avrebbe ottenuto un visto da nomade digitale per lavorare dalla Spagna
Vite artificiali e corpi smontabili. Politica e diritto di fronte alla non-vita tecnologica
L’analisi dell’impatto delle tecnologie dell’informazione sul concetto politico di identità e le conseguenze della trasformazione dell’individuo da “chi” a “cosa” è il tema affrontato dal volume “Lost in the Shell. Mind, body, identity and the the technology of information”, a firma di Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cybersecurity nell’università di Roma-Sapienza, ed edito da Routledge Books. Ne pubblichiamo un estratto
Democrazie sotto attacco cognitivo. La sicurezza epistemica secondo Demos
L’erosione della “sicurezza epistemica”, la capacità collettiva di distinguere il reale dal manipolato, sta svuotando di sostanza istituzioni e cittadini, rappresentando la minaccia più insidiosa per le democrazie liberali. Il report del think tank britannico da tempo impegnato nell’analisi del rapporto tra informazione e democrazia, firmato da Eliot Higgins (fondatore di Bellingcat) e Natalie Martin