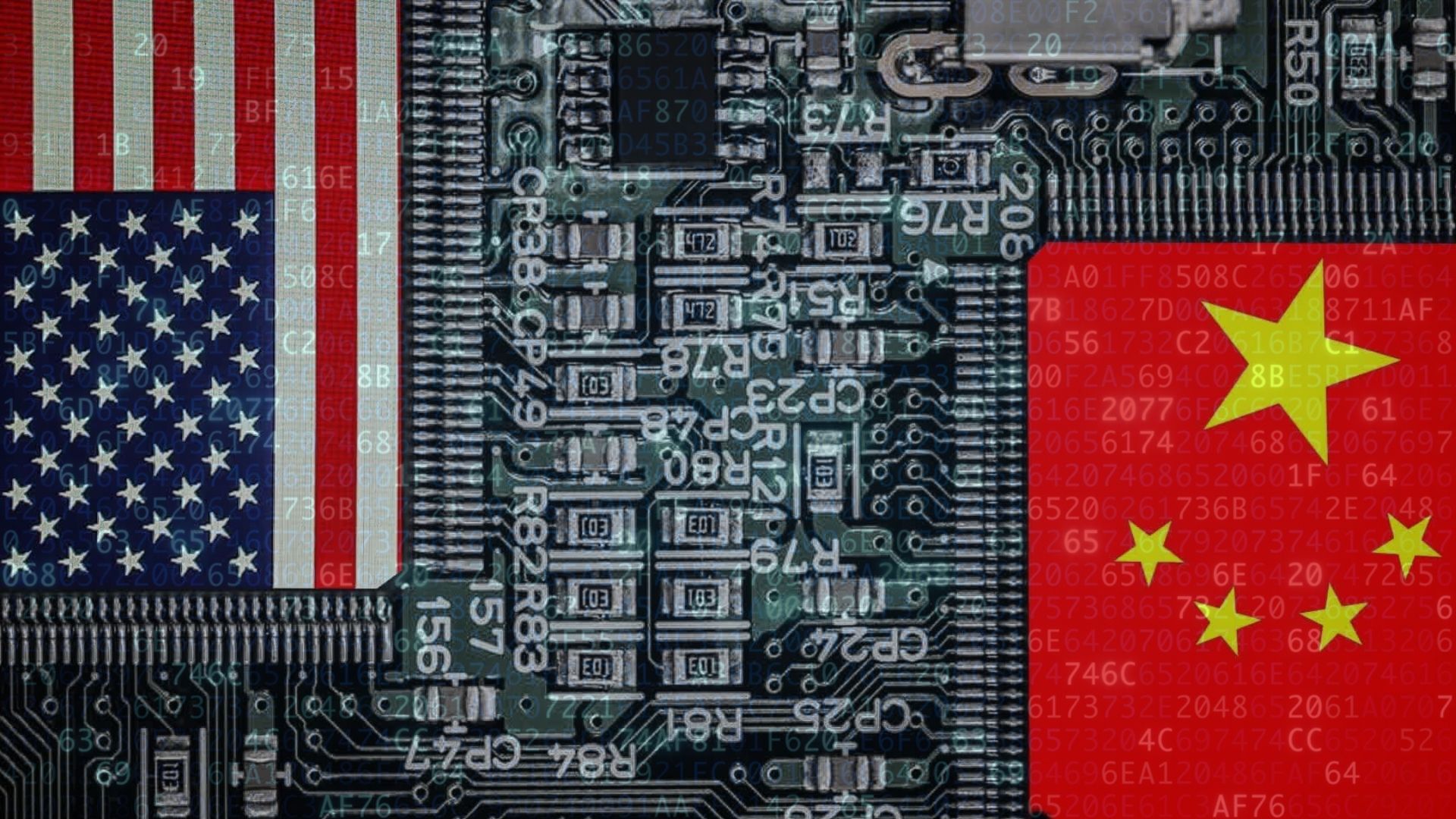Il percorso di affrancamento dell’Occidente dai fornitori cinesi e russi nella nuova guerra fredda tech sarà costoso e non senza rischi. Dalla pressione sui prezzi dei prodotti finali, sino all’aspra competizione per le materie prime, in un contesto di tensioni geopolitiche destinato a perdurare
Se c’è un’industria che più di tutti ha beneficiato dell’intensa globalizzazione intercorsa negli ultimi decenni, questa è sicuramente quella dei semiconduttori. La complessità del processo di design, fabbricazione, assemblaggio e di reperimento dei materiali (gas, metalli rari, attrezzature per l’etching) rappresenta un esempio classico di segmentazione della catena del valore, nella quale ogni attore – dalle foundry fino ai fornitori di software e prodotti chimici – ha puntato sulla specializzazione del proprio business, garantendo ricavi, abbattimento dei costi, reinvestimento in R&D e spingendo così la frontiera tecnologica fino a oggi.
Il tutto avvenuto grazie a investimenti esteri, trasferimento tecnologico, condivisione di know-how seppur la storia della più importante tecnologia esistente abbia attraversato diverse fasi discontinue, tra protezionismo e politiche industriali più o meno offensive ed efficaci, come mostra abilmente nel suo capolavoro Chris Miller.
Seppur questo processo sia avvenuto con un beneficio economico, ovvero la massificazione del comparto dell’elettronica di consumo, oggi la graduale penetrazione di tecnologie dual-use (AI, 5G, IoT) rende l’accesso ai microprocessori più avanzati la tecnologia la chiave per gli equilibri di potere del XXI secolo. E su cui, ormai senza dubbio, Stati Uniti e Cina e i paesi chiave della catena del valore (Taiwan, Corea del Sud, Giappone e in una certa misura l’Europa) vengono trascinati in una riedizione, 4.0, di alcune dinamiche della guerra fredda.
Spesso avventurarsi nelle analogie è un terreno scivoloso, soprattutto se il paragone si spinge ad equiparare paesi come l’Unione Sovietica e l’attuale Repubblica Popolare cinese in diretta competizione con gli Stati Uniti. Ma se guardiamo alle ultime mosse dell’amministrazione Biden, impegnata a rallentare il processo di “indigenizzazione tecnologica” della Cina nel comparto dei chip, qualcosa torna alla mente. In un articolo su Foreign Policy, si ritiene che il nuovo pacchetto di misure (export control) volto a bloccare vendita e utilizzo di know-how americano ai produttori cinesi (soprattutto SME – semicondoctor manufacturing equipment) si stia rivelando come una “quasi strategia del contenimento”, per bloccarne non l’espansionismo territoriale, come fu ai tempi quello sovietico in chiave politica, ma quello tecnologico. Si tratterebbe, a tutti gli effetti, di una “forma di contenimento economico” nei settori ritenuti cruciali per la sicurezza nazionale statunitense (su tutti, l’intelligenza artificiale).
Una chiave di lettura che sarebbe confermata dalle parole di Alan Estevez, sottosegretario al dipartimento del Commercio per Industria e sicurezza, in un incontro organizzato dal Center for a New American Security: “Non si tratta di distruggere economicamente la Cina […] ma soltanto di sicurezza nazionale”. E ancora: “Non bilanciamo la sicurezza nazionale contro le perdite commerciali americane”.
Gli investimenti massicci del governo americano con lo US Chips and Science Act per riportare a casa parte della produzione di chip, soprattutto quelli leading edge e concentrati nelle mani di Tsmc a Taiwan, rendono comunque la mossa parte di una strategia più ampia di decoupling, volto a cautelare la propria sicurezza e al contempo a danneggiare, con le sanzioni, quella cinese.
Quello che non è ancora chiaro è fino a che punto le agenzie federali si spingeranno in questa offensiva legale sul fronte tecnologico. Secondo un rapporto del Rhodium Group, il nuovo pacchetto di sanzioni sarebbe già “ampio e completo”, con costi contenuti per i player americani seppur il settore dei memory chip, su eccellono le coreane SK Hynix e Samsung, potrebbe essere il più impattato. L’amministrazione statunitense sembrerebbe convinta di proseguire con sanzioni unilaterali, valutando costi economici e diplomatici inferiori ai benefici geopolitici nei confronti del rivale cinese. Tuttavia, il rischio che fornitori europei e asiatici non siano pronti a scegliere da che parte stare nella “cortina di silicio” se gli Stati Uniti dovessero estendere il pacchetto sarebbe alto.
Come riporta il Financial Times, in una call con gli investitori l’azienda SK Hynix ha annunciato la preparazione di piani di emergenza per una possibile “situazione estrema” in cui le restrizioni imposte da Washington metterebbero in difficoltà operativa la foundry di chip localizzata in Cina, obbligandola a rimpatriare la produzione. Con evidenti ricadute sulla filiera, perché la sicurezza ha un costo. Secondo Goldman Sachs, la spesa in capitale tra un’attività produttiva negli Stati Uniti e una a Taiwan potrebbe essere del 44% più alta. In Europa, scommettiamo, potrebbe essere addirittura superiore considerando gli alti costi dell’energia, dal momento che produrre in scala i semiconduttori è un’attività fortemente energivora.
E Pechino resterebbe a guardare nell’ipotesi di un ulteriore escalation della guerra tecnologica? Seppur le opzioni ritorsive in mano alla Cina nel settore dei semiconduttori siano limitate, così come appare ancora asimmetrica qualunque risposta se confrontata con la profonda presa delle agenzie federali statunitensi, la risposta potrebbe riguardare il possesso e il controllo sulle filiere delle materie prime critiche, tra cui le terre rare. A parere di chi scrive, quest’ipotesi tanto sventolata anche durante la guerra commerciale con Trump è priva di fondamento: per volume delle esportazioni, perché la dipendenza da Pechino è sui prodotti a valore aggiunto nelle filiere delle rinnovabili. Una mossa simile potremmo aspettarcela da Mosca che ha fatto ampio uso delle commodity come arta di ritorsione strategica (dal gas neon al palladio, fino alle forniture di gas).
La strumentalizzazione delle materie prime avrebbe effetti inflazionistici e ricadute negative su tutto il comparto a valle, difficilmente contenibili sui mercati regionali di riferimento. La Cina non ha interesse nel fare leva sul suo controllo upstream come arma di ricatto: è la stessa struttura del suo mercato domestico e della politica industriale a incentivare la penetrazione delle sue tecnologie nei mercati di sbocco esteri. Ed è questo il trend che allarma i policymaker occidentali.
Il decoupling dalle filiere delle materie prime critiche sarà un processo parimenti lungo e costoso. Sostenere una re-industrializzazione per riprendere il controllo produttivo – non regolatorio – del Green Deal già vede una mancanza di coordinamento tra Stati Uniti e Unione europea e sui cui è cruciale intervenire. Secondo un rapporto di Bnef, riportare in casa impianti per la fabbricazione di batterie, pannelli fotovoltaici ed elettrolizzatori (idrogeno) entro il 2030, e così cautelarsi dai rischi geopolitici e climatici, potrebbe costare 149 miliardi di euro all’Europa e 113 miliardi agli americani.
Se l’obiettivo è evitare di essere sommersi dalle rinnovabili cinesi, per cavalcare l’onda della transizione energetica per posti di lavoro, know-how scientifico e produttivo, dovremo tenere conto dei rischi e dei costi, politici ed economici, che questo comporterà. Da una maggiore domanda aggregata di materie prime su cui dovremo garantirci adeguate forniture da paesi terzi, a una competizione serrata con i produttori cinesi che vantano già decenni di esperienza e programmazione industriale.
Difficoltà che aumenteranno in un clima geopolitico sempre più teso è che vede sfumare un mondo in cui il libero commercio è dato per scontato, sempre più striato e influenzato dagli equilibri tecnologici.