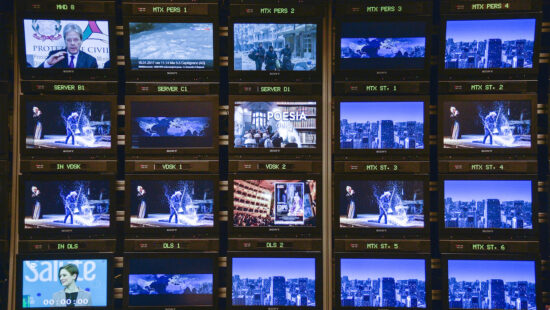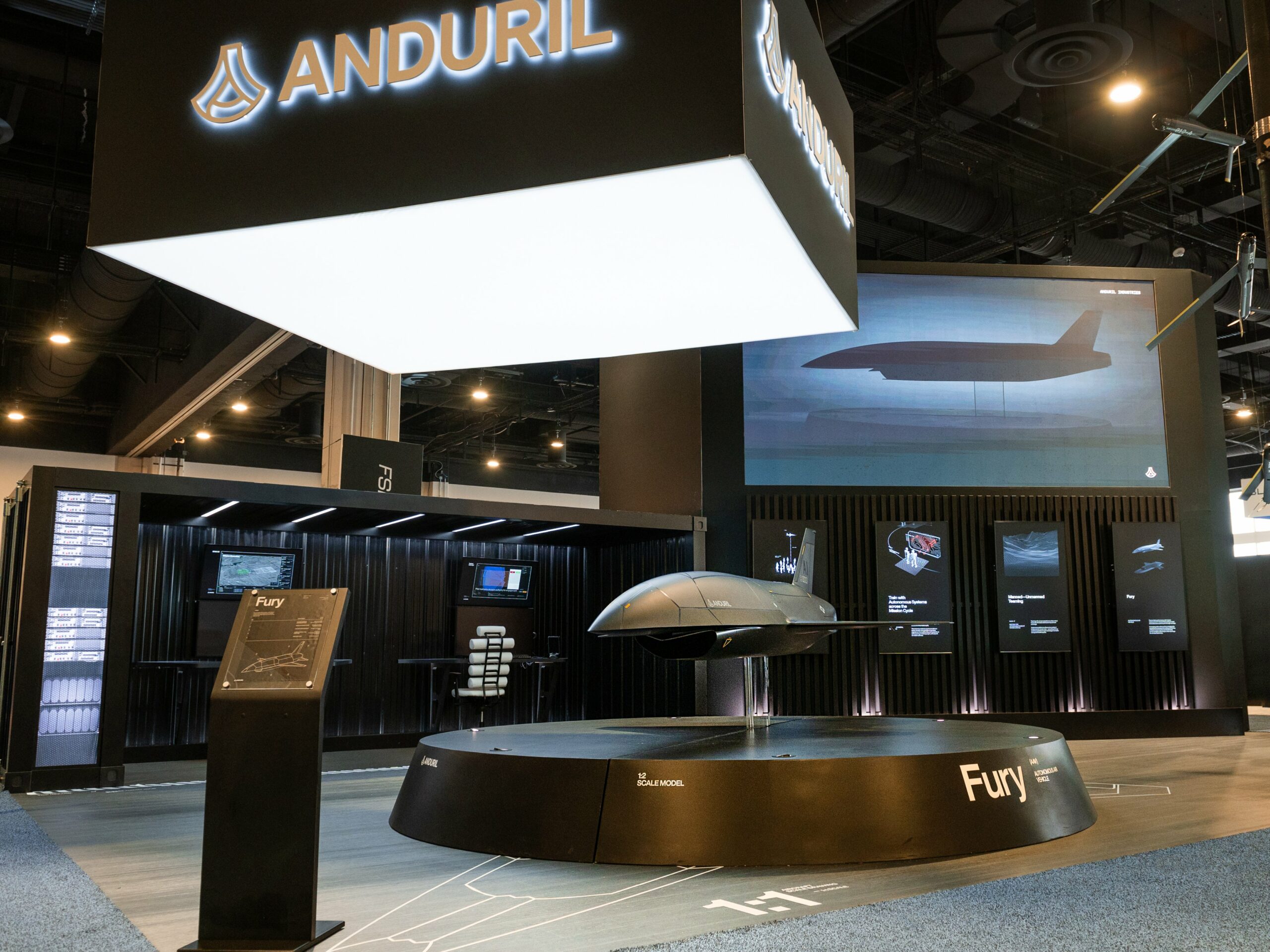C’è un passaggio altamente significativo, fra gli altri, nell’intervista che la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, intervenuta a Roma al gala di Formiche ha concesso a Formiche.net. Ed è la visione progettuale agganciata all’orgoglio europeo. Una sorta di rivendicazione valoriale, geopolitica e anche pragmatica perché tarata sulle esigenze dei cittadini prima che sulle traiettorie politiche. “Io e Giorgia Meloni proveniamo da tradizioni politiche diverse, ma condividiamo lo stesso obiettivo: fare in modo che l’Europa funzioni per tutti”, ha spiegato. Una conversazione ampia e strutturata, che tocca tutte le sfide dinanzi all’Ue, come guerre, Indo Pacifico, Mediterraneo, Balcani, rapporto con gli Usa e ruolo dell’Italia, minimo comun denominatore in tutti i temi in questione.
(TUTTE LE FOTO DI ROBERTA METSOLA AL FORMICHE EUROPEAN GALA)
Nell’ultimo decennio l’euroscetticismo ha basato la propria narrazione sulle deficienze strutturali dell’Ue: in che modo il suo operato – e il costruttivo rapporto che esiste fra lei e Giorgia Meloni – stanno favorendo un nuovo ruolo per il Parlamento europeo, finalmente visto come istituzione realmente vicina ai bisogni dei cittadini?
L’Europa è spesso percepita come troppo burocratica, troppo lenta e capace di produrre regole infinite e senza anima, a prescindere dalle sue buone intenzioni. Ma l’Europa ha un’anima: è il Parlamento europeo, l’istituzione eletta direttamente dai cittadini, che sente subito quando le cose non funzionano e lavora per correggerle. Abbandonare oggi il nostro progetto significherebbe sacrificare il futuro dei cittadini europei. È vero: abbiamo commesso errori. Ma i cittadini europei sanno che l’unità fa la forza: due terzi di loro chiedono una difesa comune e un’Europa che parli con una sola voce. È arrivato il momento di ascoltarli. Il Parlamento europeo ha dimostrato che è possibile cambiare. Grazie a coraggiose riforme, abbiamo modernizzato i nostri metodi di lavoro, reso i processi più rapidi, efficienti e agili. In poche settimane siamo passati dall’ambizione all’azione. Questo dimostra che quando istituzioni e cittadini lavorano insieme, l’Europa può agire con decisione. L’Italia è un grande Paese, qui mi sento a casa. Lavoro molto bene con tutti i colleghi eurodeputati italiani al Parlamento europeo. Io e Giorgia Meloni proveniamo da tradizioni politiche diverse, ma condividiamo lo stesso obiettivo: fare in modo che l’Europa funzioni per tutti. Negli ultimi anni ho avuto modo di conoscerla: è tenace e leale, e come madri impegnate in politica spesso troviamo punti in comune, sia nella vita quotidiana che nel lavoro. Ripartiamo dall’orgoglio europeo: semplifichiamo le regole, investiamo nella digitalizzazione, favoriamo la reindustrializzazione, rafforziamo i legami transatlantici e completiamo la casa europea. Solo così l’Europa potrà proteggere i cittadini, garantire crescita e sicurezza, e offrire un futuro concreto alle generazioni che verranno.
Come sta procedendo la riunificazione balcanica, in un’area dove l’Italia può fungere da pivot in chiave allargamento? Ovvero quali Paesi sono pronti ad entrare già ora secondo lei in Ue e quali restano in lista d’attesa?
L’allargamento è uno degli strumenti più forti dell’Europa per la pace, la stabilità e il suo ruolo strategico internazionale. È un investimento a lungo termine nel futuro dei Balcani e dell’Europa stessa, e l’Italia lo ha sempre compreso appieno. I Balcani occidentali hanno compiuto progressi concreti nel loro percorso europeo, e l’Ue li sostiene con strumenti come il Reform and Growth Facility da 6 miliardi di euro, che aiuta i partner ad allinearsi agli standard europei e a costruire economie più solide e resilienti. Non esiste un percorso unico verso l’adesione: ogni Paese avanza secondo il proprio merito e l’impegno nelle riforme. Ciò che conta è che il processo resti equo, credibile e orientato ai risultati, e che la porta dell’Europa rimanga aperta per chi guarda a noi come al proprio futuro. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso più membri di quanti nuovi Paesi siano entrati nell’Unione, e se non agiamo, altri lo faranno al nostro posto. L’allargamento non è un atto di carità: è uno strumento strategico e geopolitico nell’interesse stesso dell’Europa, che deve garantire ai Balcani un percorso chiaro e credibile. Allo stesso tempo, l’Europa deve guardare anche a sé stessa. Il Parlamento europeo ha elaborato una testo sulle riforme necessarie per prepararsi all’allargamento, ed è tempo che tutti prendano questo seriamente. Ciò che funzionava per un’Ue a 27 potrebbe non essere sufficiente per un’Ue a 33 o 35, e dobbiamo adeguare le nostre istituzioni e politiche a questa nuova realtà.
In un momento caratterizzato dalla nuova e insidiosa turbolenza nel Sahel, accanto a focolai di crisi mai sopiti come la crisi che da due anni flagella il Sudan, in che misura il Piano Mattei, lanciato dal governo italiano, può portare buoni frutti, a maggior ragione se intrecciato con il Global Gateway? Guardando a sud, da Gibilterra al Bosforo: qual è la visione europea per il Mediterraneo di domani?
Il Mediterraneo è stato troppo spesso percepito da alcuni come l’anello debole dell’Europa, ma oggi non potrebbe esserci nulla di più lontano dalla realtà. Il Piano Mattei dimostra come possiamo trasformarlo in un’area di vero progresso, puntando su una cooperazione con i Paesi africani basata su uguaglianza, investimenti e benefici reciproci, non dipendenza. Il nuovo Patto per il Mediterraneo dell’Ue segue lo stesso approccio e lo estende a un numero maggiore di partner. Il Mediterraneo è pieno di opportunità. Il Sud Europa sta plasmando il futuro, guidando la via nella creatività, nella tecnologia e nell’innovazione. I Paesi del Sud Europa sono il ponte naturale dell’Europa verso il Sud globale – per geografia, storia e cultura. L’Italia, con la sua visione e la sua esperienza uniche, è particolarmente ben posizionata per collegare l’Europa con l’Africa e il Medio Oriente. Ma la credibilità dell’Europa dipende da come collabora con i propri vicini. Dobbiamo fidarci del Sud Europa, lasciargli prendere l’iniziativa, dialogare con gli altri e ottenere risultati. Solo così costruiremo un’Europa più forte, aperta al mondo, sicura di sé e pronta a plasmare il futuro.
Nella guerra in Ucraina si sono manifestate sovente posizioni diverse in Ue, forse orientate da chi vorrebbe creare un solco tra Stati Uniti ed Europa: in che misura il ruolo dell’Italia e di Giorgia Meloni possono rappresentare un ponte nelle relazioni transatlantiche tra le due sponde dell’Atlantico, con l’obiettivo di rafforzare questa unità? Come immagina l’evoluzione del rapporto Ue-Usa in questo nuovo contesto internazionale? Quali sfide e opportunità si presentano per la Ue dal punto di vista politico, economico e di sicurezza?
Sì, esistono differenze di approccio tra gli Stati membri, ma nel complesso l’Ue ha mostrato fin dall’inizio un’unità straordinaria sulla Russia – qualcosa che, prima della guerra, non avrei mai pensato possibile. Questa coesione ci ha permesso di sostenere l’Ucraina in ogni modo: militarmente, economicamente, politicamente e con aiuti umanitari, riducendo al contempo la nostra dipendenza dall’energia russa. Abbiamo recentemente adottato il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include il divieto di importazione di gas naturale liquefatto russo. Il Parlamento europeo ha inoltre approvato il divieto totale delle importazioni di petrolio e gas dalla Russia. Queste misure, allineate a quelle degli Stati Uniti, testimoniano la forza della nostra cooperazione transatlantica. L’Italia, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al ministro degli esteri Antonio Tajani, ha avuto un ruolo centrale in questo percorso, sostenendo l’Ucraina e contribuendo a mantenere solide le relazioni Ue–Usa. Sono appena tornata da Washington, dove ho avuto ottimi colloqui su come rafforzare il partenariato transatlantico. Il nostro legame con gli Stati Uniti va oltre la storia o la geografia: condividiamo le stesse sfide in materia di sicurezza, commercio e democrazia, e dobbiamo affrontarle insieme. Ue e Stati Uniti sono reciprocamente i principali partner economici, con scambi per 1,6 trilioni di euro all’anno. L’accordo commerciale raggiunto quest’estate ha già creato nuove opportunità per le imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico. È un passo importante, ma resta ancora molto da fare, e sono fiduciosa che, lavorando insieme, ci riusciremo. L’Italia può continuare a giocare un ruolo chiave nel rafforzare l’unità europea e la cooperazione transatlantica, contribuendo a costruire un futuro più sicuro, più forte e più prospero per tutti.
Le nuove economie, che emergenti ormai non sono più, come quelle che si affacciano sull’Indo-Pacifico, possono rappresentare per l’Ue una ghiotta opportunità di sviluppo per il futuro. Come si sta approcciando l’Europa verso due temi rilevanti come il Mercosur e le relazioni con l’India?
L’Ue è già un gigante del commercio globale. Siamo il più grande blocco commerciale al mondo, un continente a tariffe zero, e dobbiamo continuare a rafforzare questa posizione. L’Europa deve restare un leader nell’esportazione di beni, servizi e idee, per sostenere la nostra economia e la competitività a lungo termine. Il nostro approccio al commercio segue la stessa logica che guida ogni altra azione: deve produrre benefici concreti per i cittadini europei e incidere positivamente sulla loro vita quotidiana. Abbiamo già firmato oltre 40 accordi commerciali con più di 70 Paesi e regioni, e circa 20 sono in fase di negoziazione. Gli accordi con Mercosur e Messico sono ormai prossimi, e il Parlamento si esprimerà a breve. L’India è un altro partner chiave, e stiamo lavorando per approfondire ulteriormente la nostra cooperazione. Il Parlamento europeo esaminerà con grande attenzione gli accordi in discussione, per assicurarsi che offrano risultati reali per cittadini e imprese. L’Ue sostiene il commercio aperto, equo e basato su regole, a beneficio di tutti. Promuovendo un commercio responsabile e strategico, possiamo rafforzare il ruolo dell’Europa nel mondo, creando al tempo stesso benefici tangibili in patria. Continueremo a sostenere un commercio aperto e leale, ma la nostra priorità sarà sempre proteggere i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, i nostri consumatori le nostre comunità. Difenderemo sempre i nostri standard, la nostra qualità, il nostro modo europeo di fare le cose. Perché è questo che rende l’Europa, l’Europa. E ne siamo orgogliosi.
IL VIDEO DEL FORMICHE EUROPEAN GALA 2025