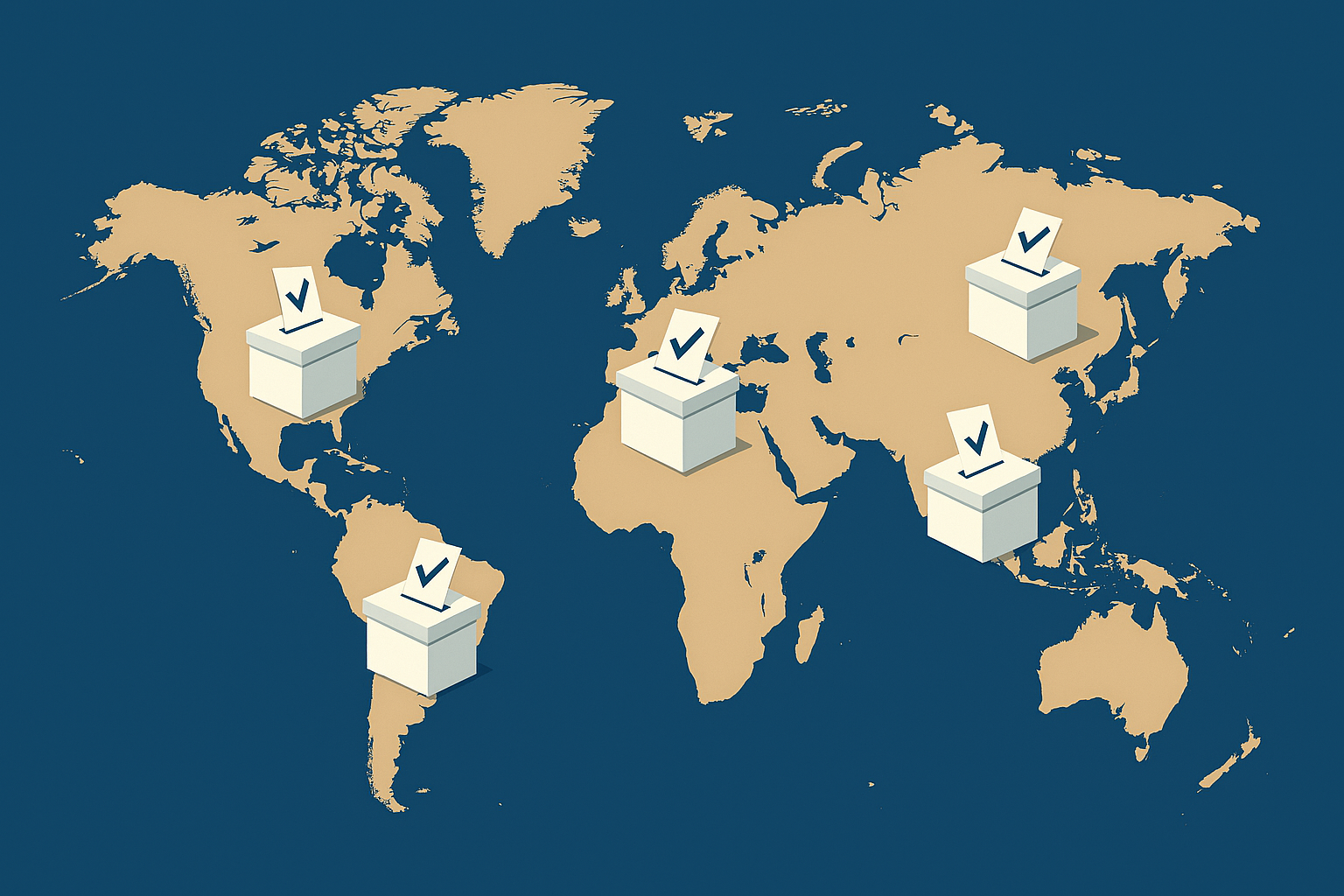L’operazione, compiuta la scorsa settimana, è stata confermata dal presidente Trump. Non ci sono dettagli sulla proprietà dei droni e il coinvolgimento delle forze armate americane, ma l’attacco farebbe parte della campagna contro il narcotraffico regionale e la pressione contro il regime venezuelano. Altri droni MQ-9 Reaper, con missili Hellfire, sono a Puerto Rico
Archivi
Emirati fuori dallo Yemen. Così cambia la partita nel Golfo
Il ritiro delle truppe emiratine dallo Yemen segna una svolta nelle relazioni con l’Arabia Saudita. La crisi mette in luce una profonda divergenza strategica tra due alleati storici e rischia di aprire una fase di maggiore instabilità nel conflitto yemenita
Taiwan come destino. Xi alza il tono, Pechino stringe il cerchio
Nel discorso di fine anno, Xi Jinping ribadisce che la riunificazione con Taiwan è “inevitabile”, mentre l’Esercito popolare di liberazione testa sul campo l’opzione militare. Tra retorica storica, muscoli e tecnologia, Pechino manda un messaggio diretto a Washington e all’isola
Ecco la Dottrina Donroe degli Usa nell’Indo-Pacifico
Nel 2025 la politica statunitense nell’Indo-Pacifico si è mossa secondo una logica sempre più funzionale e selettiva, riconducibile alla cosiddetta “Donroe Doctrine”: controllo degli spazi strategici, uso mirato di partner e strumenti economici, riduzione degli impegni politici vincolanti. Dalla riallocazione dell’assistenza estera alle ambiguità del Quad e alla gestione prudente del dossier Taiwan, emerge un approccio orientato alla gestione della competizione con la Cina più che alla costruzione di un nuovo ordine regionale
Nel mondo ci sono sempre meno armi nucleari, eppure stanno aumentando. Ecco perché
A dispetto della riduzione in termini assoluti, il 2025 ha confermato l’aumento del numero di testate nucleari operative nel mondo. Si tratta di circa 9mila ordigni, ma il loro numero risulta in aumento. Nel frattempo, mentre i trattati sul disarmo vengono lasciati scadere senza rinnovo, aumentano i fattori geopolitici che suggeriscono un aumento della tendenza anche nel resto del mondo
Fincantieri rafforza il legame con l’India nella difesa navale
La cooperazione industriale tra Italia e India compie un passo avanti nel navale militare. Fincantieri, tramite WASS, ha ottenuto una commessa da oltre 200 milioni per la fornitura di siluri pesanti alla Marina indiana. La produzione avverrà in Italia, con consegne tra 2028 e 2030, rafforzando la presenza del gruppo in un mercato strategico e confermando il valore delle tecnologie subacquee italiane
Chi resiste, chi avanza e chi rischia nel 2026. Le pagelle politiche 2025 di Carone
Come si chiude l’anno appena trascorso per i politici italiani? Dalla segretaria del Partito democratico insidiata dal leader del Movimento 5 Stelle alla presidente del Consiglio equilibrista tra necessità di alleanza e di governo, per non dimenticare i piccoli partiti ago della bilancia. Ecco le pagelle di Martina Carone
Depositi Hi-Tech, ma non solo. Come l’IA sta riscrivendo la logistica militare cinese
Dalla consapevolezza continua delle scorte alla distribuzione unmanned sul campo, la Pla sta sperimentando un nuovo modello logistico data-driven. Una trasformazione che rafforza la capacità di sostenere conflitti ad alta intensità, con impatti sostanziali sugli equilibri di forza nel settore dell’Indo-Pacifico
Elezioni 2026 nel mondo. Tutti i Paesi al voto e le sfide che cambieranno gli equilibri globali
Dalle prime elezioni generali del Sud Sudan al voto del midterm negli Stati Uniti, passando per le legislative che sono un referendum per Netanyahu in Israele e le presidenziali in Costa Rica (con 20 candidati). Questo anno nuovo sarà fitto di voti in tutto il mondo…
Il dramma estero dell'opposizione (che non scalfisce il governo). Scrive Sisci
Meloni mantiene la rotta atlantica ed europea, mentre Pd e M5S restano divisi su Russia, Palestina e rapporti con Washington. Questa ambiguità paralizza l’opposizione e lascia il governo senza veri avversari sul piano internazionale. L’analisi di Francesco Sisci