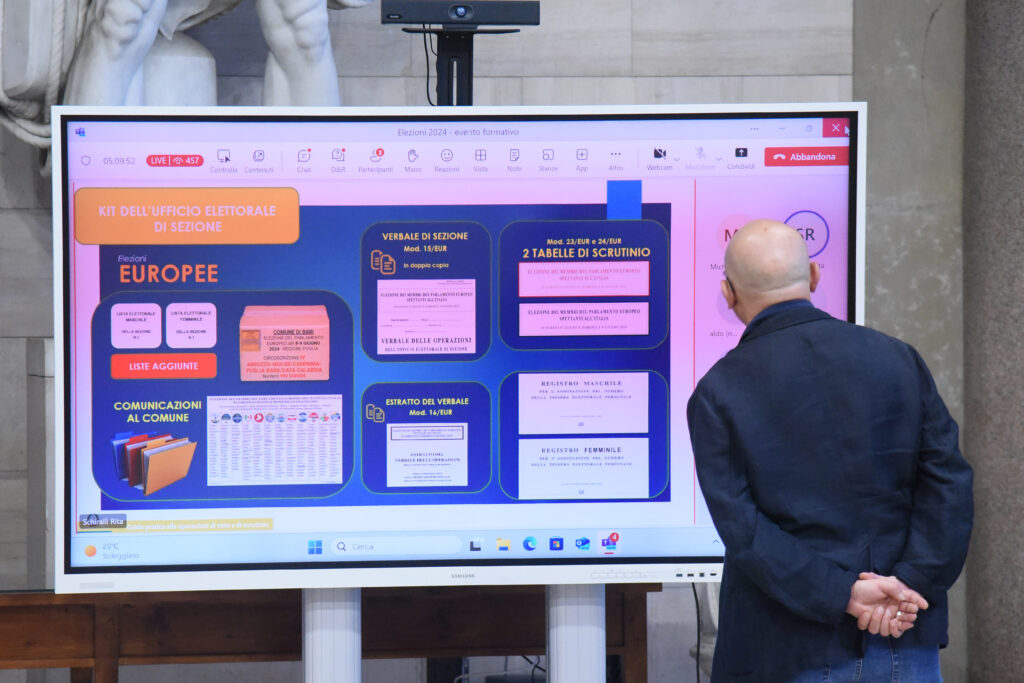A campagna elettorale finita è tempo di interrogarsi su politica e comunicazione. Abbiamo assistito a esperimenti che raccontano le difficoltà di attirare l’attenzione di coloro che abitano piattaforme. L’analisi di Christian Ruggiero (Università Sapienza di Roma)
Un’altra campagna elettorale è giunta al termine ed è il momento di interrogarsi nuovamente su quelle che possono essere considerate le promesse mancate da parte della politica e della comunicazione verso i cittadini – ma anche gli studiosi. Si tratta, infatti, di un esercizio utile tanto dal punto di vista civile quanto da quello scientifico, che consente all’elettore di esercitare la propria memoria e al ricercatore di porre le basi per un’indagine longitudinale. Non stiamo parlando delle promesse elettorali in senso stretto, ma degli obiettivi più ampi che ogni chiamata al voto porta con sé.
Essendo una campagna europea, questa del 2024 rimanda a un interrogativo ormai classico per le scienze politiche, sociali e della comunicazione: riuscirà questo tipo di appuntamento a svincolarsi dalla dimensione della second order election – termine coniato proprio per le prime europee, quelle del 1979 –, ad assumere, per rilevanza nell’agenda della politica e dei cittadini, un ruolo proprio, svincolato da quello della politica nazionale? Si tratta di un interrogativo reso ancor più attuale dal quasi ventennale dell’uscita del masterpiece di Carlo Marletti e Jean Mouchon su La costruzione mediatica dell’Europa (edito da FrancoAngeli nel 2005), celebrato a Catania in occasione del convegno annuale dell’Associazione italiana di comunicazione politica. E la risposta, purtroppo, sembra essere ancora una volta “no”. Chi scrive ha presentato, con Mauro Bomba e Matteo Maiorano, al convegno AssoComPol un’analisi basata sulle prime due settimane di campagna elettorale, che trova facile conferma nel prosieguo del mese di avvicinamento alle urne. Secondo i nostri dati, l’agenda del mainstream televisivo – segnatamente, dei titoli dei sette telegiornali di prima serata, oggetto di monitoraggio dell’Osservatorio TG del dipartimento CoRiS della Sapienza e della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi” – è rimasta largamente ancorata ai macro-temi di cronaca, politica e società e cultura, dedicando allo specifico delle elezioni europee appena un 3% del coverage totale, peraltro in riferimento in buona parte alla polemica televisivamente autoriferita del mancato confronto tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, ed Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Porta a porta.
Veniamo con questo alla seconda promessa, al secondo interrogativo che ogni appuntamento elettorale porta con sé: come riavvicinare i mondi, sempre più distanti, della politica – e della comunicazione mainstream – da un lato, e dei giovani dall’altro? Si tratta di un interrogativo particolarmente rilevante, perché chiama in causa tanto i canali quanto i contenuti della comunicazione politica ed elettorale, due dimensioni che inevitabilmente si intersecano.
La stessa analisi sopra riportata evidenzia come siano i produttori di informazione social-media based a portare l’attenzione su contenuti più in linea con le agende dei giovani elettori. Stiamo parlando di realtà come Will Media e Factanza, che operano al di fuori del più tradizionale campo giornalistico e politico, in quel territorio che autorevoli esperienze internazionali identificano come un luogo possibile per la costruzione di un accesso all’informazione politica da parte delle giovani generazioni. In questi ambienti, non solo il tema delle elezioni europee in quanto tale occupa uno spazio di tutto rispetto (27% nell’agenda di Factanza delle prime due settimane di campagna), ma viene declinato secondo modalità innovative, che rimandano alle più tradizionali interviste ai leader attraverso pillole in forma di reel, in grado sì di funzionare da “gancio” ma anche di comporre un piccolo mosaico informativo tutto sommato coerente anche nella “sola” dimensione della forma breve audiovisiva, oppure che giocano la carta dell’engagement della propria community attraverso la funzione di sondaggio che ormai risulta più che tipica delle affordances delle piattaforme più “giovani” (Instagram e TikTok).
Ancor più importante, è solo in questi nuovi spazi di informazione che si trova un riferimento ai temi percepiti come rilevanti da quello che dovrebbe essere un target privilegiato della comunicazione politica, e neppure in modo esaustivo. Le ragazze e i ragazzi del mensile indipendente Scomodo ci consegnano, con il numero 55 della rivista, almeno due messaggi importanti in questo senso. Il primo riguarda “Paure e speranze” degli under 35 oggetto dell’innovativa ricerca sui Nuovi Europei presentata il 14 maggio alla Sala stampa estera a Palazzo Grazioli. Ambiente e cambiamento climatico, aumento dei prezzi, salute mentale: sono queste le questioni che preoccupano, con percentuali che in altro contesto si definirebbero bulgare, i giovani. Come anticipato, anche indirizzando la propria attenzione alle nuove piattaforme di informazione, che nell’auspicio degli osservatori possono rappresentare le nuove fonti di orientamento all’azione politica, questi temi risuonano solo in parte. L’agenda di Will tratta di lavoro per l’11% del coverage delle prime due settimane di campagna, di ambiente per l’8%, si salute e diritti rispettivamente per il 5% e il 6%. Restano fuori tematiche sensibili, che non a caso trovano rappresentanza/rappresentazione nel più “sensibile” comparto delle fiction, e per quella via tornano al mondo dell’informazione, senza avere in esso reale cittadinanza – salvo, appunto, che in occasioni di auto-riflessione come quella operata da Scomodo.
E la politica? L’impressione generale è ancora quella di un’attenzione focalizzata sul canale e le sue caratteristiche e potenzialità, alla quale non corrisponde una sufficiente attenzione al contenuto da veicolare tramite di esso. Ne sono dimostrazione quelli che possiamo considerare il top e il flop di questa campagna, il siparietto tra Meloni e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e i post “Ignoralo” dedicati dal Partito democratico a Roberto Vannacci, candidato della Lega. Da un lato, un caso di “inciviltà politica” come risorsa strategica, direbbero Sara Bentivegna e Rossella Rega, che ha il vantaggio di rappresentare perfettamente quella “appiccicosità” che caratterizza le fonti algoritmiche sin dai primi tentativi di ridefinire l’agenda dei pubblici operati da Buzzfeed alla metà degli anni Duemila. Un’espressione così efficace da porsi come veicolo di diversi tipi di contenuto, o forse proprio di liberarsi del tutto di questo fardello, consegnando alle cronache un gesto iconico valido per sé stesso, ma che se dobbiamo collocarlo in un’agenda politica non può che far riferimento alle buone vecchie polemiche tra esponenti politici, fatte per infiammare gli animi degli aficionados più che degli early adopters della politica. I quali, d’altro canto, non possono rimanere affascinati neppure dal preminente contenuto della campagna del Partito democratico, che richiama l’unfitness to rule che per l’intera Seconda repubblica ha costituito una carta giocata, peraltro con scarso effetto, nei confronti di Silvio Berlusconi, dimenticando in generale la regola lakoffiana del “Non pensare all’elefante” – ossia non costruire la tua offerta politica per contra rispetto a quella del tuo avversario, e in ogni caso non mettere lui o lei al centro della scena. E nel caso particolare la capacità dell’ambiente social di rendere virale (anche detto “appiccicoso”) un contenuto per caratteristiche anche molto lontane da quelle che hanno animato le intenzioni di chi l’ha prodotto – da qui il cortocircuito della visibilità concessa all’“elefante” attraverso un post che intendeva invitare a ignorarlo.
Quel che resta di questa campagna sono, dunque, esperimenti più o meno riusciti sul piano della comprensione delle logiche di circolazione che reggono le piattaforme, che però rischiano di mancare il bersaglio più importante in questo momento: attirare l’attenzione di coloro i quali quelle piattaforme le abitano. Quei giovani che si spera esercitino il proprio diritto/dovere e si rechino alle urne in quelle più che ottimistiche percentuali che ogni fonte, da Eurobarometro a Scomodo, certifica, ma i cui interessi restano tutto sommato lontani dalle forme, per quanto social, di politique politicienne, e dunque dai flussi di comunicazione politica, anche quelli via social.