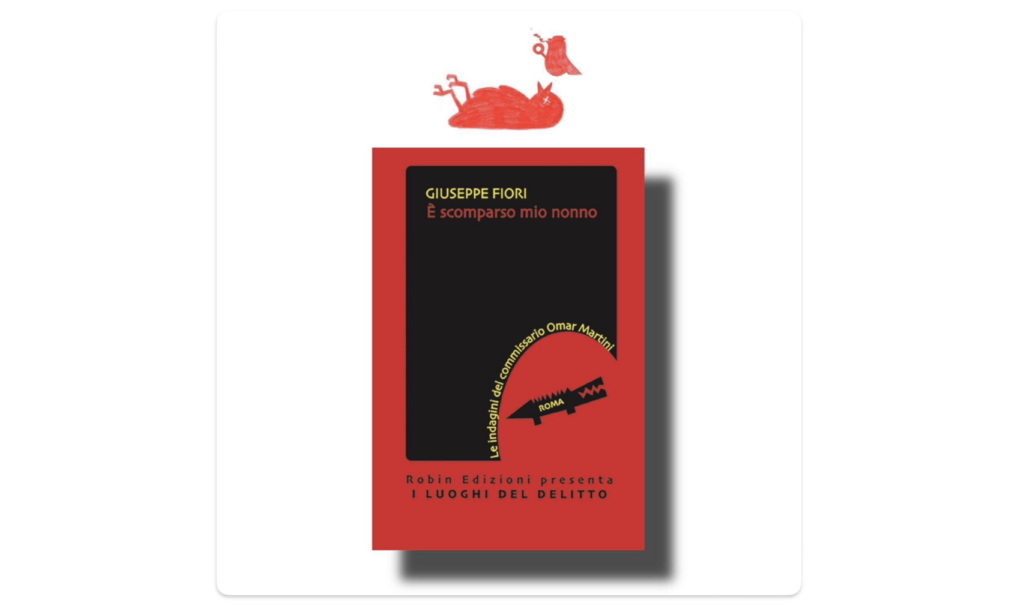L’esperienza lacerante della Grande Guerra (G. Ungaretti), l’invadenza della macchina (L. Pirandello), il pericolo di un nuovo e, stavolta, atomico conflitto mondiale ( G. Galasso), riscoprire il valore del silenzio (N. Polla-Mattiot) e accettare l’imperfezione (R. Levi Montalcini). Una prova di italiano scritto a portata di tutti
La spiazzante lirica di Giuseppe Ungaretti, Pellegrinaggio, con i suoi “versicoli” (così li ribattezzò felicemente Giovanni Raboni), privi di punteggiatura, autentiche inquadrature in dettaglio alla G.W. Pabst (“carcassa”, “fango”, “suola”, “seme”), in montaggio stretto, che ti colpiscono come lame di luce, schizzi abbaglianti, con un finale alla Guillaume Apollinaire (suo amico del cuore), “Un riflettore/di là/mette un mare/nella nebbia”, innegabile apertura all’ermetismo, chissà quali interpretazioni riceveranno sul foglio bianco dei nostri diciottenni, cento anni dopo. Saggiamente, i redattori delle tracce ministeriali, oltre a chiedere l’analisi testuale, suggeriscono dei collegamenti comparativi con altri testi dell’autore e/o altre opere in tutti i campi dell’arte. Chissà se qualcuno su quel «riflettore» non ci metterà le terribili sequenze, anche lì con la nebbia e razzi notturni, di Uomini contro (1970) di Francesco Rosi tratto da Un anno sull’altipiano (1938, pubblicato in Francia, per via del fascismo) di Emilio Lussu?
Per quanto i docenti, nel trattare Luigi Pirandello, si soffermino sul teatro (Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore, I giganti della montagna, L’uomo dal fiore in bocca) e sulle novelle (Il treno ha fischiato), e sul notissimo romanzo Il fu Mattia Pascal, trascurano un altro romanzo capolavoro: Si gira… (1915, pubblicato a puntate su “Nuova Antologia”; poi, in volume, con il titolo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 1925). Il Serafino è, a livello mondiale, il primo romanzo di “narrativa cinematografica” (avrebbe detto il fine linguista e storico del cinema Sergio Raffaelli) interessato a trattare il tema del dominio della macchina sull’anima (qui la cinepresa che duplicando la vita nella finzione la divora). Un tema caro ai giovani che consente collegamenti da Metropolis (1927) di Fritz Lang sino a mondo irreale della I.A.
Nel significativo passaggio tratto da Storia d’Europa (1998) Giuseppe Galasso, dopo essersi soffermato sul concetto di “guerra fredda”, una sorta di pace obbligata a partire dal 1945, confezionata con il fine di evitare un terzo conflitto mondiale, chiosa come siamo ormai schiavi delle nostre invenzioni (un aggancio con Pirandello!), soprattutto nel settore degli armamenti, inclusa l’atomica. Lo studioso sottolinea l’eventualità che un leader-dittatore, o un governo poco responsabile, o una opinione pubblica pressata o che pressa, possa far uno sconsiderato uso della atomica. Chiunque vincesse nell’ultimo conflitto a colpi di atomiche, erediterebbe, aggiungiamo noi, un pianeta devastato. Auguri. Per questo da anni la maggioranza degli Stati sta adottando la politica del disarmo atomico, invocata tra l’altro da tutti i Pontefici, ma da molti Paesi aggirata. Un tema, purtroppo attualissimo, che i giovani possono trattare con cognizione di causa visto il continuo dibattito tra leader, alcuni dei quali in preda a toni sovente minacciosi (Russia, Corea del Nord, Iran): affermazioni pesanti in un tempo di guerre in atto. La traccia, tra l’altro, chiede ai giovani: «è sufficiente l’equilibrio del terrore» per garantire la pace?
Nella proposta B2, tramite un passaggio di un suo articolo-saggio, Maria Agostina Cabiddu ci invita a riflettere sulla salvaguardia della bellezza del nostro patrimonio naturale, artistico e culturale. Ella ci rammenta che non solo Enti (Italia Nostra, Fai, Touring Club) lo difendono, ma anche semplici cittadini hanno testimoniato, negli anni, tramite azioni di volontariato, un senso civico per la cura della bellezza del nostro habitat. Avvincente anche il tema (B3) su “Riscoprire il silenzio”, tratto da un saggio di Nicoletta Polla-Mattiot. Il candidato è chiamato a riflettere sulla differenza di una comunicazione a senso unico, in cui abbiamo un parlante “logorroico”, “autoreferenziale”, che lascia poco spazio a chi gli è di fronte, e una reale conversazione, in cui si attiva uno scambio adottando il “turno linguistico”, direbbero i linguisti allievi di Roman Jakobson. La pausa orale non è necessaria solo dal punto di vista fonico-linguistico ma anche mentale: il silenzio verbale aiuta il pensiero. Insomma “si parla a turno e si tace a turno”.
Rita Levi Montalcini, nel volume Elogio dell’imperfezione (2017), ribaltando l’opzione del grande poeta W. B. Yeats “Perfection of the life, or of the work” sostiene, dopo una lunga carriera e anni di lavoro in équipe con giovani di diverse generazioni, come sia importante la imperfezione nel lavoro e nella vita. Ossia, è attraverso le sconfitte, gli errori, i vuoti, che si arriva al risultato. Dunque, viva l’imperfezione, con il plauso di molti maturandi.
Infine, chi volesse soffermarsi su un argomento più filosofico ecco il tema del “diario”, quella riservata e delicata confessione che, nell’era dei social è scomparsa, per far posto ai sentimenti gridati. Nell’era del digitale in diretta, riflette Maurizio Caminito (Profili, selfie e blog, articolo, 2014), il diario alla Anna Frank, in cui l’autrice scopriva sé stessa gradualmente, con timori e pudori, è considerato sentimentalismo. Oggi, tramite i social, si afferma la mitizzazione del sé da esibire agli altri. Ogni minima azione o sentimento vanno gridati e mostrati ostensivamente, per ottenere uno sparuto consenso sul web. Il segreto interiore, le riflessioni, le esitazioni, il recondito percorso di formazione affidato alla scrittura privata, caro a Petrarca, a Marcel Proust, a Franz Kafka a Katherine Mansfield, è uno sbiadito ricordo.